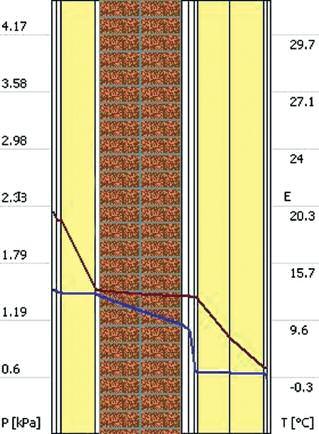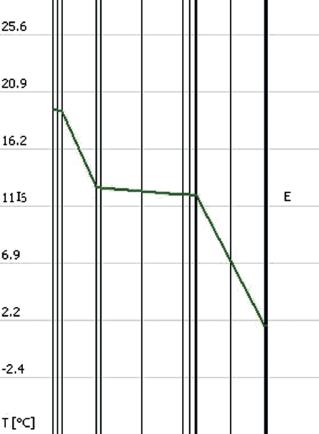RAFFRESCAMENTO PASSIVO








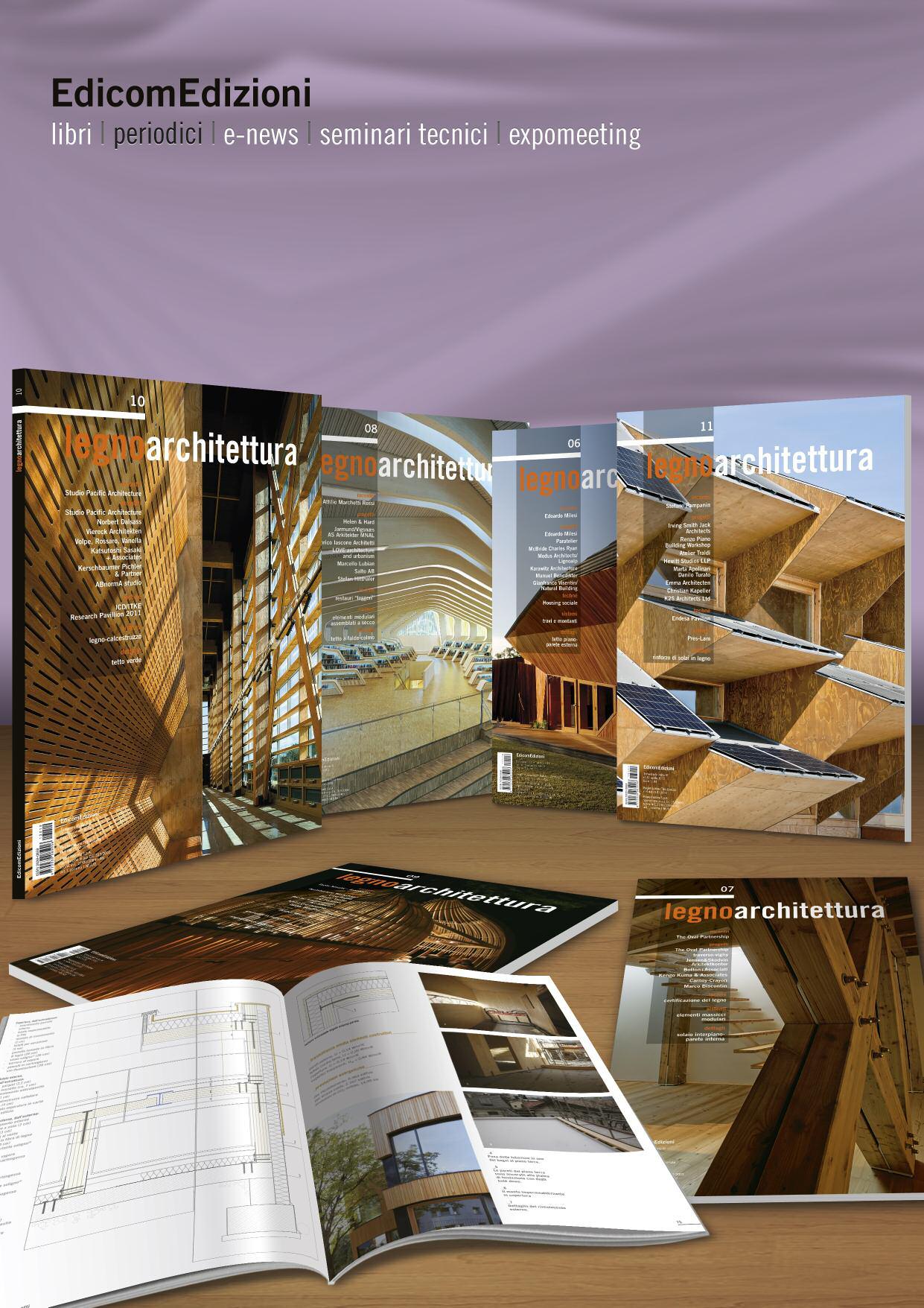
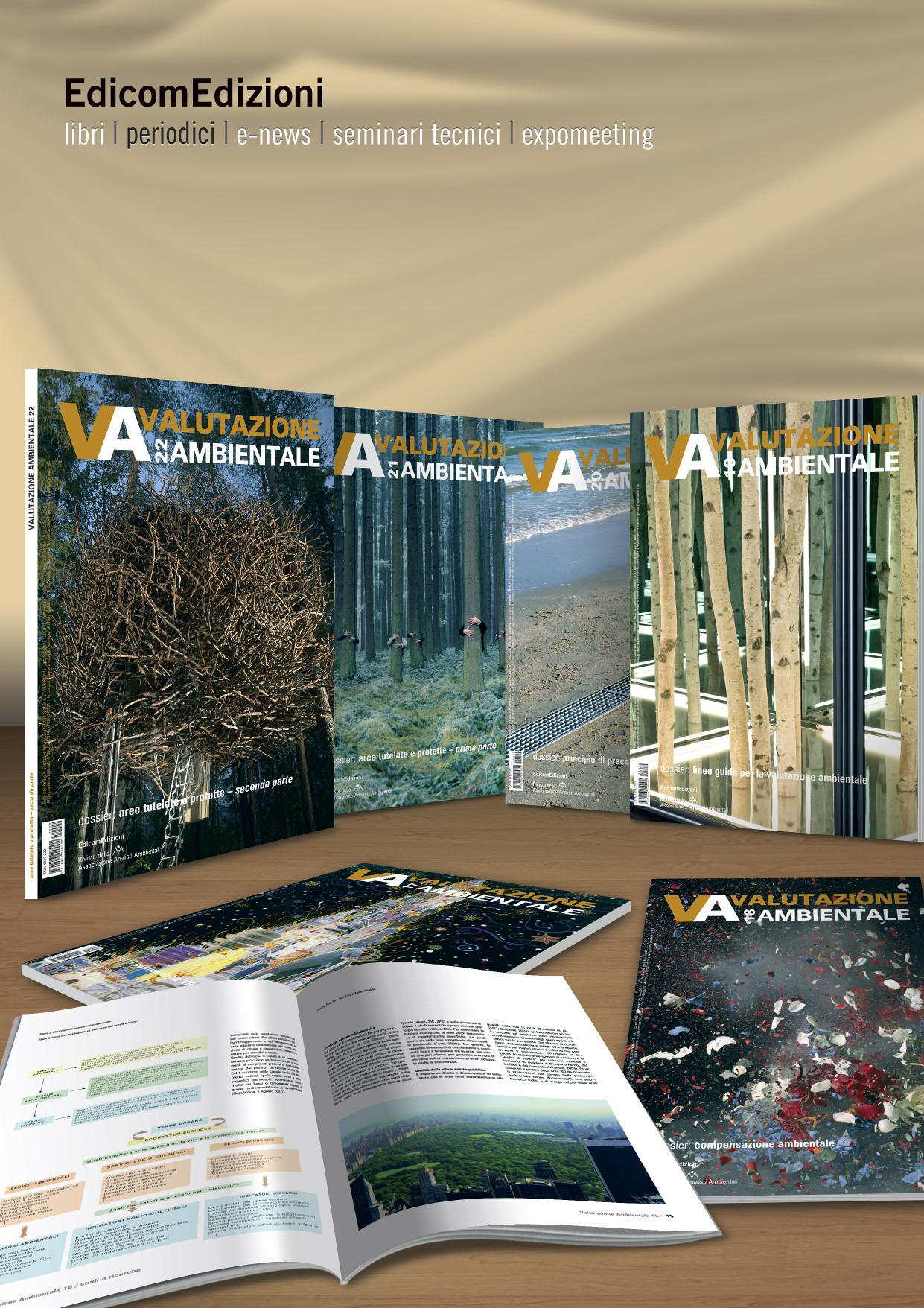
EdicomEdizioni




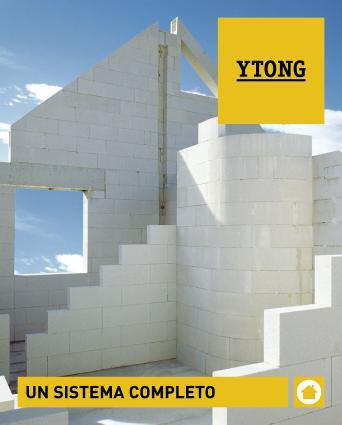


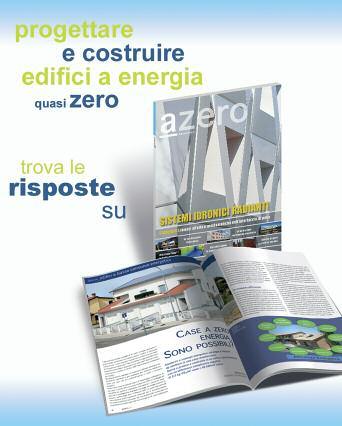


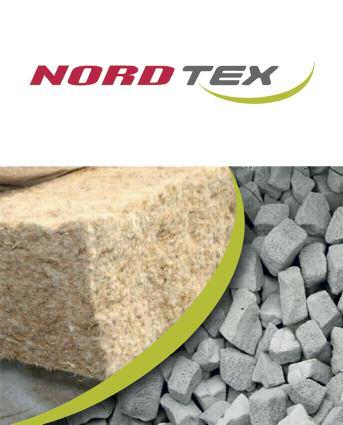






IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 63/2013 a cura della Redazione SPOT PROGETTI
INTERVISTA A OLIVER RAPF
UN HOTEL IN STANDARD PASSIVO albergo e ristorante a Scandiano (RE)
SOTTO UN UNICO TETTO abitazione e residence a Terlano (BZ)
UN MANIFESTO PER UN FUTURO MAGGIORMENTE SOSTENIBILE centro ricerca, Vancouver (CAN)
UN’INFANZIA... PASSIVA complesso per l’infanzia, Maria Enzersdorf (A)



azero - rivista trimestrale - anno 3 - n 08, luglio 2013
Registrazione Tribunale Gorizia n 03/2011 del 29 7 2011
Numero di iscrizione al ROC: 8147
ISSN 2239-9445
direttore responsabile: Ferdinando Gottard
redazione: Lara Bassi, Lara Gariup, Gaia Bollini
editore: EdicomEdizioni, Monfalcone (GO)
redazione e amministrazione: via 1° Maggio 117, 34074 Monfalcone (GO) tel 0481 484488, fax 0481 485721
stampa: Grafiche Manzanesi, Manzano (UD) Stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate prezzo di copertina 15,00 euro - abbonamento 4 numeri - Italia: 50,00 euro, Estero: 100,00 euro Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno distribuzione in libreria: Joo Distribuzione, Via F Argelati 35 – Milano È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore
copertina: CIRS a Vancouver, foto: Martin Tessler / courtesy: Perkins+Will



IL
Mario Grosso
COLORE
SUL
Fausto Barbolini, Luca Guardigli

MICROGENERAZIONE
Giacomo Cassinelli
MICROGENERAZIONE


DETTAGLI DI CANTIERE: VILLA DINA
a cura della Redazione
Il recepimento della Direttiva 2010/31/UE
Le novità introdotte
dal D.L. 63/2013
A quasi un anno dalla scadenza imposta dall’Unione Europea, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 2010/31/UE che introduce il concetto di edifici a energia quasi zero. Un breve excursus sulle novità del D.L. 63 del 4 giugno 2013 in attesa della sua conversione in Legge.
A quasi un anno dalla data fissata dall’Unione Europea (9 luglio 2012), l’Italia ha recepito la Direttiva 2010/31/UE1 attraverso il D L 4 giugno 2013, n 632, ponendo fine ad alcune procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese a seguito di una non corretta applicazione della Direttiva 2002/91 UE Un’analisi esaustiva del Decreto si potrà effettuare solamente dopo la conversione in legge del provvedimento, prevista entro il mese di agosto; tuttavia, riteniamo utile mettere in evidenza alcune parti e formulare alcune considerazioni sugli aspetti salienti del Decreto Legge che interviene drasticamente sul D Lgs 192/2005 Esso abroga e introduce nuovi commi, riformulando ex novo e/o integrando i seguenti articoli: 1 (Finalità), 2 (Definizioni), 3 (Ambito di intervento), 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica), 6 (Certificazione energetica degli edifici), 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva), 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali), 11 (Norme transitorie), 13 (Misure di accompagnamento), 14 (Copertura finanziaria), 15 (Sanzioni), 16 (Abrogazioni e disposizioni finali)
Nel frattempo, in attesa di nuovi documenti attuativi, rimane ancora in vigore il D P R 59/2009, che mantiene inalterati aspetti applicativi e pratici
Definizioni e metodologia di calcolo
Il Decreto modifica l’art 2 del D Lgs 192/2005 a partire dalle definizioni legate all’edificio e ai possibili interventi eseguibili sullo stesso Riportiamo di seguito alcune definizioni significative
• Edificio a energia quasi zero3: “edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1 Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ)”
• Edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica p rog ettu a le, d ia g n osi, o a ltra va lu ta zion e en erg etica 4: “edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei
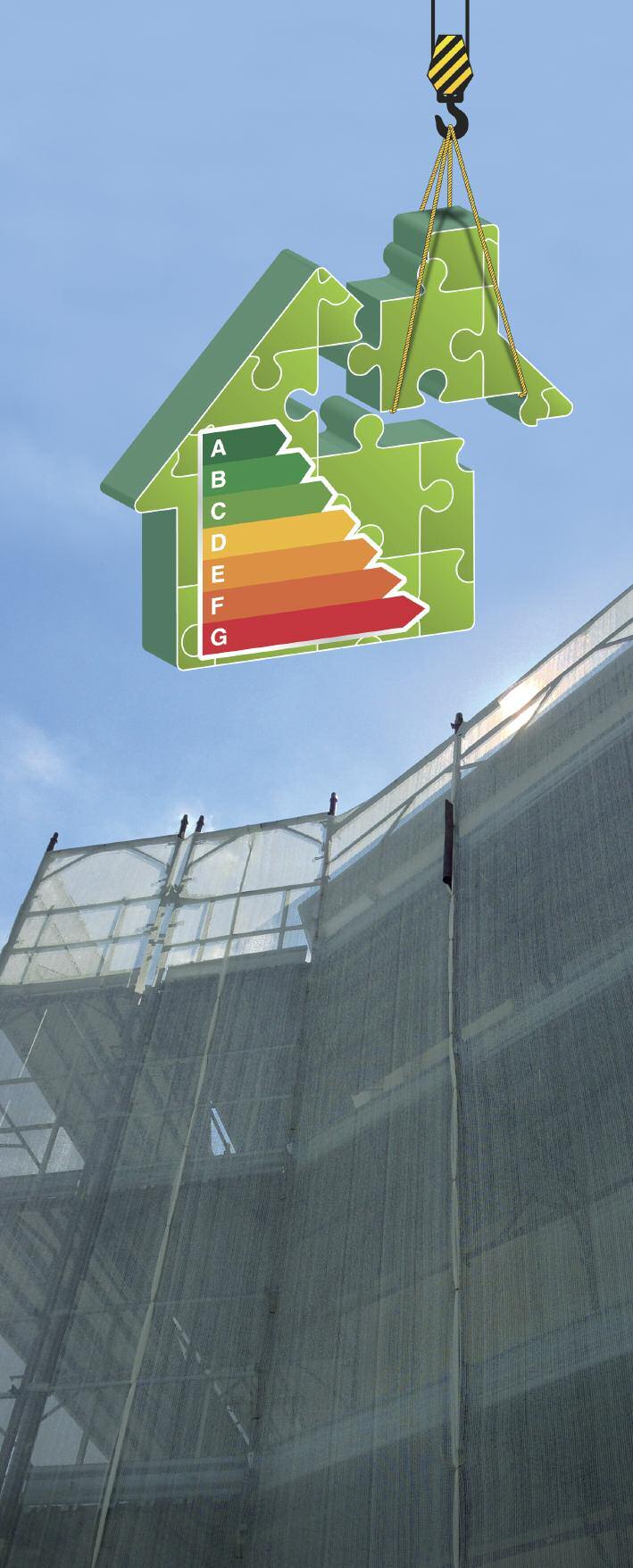
componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati“
• Riqualificazione energetica di un edificio5: “un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis”
• Ristrutturazione importante di un edificio6: “un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture”
Per quanto riguarda la metodologia a livello nazionale, si adotta un sistema di calcolo della prestazione energetica che tiene conto delle caratteristiche termiche dell’involucro, degli impianti di climatizzazione (invernali ed estivi), di produzione di acqua calda e di ventilazione (per il settore terziario anche l’illuminazione), specificando che, in attesa dell’aggiornamento delle relative norme europee, si fa riferimento alla metodologia contenuta nelle norme UNI/TS 11300, parti da 1 a 4, e alla raccomandazione CTI 14/2013 (norme che saranno il riferimento anche in caso di recepimento da parte delle regioni o delle Province Autonome)
Il fabbisogno energetico annuale globale viene dunque calcolato per ogni singolo servizio energetico su base mensile ed espresso in energia primaria, modalità queste che si applicano altresì all’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine di sistema, e si ottiene operando “ la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; ai fini della compensazione , è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata, ”7
I decreti attuativi successivi andranno a stabilire e fissare prescrizioni e requisiti minimi inerenti le prestazioni energetiche degli edifici, distinte secondo interventi di nuova costruzione, ristrutturazione importante e riqualificazione energetica; i requisiti minimi di prestazione energetica – tali da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi – saranno rivisti ogni 5 anni Edifici, che ricadono nella disciplina prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42), dovranno comunque attestare la prestazione ener-
getica, rispettando le norme di esercizio e di manutenzione e ispezione degli impianti Tali requisiti inoltre dovranno rispettare valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi dei costi/benefici del ciclo di vita degli edifici
Un Piano nazionale sarà redatto, entro il 31 dicembre 2014, per incrementare il numero degli edifici a energia zero attraverso obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli stessi e mediante misure finanziarie o di altro tipo da individuare entro il 30 aprile 2014
Attestato di prestazione energetica e attestato di qualificazione energetica
L’Attestato di Certificazione Energetica diventa Attestato di Prestazione Energetica e viene rilasciato da esperti qualificati e indipendenti a:
- edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione importante (al termine dei lavori);
- edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o dati in locazione a un nuovo locatario;
- edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico (con superficie utile totale superiore a 500 m2; a partire dal 9 luglio 2015 questa superficie viene ridotta a 250 m2) Nel caso di edifici con più unità immobiliari, l’attestazione può riferirsi a una o a più unità; se riferita a più unità, queste devono avere la stessa destinazione d’uso, essere servite dallo stesso impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, se presente, anche dal medesimo sistema di climatizzazione estiva
L’attestato ha una validità temporale di 10 anni dalla data del rilascio e viene aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione e di riqualificazione che modifica la classe energetica dell’edificio o dell’unità La validità è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di controllo e di ispezione di efficienza energetica degli impianti termici, pena la decadenza dell’Attestato stesso.
Per i nuovi edifici, l’Attestato di Prestazione Energetica viene prodotto a cura del costruttore, sia esso committente o società di costruzione che opera direttamente, mentre nel caso di edifici esistenti è il proprietario che presenta l’attestato Quando si vende o si dà in nuova locazione edifici o unità immobiliari, se non già dotati, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato “ al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime”8 Nel caso delle vendite e delle locazioni, gli annunci immobiliari devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
L’Attestato di Prestazione Energetica non certificherà solamente la prestazione energetica dell’edificio, come avveniva con l’Attestato di Certificazione Energetica, ma indicherà anche una serie di raccomandazioni per la futura vita energetica dell’edificio
L’Attestato di qualificazione energetica, predisposto da un professionista abilitato, è invece facoltativo ed è pensato al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica; proprio per questo esso “ comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi”9
Un successivo decreto adeguerà il D M 26 giugno 2009 secondo i seguenti criteri e contenuti:
- prevedere metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni e con prestazioni energetiche di modesta qualità;
- definire un attestato di prestazione energetica che comprenda tutti i dati relativi all’edificio “Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, ;
2) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l’energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ”10
L’attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
I pannelli fotovoltaici
installati sulla copertura dell’Habitat Lab di Saint-Gobain a Corsico (MI).

Sanzioni
Al fine di raggiungere gli obiettivi e di far rispettare quanto previsto, sono state previste numerose sanzioni, in particolare per le seguenti figure professionali
• Professionista qualificato: rilascia la relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento di consumo di energia Se la relazione è compilata senza rispetto degli schemi e delle modalità stabilite dal decreto, il professionista viene punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 000 Euro e non superiore a 6 000 Euro Inoltre, l’ente locale e la regione provvedono a darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
• Direttore dei lavori: se omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 000 Euro e non superiore a 6 000 Euro Il comune comunica all’ordine o al collegio professionale competente la sanzione per i provvedimenti disciplinari
• P rop rieta rio o con d u ttore d ell’u n ità im m ob ilia re, a m m in istratore del condominio o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità: se non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3 000 Euro
• O p era tore in ca rica to d el con trollo e m a n u ten zion e: se non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 000 Euro e non superiore a 6 000 Euro L’ente locale, o la regione, ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti
Per i mancati adempimenti, il D.L. prevede:
- sanzione amministrativa non inferiore a 3 000 Euro e non superiore a 18 000 Euro per il costruttore o il proprietario di edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti per violazione dell’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica;
- sanzione amministrativa non inferiore a 3 000 Euro e non superiore a 18 000 Euro per il proprietario che viola l’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita;
- sanzione amministrativa non inferiore a 300 Euro e non superiore a 1 800 Euro per il proprietario che viola l’obbligo di dotare dell’attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari in caso di vendita;
- sanzione amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3 000 Euro per il responsabile dell’annuncio che viola l’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione
Note
1 - Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the Energy Performance of Buildings
2 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
3 - Art 2, comma 1, lettera l-octies)
4 - Art 2, comma 1, lettera l-novies)
5 - Art 2, comma 1, lettera l-vicies ter)
6 - Art 2, comma 1, lettera l-vicies quater)
7 - Art 4, comma 1, lettera a), punto 3) e 4)
8 - Art 6, comma 2
9 - Art 6, comma 11
10 - Art 6, comma 12, lettera b)









01. La prima casa certificata con il nuovo sistema MinergieA-Eco si trova a pochi km da Berna Isolata con fiocchi di cellulosa e rivestita internamente con pannelli in argilla e intonaco dello stesso materiale, l’edificio ha collettori solari sul tetto per l’ACS, un impianto fotovoltaico connesso in rete che fornisce energia anche per l’impianto di VMC con recupero di calore e la predisposizione per l’allacciamento a un mini impianto eolico. Per i mesi più freddi è previsto l’intervento di un stufa a pellet www aab-architekten ch
02. Inserito in un programma urbanistico più vasto che comprende la realizzazione di 5 000 appartamenti, il complesso di Bruyn Ovest a Bruxelles accoglie 79 alloggi a uso sociale. L’accurata scelta dei materiali, la cura dei dettagli e una VMC a doppio flusso garantiscono un consumo di 12 kWh/m2a Pannelli solari in copertura producono l’acqua calda sanitaria mentre quella piovana viene raccolta in cinque cisterne per essere riutilizzata nell’edificio www.pblondel.be
03. Lo standard passivhaus (10 kWh/m2a per riscaldamento) del nuovo edificio della facoltà di Antropologia dell’Università J. Gutenberg di Magonza (D), progettato dallo studio Bernhardt+Partner (arch Andreas Hammer), è stato raggiunto anche grazie alla presenza di scambiatori di calore altamente efficienti La successiva installazione di un impianto FV permetterà all’edificio di raggiungere anche il nuovo standard europeo “Net Zero Energy Building” www bp-da de
04. Il più grande edificio passivo per uffici austriaco, progettato da AllesWirdGut e feld72, si trova a Krems e raggruppa diversi uffici pubblici in un unico luogo nel centro cittadino La forma compatta suddivisa in 3 volumi, l’attenzione all’involucro e un’impiantistica performante consentono un consumo per riscaldamento inferiore ai 10 kWh/m2a L’utilizzo di ecocemento ha permesso di evitare più di 1 000 tonnellate di emissioni di CO2 www.alleswirdgut.cc; www.feld72.at
05. Un fabbricato in pietra, reso pericolante dai dissesti strutturali causati dal sisma dell'Aquila del 2009 è stato oggetto di una demolizione e ricostruzione in chiave innovativa ed ecosostenibile Le tracce murarie perimetrali conservate diventano la base di supporto per un edificio scatolare di due piani realizzato in X-lam, dove la coibentazione e le tecnologie a basso impatto ambientale consentono di raggiungere un bilancio CO2 positivo con una prestazione energetica di 6 kWh/m2a (CasaClima Gold in fase di certificazione) Progetto ing Pierluigi Bonomo
06. È realizzata con balle di paglia e intonaco in calce idraulica naturale questa casa a San Donà di Piave (VE) che sarà certificata CasaClima Gold (9 kWh/m2a) dopo l’installazione anche di un impianto di ventilazione meccanica controllata Grande attenzione è stata prestata alla tenuta all’aria dell’involucro, alla sigillatura delle tubazioni e delle canalizzazioni impiantistiche, dei serramenti e degli attacchi tra gli elementi costruttivi (progetto: geom Sandro Sforzin)

INTERVISTA A OLIVER RAPF
CON LO STUDIO “GLI EDIFICI EUROPEI SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO” IL BPIE ANALIZZA PER LA PRIMA VOLTA LA SITUAZIONE DELL’INTERO PATRIMONIO IMMOBILIARE EUROPEO. QUALI SONO STATI I DATI PIÙ DIFFICILI DA RACCOGLIERE?
I dati più difficili da raccogliere sono stati quelli relativi agli edifici commerciali, alla definizione del profilo dei proprietari di edifici non residenziali, i dati di utilizzo dell’energia per tipo di edificio e utilizzo finale, i tassi di ristrutturazione in generale Ci sono anche pochissime informazioni sugli interventi di risanamento energetico, ad esempio il numero totale e la tipologia di interventi e i costi che questi comportano a livello di singolo Stato Membro
A SUO PARERE, CI SONO DELLE POSSIBILITÀ DI RACCOGLIERE QUESTI DATI IN UN LASSO DI TEMPO RAGIONEVOLE?
È indispensabile che i governi europei comprendano che possedere dati dettagliati e affidabili è un prerequisito per sviluppare e attuare politiche e programmi in grado di migliorare significativamente le prestazioni energetiche degli edifici Noi stiamo supportando la raccolta dati grazie al BPIE data hub,
Il direttore esecutivo dell’Istituto Europeo per la performance degli edifici (BPIE) illustra i risultati dello studio effettuato sugli edifici in Europa e le prospettive dell’isolamento termico e del risanamento energetico. Rapf ha lavorato a lungo nel WWF ricoprendo, tra gli altri, i ruoli di capo dell’unità internazionale “Climate Business Engagement” e vice capo delle unità “European Climate Change” e Politica Energetica Europea.
online dall’autunno 2012 Grazie a questo portale potremo selezionare singoli set di dati e comparare, ad esempio, il consumo energetico di case unifamiliari in Germania e Austria Tutti i dati saranno presentati in maniera trasparente e ne verranno citate le fonti Se i dati saranno stime o previsioni, questo verrà segnalato nel database Uno degli obiettivi di questo strumento è anche mostrare ciò che non sappiamo, in modo da spingere i responsabili in tutta Europa a colmare questa lacuna.
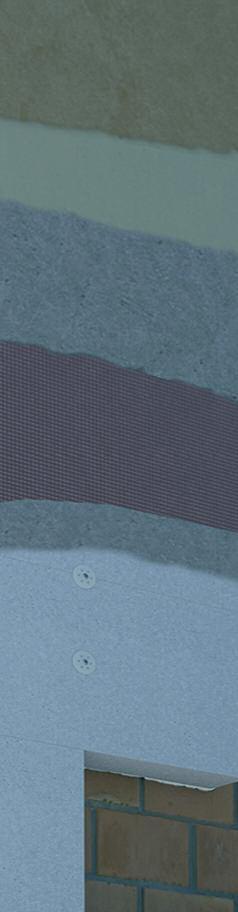
L’intervista a Oliver Rapf è pubblicata in inglese nella “European Energy Saving Guide 2013” di EAE - European Association for ETICS di cui Cortexa, che ne ha curato la traduzione in italiano, è socio fondatore
Contiamo sulla collaborazione di altri istituti e autorità per riuscire a raccogliere nel tempo informazioni migliori
QUALE ÈL’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL VOSTRO DATA HUB?
Vogliamo rendere i dati del settore costruzioni molto più trasparenti e lavorare per una armonizzazione dei dati disponibili a livello europeo
L’Europa ha definito degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici, tutti gli Stati Membri dovranno contribuire al raggiungimento di tali obiettivi Se non siamo in grado di misurare con esattezza il contributo e il potenziale dei vari Stati, avremo un grande problema Diversi standard e metodi di misurazione per la performance degli edifici rappresentano forti barriere commerciali, anche se abbiamo un mercato del lavoro comune a livello europeo. Vi faccio un esempio per il settore delle costruzioni: se un’impresa tedesca vuole restaurare un edificio in Belgio, deve conoscere in maniera molto approfondita le leggi e gli standard locali, che sono molto diversi da quelli tedeschi
GUARDANDO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE EUROPEO, QUALI AREE DI AZIONE
URGENTI SONO STATE IDENTIFICATE GRAZIE AL VOSTRO STUDIO?
Oltre all’organizzazione di un metodo di raccolta dati e di monitoraggio sistematici, raccomandiamo di sviluppare piani d’azione nazionali sul risanamento energetico e di creare nuovi incentivi finanziari in grado di stimolare un numero maggiore di interventi in tutta Europa
Il problema dei finanziamenti oggi è uno dei maggiori ostacoli agli interventi di efficientamento energetico La crisi economicofinanziaria in corso rende l’accesso alle risorse pubbliche ancora più difficile, per questo motivo servono meccanismi innovativi per il finanziamento in grado di spingere gli investimenti privati nei progetti di risanamento energetico
Sul lato dell’applicazione delle politiche dovrebbe essere posta maggiore attenzione alla creazione di sistemi di monitoraggio efficaci, per garantire che vengano rispettate norme e standard anche nell’esecuzione dei lavori Infine, non sarà possibile ottenere una vera qualità senza formare ed educare la forza lavoro del settore delle costruzioni, che gioca un ruolo fondamentale nell’esecuzione di interventi di risanamento energetico
PAROLA CHIAVE “FINANZIAMENTI”: A SUO PARERE COME È POSSIBILE
RIDURRE LE BARRIERE FINANZIARIE PER OTTENERE UN AUMENTO DEGLI
INTERVENTI DI RISANAMENTO ENERGETICO?
Oggi gli investitori istituzionali hanno veramente poche opportunità di investire in progetti di risanamento energetico Questo tipo di investimenti potrebbero essere attrattivi per investitori con prospettive a lungo termine come i fondi pensione, perché garantiscono ritorni affidabili, a basso rischio e a lungo termine
Per rendere la cosa più interessante, diversi piccoli progetti di risanamento potrebbero essere combinati per creare un progetto di investimento di più ampia portata La cosa importante è che tali strumenti per gli investimenti saranno realizzati tenendo conto delle circostanze locali In questo momento stiamo discutendo con gli investitori in merito a come tali strumenti per gli investimento dovrebbero essere disegnati Il ruolo del governo potrebbe essere quello di assicurare delle garanzie per tali progetti, questo non richiederebbe un investimento ingente e continuo come invece è avvenuto in altri casi
LEI RITIENE CHE L’ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI POTREBBE ESSERE UN ELEMENTO TRAINANTE PER LA CRESCITA ECONOMICA IN EUROPA?
Assolutamente sì! Il know-how tecnico è disponibile così come la forza lavoro, anche se sarà necessario investire in misure di formazione, e ci sono numerosissimi edifici che dovranno essere risanati Questi progetti non solo aiuteranno la ripresa dell’industria delle costruzioni locali e i produttori di materiali da costruzione, ma daranno nuovo lavoro anche al settore della progettazione, all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo
SEMBRA UNA RICETTA PER IL SUCCESSO ANCHE PER GLI STATI MEMBRI PIÙ COLPITI DALLA CRISI
Possiamo guardare alla Spagna: negli ultimi decenni si è costruito in maniera molto rapida ed economica La gran parte di questi edifici nuovi ha un grandissimo potenziale di miglioramento energetico Con l’aiuto di un programma di governo finalizzato a risolvere questo problema, molte persone attualmente disoccupate potrebbero trovare un nuovo lavoro
Le risorse oggi spese per pagare le indennità di disoccupazione potrebbero essere investite in interventi di risanamento energetico Considerando che questo effetto sull’occupazione non sarà solo a breve termine e che questi lavori non potranno essere trasferiti all’estero, questa sarà certamente una storia di successo!
Angelo Silingardi (progetto architettonico definitivo)
Michele De Beni (consulente efficienza energetica)



Sostenibilità, innovazione e design sono parte integrante della filosofia ispiratrice del progetto di questo albergo passivo il cui obiettivo principale è stato quello di fornire ai clienti livelli di comfort superiori alla media con un ridotto consumo energetico
UN HOTEL IN STANDARD PASSIVO
Pensato per soddisfare i requisiti energetici dello standard edifici passivi e per inserirsi armoniosamente nel paesaggio rurale alle pendici delle prime colline appenniniche, l’Hotel
Boiardo è composto da tre nitidi e compatti parallelepipedi, dove la semplicità formale della facciata del grande volume delle camere è rotta solamente dai brise-soleil con elementi ceramici
Due spazi minori, uguali e simmetrici, che si estendono verso est, accolgono la sala conferenze e la sala colazioni con ampie vetrate e pilastri in muratura Il parcheggio e i locali tecnici si trovano nel seminterrato; in fase di progettazione questa parte ha richiesto una maggiore attenzione anche a livello esecutivo alla ricerca delle migliori soluzioni costruttive per isolare termicamente tali spazi dal livello superiore, mitigando al contempo i numerosi ponti termici formati dalla continuità strutturale con il piano superiore riscaldato
La struttura portante è realizzata in c a con tamponamenti in laterizio e isolamento in polistirene espanso additivato con grafite, le partizioni interne sono eseguite con sistemi a secco che
coniugano l’isolamento termico e acustico con la flessibilità in caso di future modifiche degli spazi La copertura prevede una unica orditura di travi (sagomate per i corpi bassi) con dei pannelli in legno lamellare di abete
L’orientamento e le dimensioni delle aperture non ricercano la massimizzazione dei guadagni solari, ma sono piuttosto una conseguenza delle scelte di distribuzione interna degli spazi e della ricerca di scorci visuali Tutte le vetrate sono a doppia camera con distanziali altamente isolanti “warme edge” e opportune schermature
Negli spazi dell’hotel la tecnologia impiantistica è sapientemente celata alla vista degli utilizzatori, pur essendo parte fondamentale del concetto energetico dell’edificio: un sistema a pompa di calore modulare e un sistema di ventilazione meccanico consentono la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di ACS, coadiuvata anche dall’impianto solare termico installato in copertura e da una caldaia a metano che entra in funzione solo nei momenti di massimo carico

Concetto energetico, serramenti e schermature
Progettare un edificio a uso terziario ad alta prestazione energetica significa prestare particolare attenzione agli elementi che ne delimitano gli spazi (pareti, infissi, copertura) e all’utilizzo degli spazi stessi, in quanto questi edifici si differenziano, rispetto ai fabbricati residenziali, per la discontinuità d’uso, per i requisiti di sicurezza in caso di incendio o emergenza e per le dimensioni Quest’ultimo punto, insieme alla compattezza volumetrica, determina il buon rapporto S/V complessivo (l’Hotel Boiardo ha un rapporto S/V pari a 0,37 m2/m3), fattore che consente di raggiungere buoni valori di indice di calore utile con spessori di isolamento non esagerati Il concetto energetico sviluppato nel progetto ha estremizzato sia la compattezza sia l’isolamento, in quanto l’obiettivo era mantenere e trattenere nell’edificio, durante la stagione invernale, tutti i guadagni di calore gratuiti interni, notevoli in una struttura come questa (valori attorno ai 4 W/m2) vista la molteplicità di apparecchiature elettroniche presenti La minimizzazione delle perdite per conduzione dell’involucro ha lasciato spazio a una maggior libertà compositiva tradottasi in aperture che sono frutto della distribuzione degli spazi interni e degli scorci visuali verso le colline, slegate nell’orientamento e nelle dimensioni dalla massimizzazione degli apporti solari Attenzione particolare è stata posta alla progettazione, e alla successiva esecuzione, delle schermature e alle prestazioni energetiche delle vetrate.
Gli infissi (finestre e porte finestre certificate Passivhaus) dei volumi climatizzati rispettano i limiti dello standard passivo (Uw da certificato <0,8 W/m2K) con telai in legno (88 mm) placcati con isolante XPS (a eccezione di quelli del vano scala), rivestiti da un carter in alluminio e di tipo a battente, considerata la garanzia che tali chiusure forniscono in relazione alla tenuta all’aria complessiva dell’involucro I falsi telai sagomati rivestono la parte fissa del telaio con il cappotto esterno e sono stati nastrati sul perimetro Tutte le vetrate sono a doppia camera con valore Ug=0,6 W/m2K (0,5 per le vetrate selettive che si affacciano sulla corte) e distanziale “warme edge” con valore ψ g=0,036 W/mK Il valore medio Uw complessivo delle strutture trasparenti è pari a 0,765 W/m2K
Gli elementi schermanti si adattano all’orientamento delle aperture e alla funzione dei locali da schermare e precisa-
pianta
pianta del piano terra
pianta del piano interrato

Sopra, un particolare del fronte principale dell’albergo, a est, con i frangisole in ceramica.
A destra, una delle camere e, sotto, la sala convegni
sezione AA
sezione BB
mente: le finestre delle camere, prevalentemente a est e a ovest, sono protette da frangisole esterni in ceramica, appositamente realizzati per questo edificio, di colore chiaro così da non penalizzare la disponibilità di luce naturale nei locali interni; un portico ripara le vetrate esposte a sud della sala convegni, consentendo tuttavia efficaci guadagni solari durante l’inverno; le aperture della corte interna (a est, nord e ovest) non dispongono di schermature esterne ma sono dotate di vetrate selettive (Ug=0,5 W/m2K; fattore solare g=33%) La difficoltà maggiore è stata però la scelta delle porte che separano il vano scale, non riscaldato, dal volume delle camere e che dovevano fornire adeguate prestazioni riguardo: resistenza termica (valore Ud), resistenza al fuoco (valore REI) e tenuta all’aria (valore n50) Si sono scelte porte ad anta unica, realizzate con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 e un valore Ud=0,9 W/m2K: nell’impossibilità di avere una soglia inferiore di battuta (per problemi relativi alla sicurezza in caso di fuga) si è optato per un sistema a ghigliottina che, a porta chiusa, assicura una più che accettabile tenuta.
Progetto architettonico definitivo arch. Angelo Silingardi -
Studio CCDP, Reggio Emilia
Consulente (bioarchitettura, acustica, termica) ing. Michele
De Beni, Modena
Impianti elettrici ing Enrico Camellini, Reggio Emilia
Impianti meccanici p.i. Davide Parisi, Bressanone (BZ)
Interior design arch Elisa Annovi, Modena; Simone Cagnazzo, Sassuolo (MO)
Committente Boiardo Costruzioni S.r.l., Scandiano (RE)
Direttore dei lavori ing Michele De Beni, Modena
Appaltatore Impref S.r.l, Reggio Emilia
Superficie fondiaria 8.200 m2
Superficie utile 1 800 m2
Superficie verde 6.500 m2


Solaio verso parcheggio, dall’estradosso:
- pavimentazione in battuto alla veneziana
- massetto cementizio di allettamento
- pannello XPS (12 cm)
- solaio in laterocemento
- pannelli in silicati di calcio (6 cm)
- intonaco
1 calcestruzzo armato
2 battuto in cemento
3 muratura in blocchi
4 intonaco
5 pannello XPS (16 cm)
6 pannello in EPS stampato a celle chiuse (32 cm)
7 pannello in EPS con grafite (5 cm)
8 rasatura calce-cemento
9 materassino in fibra di vetro
10 lastra cartongesso




dettaglio della fondazione verso il parcheggio
Involucro
La struttura portante dell’edificio è realizzata in c a con tamponamenti in laterizio (25 cm), i corpi scala sono interamente in c a con struttura a setti La copertura ha un’unica orditura di travi in pannelli di legno lamellare di abete (10 cm) con isolamento in fibra di legno (24 cm) Una particolare attenzione è stata posta alle prestazioni acustiche delle camere, dotando ognuna di esse di una propria struttura di copertura, eliminando in tal modo qualsiasi possibile ponte acustico tra di esse I divisori interni sono stati realizzati a secco con lastre in cartongesso e isolamento con materassini in lana di vetro e roccia di diverse densità a seconda della collocazione, soluzione usata anche sul lato interno delle pareti esterne, opportunamente rasate al fine di ottenere una superficie liscia ma anche una tenuta all’aria affidabile e continua Un cappotto in EPS additivato con grafite riveste la struttura con uno spessore che varia da un minimo di 20 cm a un massimo di 32 cm in corrispondenza del piano terra; i vani scala, pur non riscaldati, sono stati coibentati con 16 cm di spessore del medesimo materiale. Il solaio di separazione tra il piano terra riscaldato e quello interrato è stato rivestito all’intradosso con pannelli in silicato di calcio (10 cm), come pure tutti i pilastri e i setti del livello interrato, al fine di limitare la dispersione dei flussi di calore provenienti dalle strutture soprastanti All’estradosso è stato invece placcato con pannelli in XPS battentato da 12 cm che sostengono il massetto di allettamento della pavimentazione in battuto alla veneziana Più di 100 pezzi speciali in PUR ad alta densità sono inseriti nell’isolamento per sostenere la struttura degli elementi ombreggianti senza ancorarla direttamente alla struttura portante principale ed evitare così i ponti termici
A sinistra, in alto: il giunto sul piazzale antistante l’albergo. Sotto, immagini della coibentazione esterna con lo zoccolo in EPS e i due tipi di isolante.




Stratigrafia solaio verso parcheggio, dall’estradosso: - pavimentazione in battuto alla veneziana - massetto cementizio di allettamento
- materassino fonoisolante in EPS elastico - massetto cementizio
- pannello XPS
- solaio in latero-cemento
- pannelli in silicati di calcio (6 cm)
- intonaco
Stratigrafia solaio interpiano, dall’estradosso:
- pavimentazione in legno di rovere
- massetto cementizio di allettamento
- materassino fonoisolante in EPS elastico
- massetto cementizio
- solaio in latero-cemento
- intonaco
Dall’alto: i frangisole in ceramica con struttura metallica; uno dei pezzi speciali per l’aggancio dei frangisole; il cappotto in EPS addittivato con grafite; il placcaggio del solaio del parcheggio con pannelli in idrati di silicati di calcio
P.F.E.+10.30
1 calcestruzzo armato
2 pannello XPS (16 cm)
3 pannello in EPS stampato a celle chiuse (32 cm)
4 rasatura calce-cemento
5 materassino in fibra di vetro (5 cm)
6 lastra cartongesso
7 bancale interno in legno laccato
8 bancale esterno in lamiera coibentata
9 telaio in legno e PUR
10 vetrata a doppia camera
11 pannello in EPS con grafite (32 cm)
12 pezzo speciale in PUR ad alta densità
13 montante in acciaio zincato e verniciato
14 frangisole in ceramica
15 angolare in acciaio per fissaggio
16 pannelli fotovoltaici
P.F.E.-0.05
1 pannello in
2 calcestruzzo armato
3 materassino in fibra di vetro
4 lastra cartongesso
5 telaio in legno e PUR
6 vetrata a doppia camera
7 montante ligneo
8 bancale di quarzite a spacco
9 mattoni pieni
In basso, da sinistra: posa delle soglie in quarzite; pilastri in muratura della sala colazioni
Energy Efficiency
In fase di progetto e realizzazione, ai fini energetici si è fatto riferimento al protocollo tecnico dello standard Passivhaus Tra i requisiti richiesti, questo protocollo tecnico prevede anche una “Thermal Bridge Free Construction”, ovvero la possibilità di non considerare nelle dispersioni totali dell’involucro i nodi tecnologici che presentano valori del coefficiente lineico Ψ inferiori a 0,01 W/mK, mentre quelli che superano tale valore devono essere calcolati e verificati nei valori di temperatura superficiale Per l’albergo, in particolare, sono stati verificati i punti di attacco del piano terra con le strutture del piano interrato, al fine di calcolare flussi di calore e temperature superficiali I flussi di calore aggiuntivi causati dagli attacchi speciali che sorreggono la struttura dei frangisole (λ = 0,04 W/m2K), sono stati invece stimati tramite UNI EN 6946, valutando in circa il 2% l’incidenza superficiale degli stessi sul totale della superficie del cappotto
Dai risultati del bilancio energetico di calore, si è potuto desumere che:
- le dispersioni verso il piano interrato (6 197 kWh/a) sono confrontabili con quelle delle pareti esterne e con quelle verso i blocchi scale e ascensori (7 161 kWh/a) dimostrando quanto sia dispendioso, in termini energetici e costruttivi, la realizzazione di edifici a standard passivo con piani interrati;
- le maggiori dispersioni sono imputabili alle numerose vetrate che, nonostante gli ombreggiamenti fissi delle camere, nel bilancio netto annuale presentano un saldo netto positivo (5.545 kWh), risultato ottenuto soprattutto grazie alle altissime prestazioni isolanti dell’infisso certificato
In relazione all’impatto in termini di energia primaria consumata dal sistema-edificio (illuminazione, apparecchi ausiliari, pompe di circolazione, ventilazione, pompe di calore, domotica etc ) è da sottolineare che, nonostante siano stati compiuti grossi sforzi per installare componenti ad alta efficienza (luci LED, pompe a portata variabile, ventilatori “brush-less” con motori IE3 etc ), il valore di 87 kWh/m2a è in larga parte imputabile ad apparecchiature quali i frigo delle camere (consumo annuo stimato in circa 22 000 kWhe/a) e i sistemi di domotica e servizi TV (consumo annuo stimato in circa 11 000 kWhe/a)




pianta della sala colazioni
A destra, in senso orario: gli aeratori con valvola; un canale di mandata dell’aria in uno dei corridoi; il canale di mandata dell’aria della sala convegni; il torrino esterno di aspirazione del sistema di ventilazione.


Impianti
L’edificio dispone di un sistema meccanico per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria Ma il vero “cuore” dell’edificio è la macchina di ventilazione ad altissimo rendimento posizionata nel vano tecnico al piano interrato da 9 500 m3/h, con un’efficienza nel recupero di calore dichiarata superiore al 74%; grazie al recuperatore a piastre controcorrente a due stadi, ai ventilatori “brush-less” e agli inverter di cui sono dotati, è possibile regolare la portata d’aria in funzione delle zone attive o spente Un gruppo frigorifero interno, tramite una batteria di post-trattamento, provvede nel periodo estivo a raffreddare l’aria prima di immetterla nell’ambiente
La climatizzazione dell’edificio è affidata a un sistema a pompa di calore modulare a espansione diretta del gas frigogeno Il sistema è definito “a recupero di calore” e provvede a trasferire il calore dalle zone che devono essere raffreddate a quelle che devono essere riscaldate, senza la necessità di dover spendere altra energia sotto forma di lavoro di compressione, considerato che le unità interne (presenti in ogni ambiente climatizzato) sono libere di funzionare in riscaldamento o raffrescamento
L’acqua calda sanitaria è prodotta da un impianto solare termico collegato a due accumuli tecnici da 2 000 litri in grado di fornire istantaneamente acqua calda tramite uno scambiatore a piastre dedicato Una caldaia funzionante a metano fa da supporto all’impianto nei momenti di massimo carico e durante i periodi di scarso irraggiamento solare Riguardo l’illuminazione interna ed esterna, particolare cura è stata prestata sia all’efficienza luminosa complessiva dei corpi illuminanti sia alla gestione degli stessi tramite sensori di presenza, sensori di movimento, dimmerazione e parzializzazione. La massimizzazione della luminosità naturale è invece il motivo principale delle tinte chiare che caratterizzano tutti gli ambienti interni


INVOLUCRO
trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,12 W/m2K solaio contro interrato, U = 0,14 W/m2K copertura, U = 0,15 W/m2K serramenti, Uw = 0,72 W/m2K
prestazioni energetiche riscaldamento (energia utile), 10 kWh/m2anno ACS (energia primaria), 8,65 kWh/m2 anno raffrescamento, 7 kWh/m2 anno emissioni CO2 evitate, 13 482 kg/anno
IMPIANTI
VMC da 9 500 m3/h con recupero di calore (74%) solare termico 35 m2 (9 pannelli) fotovoltaico 10,5 kW domotica sistema KNX climatizzazione pompa di calore modulare a espansione diretta del gas frigogeno illuminazione lampade LED e CFL o tubolari T5 a reattore elettronico




copertura/parete portante esterna
copertura/parete contro vano scale
copertura/parete divisoria
Copertura, dall’esterno:
- pannello in legno lamellare (10 cm)
- telo freno vapore
- isolante in fibra di legno
- telo traspirante (sd=2 m)
- camera di ventilazione
- lastra ondulata sottocoppo
- perline in abete
- coppo in laterizio
1 intonaco
2 pannello in EPS con grafite
3 calcestruzzo armato
4 materassino in fibra di vetro
5 lastra cartongesso
6 materassino fonoisolante in EPS elastico
7 lattoneria in rame
8 griglia di aerazione
9 trave portante in legno lamellare
10 arcareccio per ventilazione (9x16 cm)
11 pannelli fotovoltaici
copertura/parete portante interna
A sinistra, dall’alto: due immagini della fibra di legno della copertura; le travi portanti della copertura; una parte divisoria tra le camere.
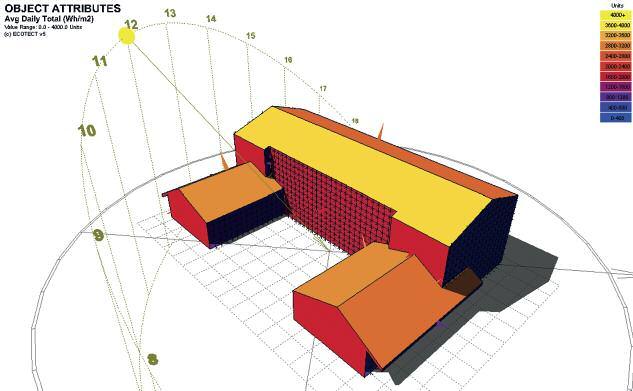
irraggiamento estate
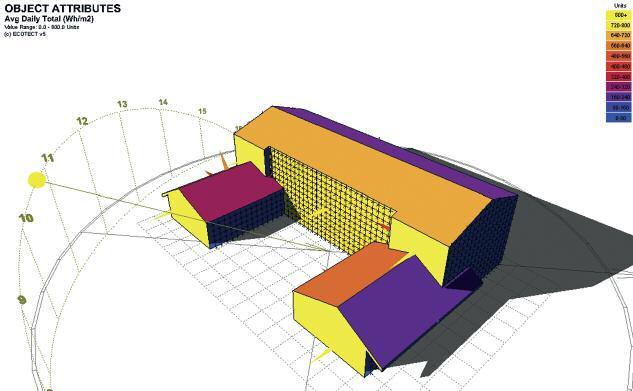
irraggiamento inverno
Placcaggio dall’interno delle pareti esterne

RECUPERO PASSIVO
3 domande a ... ing Michele De Beni - Direttore Ufficio di Modena TBZ (Centro di Fisica EdileBolzano); membro del Consiglio Scientifico PHI Italia (Passive House Institute Italia)
Perché un professionista dovrebbe progettare una casa passiva e poi certificarla?
Cosa garantisce una certificazione di edificio passivo?
La progettazione e la certificazione sono due percorsi complementari che hanno il comune scopo di dare al cliente l’edificio che lui desidera Io credo fermamente che sia il regolamento tecnico, base della certificazione stessa, a essere di primaria importanza per le basi che fornisce ai progettisti e per le garanzie di riuscita dell’intero processo Questo regolamento, credo debba poi essere visto come un documento dinamico, che si arricchisce con la rapida evoluzione della tecnica odierna e con le esperienze dei tecnici che lo applicano sul territorio
Non solo, credo che i protocolli in generale debbano ampliare il proprio raggio d’azione e, da rigida applicazione o rispetto di valori numerici, diventare sempre più delle linee guida per i progettisti, coinvolgendo maggiormente i clienti sia prima che dopo la realizzazione del proprio edificio passivo Nello specifico, l’albergo “Il Boiardo” è stato progettato e realizzato nel rispetto del regolamento tecnico del neonato protocollo del PHI-Italia, frutto delle esperienze bioclimatiche italiane, dell’evoluzione degli edifici SUPERINSULATION in NordAmerica, della metodologia del Passivhaus Institut Darmstadt, delle normative nazionali e internazionali e delle esperienze e adattamenti necessari di edifici passivi sul territorio italiano
In breve potrebbe descriverci quali sono le problematiche che deve affrontare un progettista quando sceglie di progettare secondo standard passivi in Italia?
Paradossalmente, credo che le problematiche maggiori siano legate all’impostazione errata delle fasi preliminari del progetto L’esigenza di coinvolgere i clienti nasce proprio dal fatto che le loro richieste, se mal poste, possono costringere la progettazione e la realizzazione su un percorso più tortuoso e meno efficace di quello ottimale Un edificio passivo nasce con specifiche esigenze tecniche che la stessa fisica pone come condizione essenziale per la riuscita del progetto stesso
Secondo lei, il recupero del patrimonio edilizio esistente può essere il futuro della progettazione e del settore edile?
Credo che questo sia in parte vero, ma non sarà la regola Dipende dal “disegno” che in futuro si vorrà dare – dalla scala territoriale a quella urbana – alle nostre città Il recupero, in quanto estremamente costoso e difficoltoso, dovrà essere fatto solo per quelle realtà che rientrano in questo progetto globale in cui l’autosufficienza energetica degli edifici sarà un tema chiave, ma non l’unico




Il ristorante
Il ristorante è un edifico separato dall’albergo, che si contraddistingue per le alti performance energetiche raggiunte grazie alle soluzioni impiantistiche e all’isolamento a cappotto realizzato con lastre isolanti minerali in idrati di silicati di calcio
Il sistema di recupero del calore nel ristorante è identico a quello dell’albergo, ma la macchina di ventilazione, grazie a un sistema di lavaggio interno dello scambiatore, può recuperare energia anche dai fumi della cucina Questo significa che con una temperatura dell’aria totale espulsa (cucina più sale) che mediamente rimane su valori attorno ai 26-27 °C (persino superiori con la cucina a pieno carico), l’aria immessa, attraverso il recuperatore di calore, raggiunge temperature prossime ai 22-23 °C
Questo carico è, per la maggior parte della stagione invernale, sufficiente a compensare le perdite dell’involucro dell’edificio, altamente efficiente Quando non ciò non è sufficiente, interviene il sistema di ricircolo dell’aria interno con le unità interne a fancoil del sistema VRV (Volume di Refrigerante Variabile)
In estate, invece, i fumi della cucina, attraverso un bypass, vengono direttamente espulsi all’esterno, mentre l’aria delle sale è raffrescata attraverso un sistema di raffrescamento adiabatico indiretto che la stessa macchina di ventilazione integra al suo interno
Sopra, vista del corpo del ristorante dall’albergo
A sinistra, dall’alto, i canali di ventilazione inseriti direttamente nella platea dell’edificio
In basso, installazione della macchina di ventilazione.
Sotto, l’isolamento esterno dell’involucro in pannelli minerali in idrati di silicato di calcio dell’edificio del ristorante

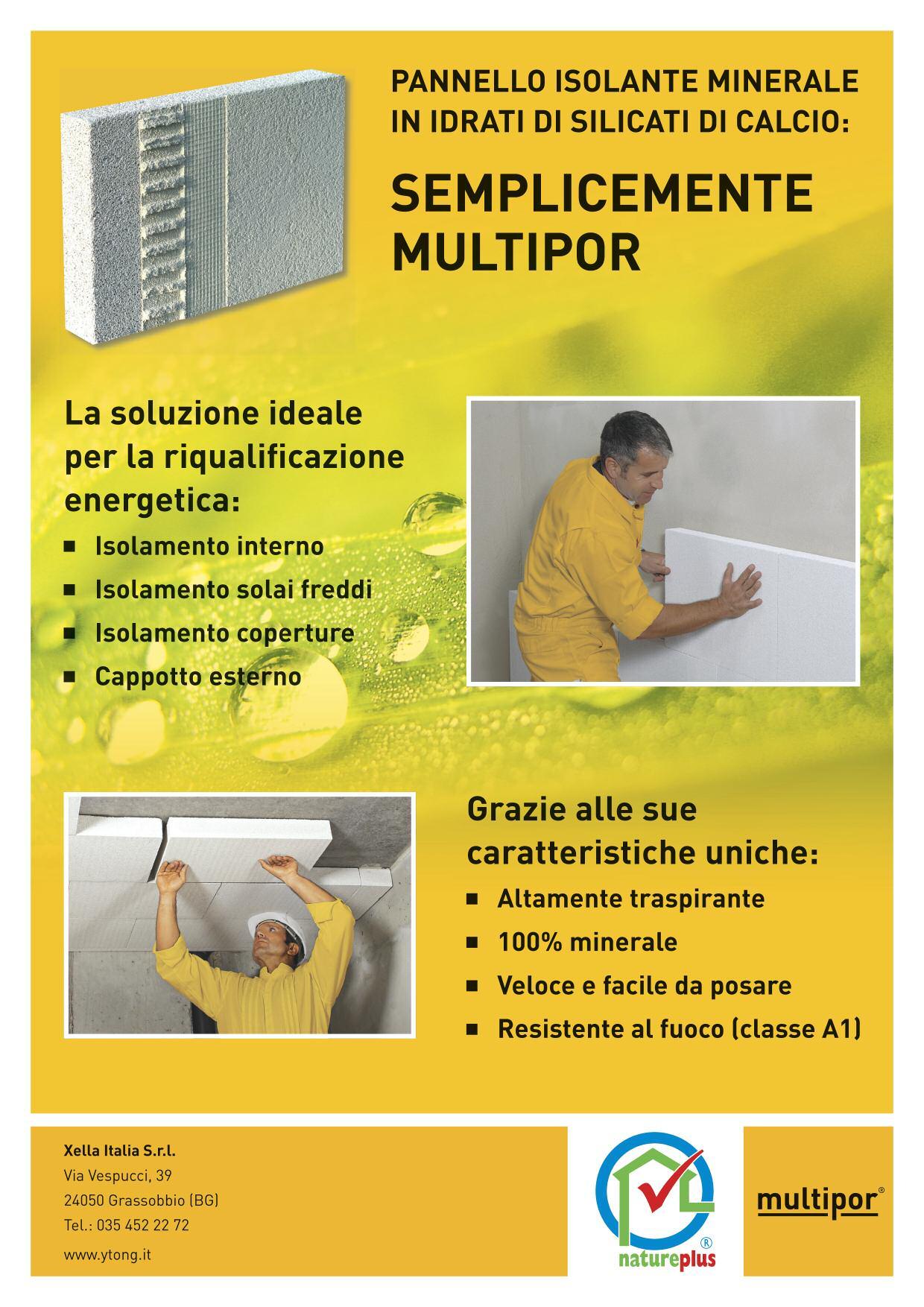


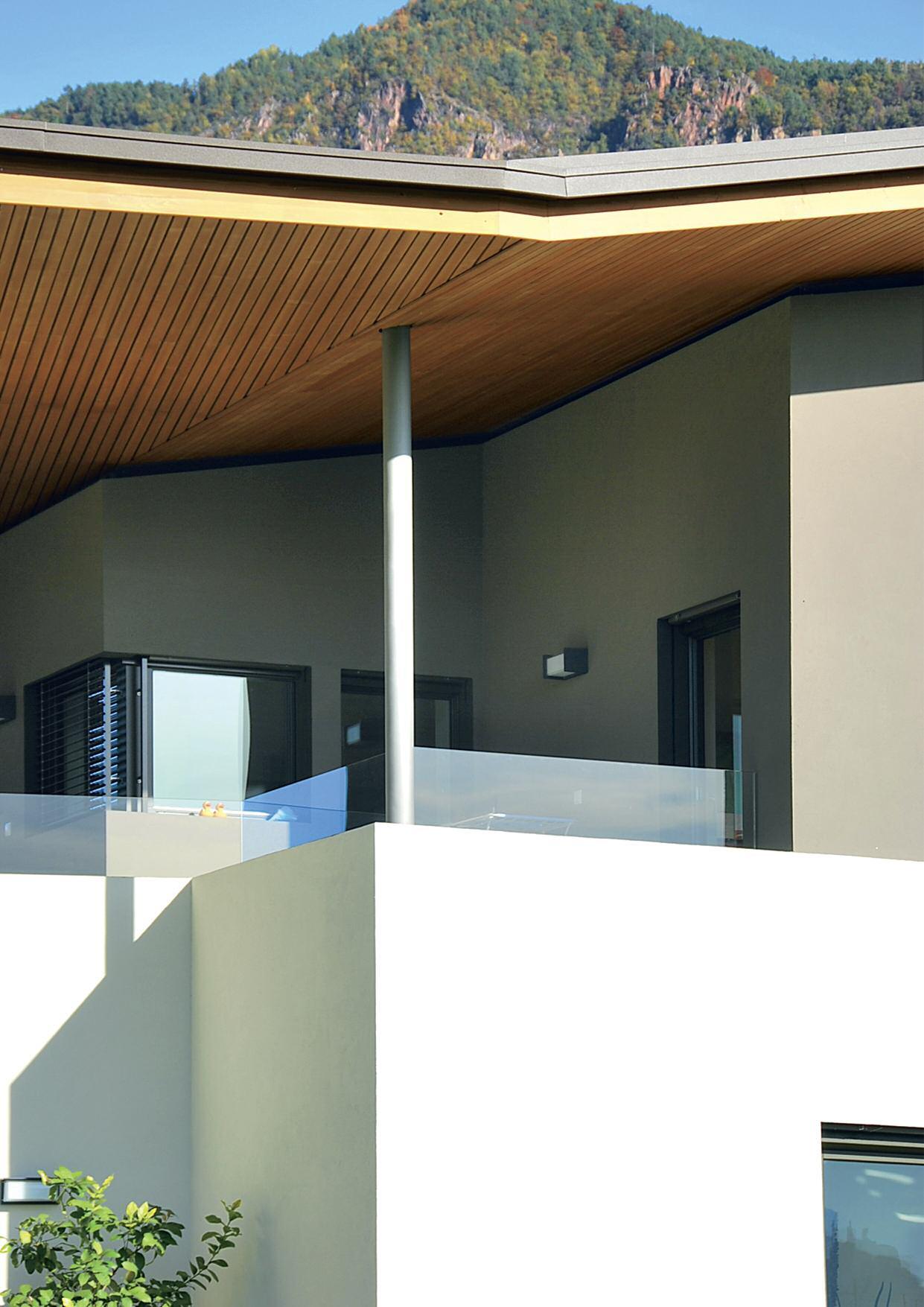
Tribus
Il rispetto dei criteri delle certificazioni Passivhaus e CasaClima ha consentito la realizzazione di un complesso a bassissimo consumo energetico caratterizzato da una grande copertura con ampi sbalzi Uno spostamento di cubatura ha inoltre permesso la realizzazione del fabbricato in un’area più sicura e accessibile
SOTTO UN UNICO TETTO
Questo nuovo complesso a corte con due unità abitative, una residenza per vacanze e un corpo di servizio è il risultato dello spostamento di cubatura di una cascina da una zona centrale di Terlano in un’area nella frazione di Settequerce La scelta di costruire un edificio ex novo in un area verde già urbanizzata nella zona meridionale della cittadina è legata alle difficoltà e ai limiti della ristrutturazione dell’edificio esistente, opzione verso la quale i proprietari erano inizialmente orientati; si è così utilizzata la possibilità di uno spostamento di cubatura usufruendo anche del bonus del 10% assegnato agli edifici che raggiungono almeno la classe energetica A della certificazione CasaClima in vigore nella Provincia di Bolzano
Il Kererhof, questo il nome del nuovo complesso, è composto da due volumi, simili planimetricamente e collegati al centro da un ingresso comune: le due unità si piegano sul piano a creare una V che sembra allontanarle, dando l’impressione, a chi vi risiede, di abitare in edifici autonomi che si aprono verso sud A nord il locale tecnico, i garage e gli spazi di servizio chiudono il
lotto formando un cortile chiuso Dei due corpi, quello orientato a ovest ospita l’appartamento del proprietario con al piano superiore l’appartamento per le vacanze, mentre quello a est accoglie l’abitazione della figlia L’involucro è realizzato con blocchi a cassero in legno cemento mineralizzato con isolante
La copertura a doppia falda è a travetti portanti a doppia T in legno di provenienza prevalentemente locale con tamponamento sui due lati in OSB a comporre una struttura scatolare isolata internamente con fibra di cellulosa
I grandi sbalzi del tetto, a protezione dalle intemperie e dall’irraggiamento, hanno struttura in legno con sostegni metallici lungo i fronti sud, est e ovest
Per quanto riguarda gli impianti sono stati installati una ventilazione meccanica controllata centralizzata per ogni edificio, una pompa di calore geotermica, pannelli radianti a pavimento e collettori solari termici
L’edificio è di tipo passivo ed è stato progettato, realizzato e certificato secondo i protocolli Passivhaus e CasaClima

Impiantistica
Il ridotto consumo energetico è il frutto dell’efficacia dell’involucro – coibentazione e tenuta all’aria – e delle scelte impiantistiche Oltre a rispettare i parametri richiesti di dal Passivhaus e da CasaClima, controlli sono stati effettuati anche durante la fase di costruzione attraverso il Blower Door Test (n50 = 0,5/h)
Tecnologicamente ogni unità immobiliare è autonoma: un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore specifico fino al 90% garantisce una buona qualità dell’aria indoor, mentre una pompa di calore geotermica riscalda e raffresca gli ambienti mediante soffitti radianti (nei bagni tramite pavimenti radianti), sia i collettori solari nella produzione di acqua calda sanitaria (con uno stoccaggio di riserva)
La temperatura ambiente è scelta in autonomia dai singoli utilizzatori. Indipendenti anche gli impianti elettrici con singoli contatori in ogni abitazione da 3 kW e un impianto fotovoltaico integrato sulla copertura dell’edificio di servizio
sezione longitudinale
trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,147 W/m2K solaio controterra, U = 0,13 W/m2K copertura, U = 0,135 W/m2K serramenti, Uw = 0,98 W/m2K; Ug = 0,65 W/m2K; g = 60%
energia primaria, 61 kWh/m2anno
IMPIANTI
VMC con recupero di calore pompa di calore geotermica solare termico

Progetto architettonico arch. Michael Tribus, Lana (BZ)
Fisica tecnica Günther Gantioler, Luca Senettin (TBZ), Bolzano
Progetto strutture ing Markus Peer, Avelengo (BZ)
Impianti p i Anton Linter, Malles (BZ)
Direttore dei lavori arch. Michael Tribus, Lana (BZ)
Appaltatore Plattner Bau, Laives (BZ)
Superficie lotto 3 600 m2
Superficie netta 585,23 m2

A sinistra, il blocco ovest con la parte coperta che delimita la corte formata dalle unità abitative con l’edificio di servizio Quest’ultimo è destinato ai servizi, al locale tecnico e al garage; sulla copertura è stato installato l’impianto fotovoltaico
fronte sud
Copertura, dall’estradosso:
- membrana impermeabile bituminosa (20 mm)
- distanziatore in legno (160 mm)
- sottostruttura in legno (90 mm)
- ventilazione
- OSB (20 mm)
- isolamento (410 mm)
- OSB (20 mm)
- cartongesso (100 mm)
- intonaco interno (15 mm)
Parete esterna, dall’esterno:
- intonaco in cemento di calce (20 mm)
- cassero in legno-cemento mineralizzato (40 mm)
- cavità (140 mm)
- cassero in legno-cemento mineralizzato (40 mm)
- isolamento in resina fenolica (λ=0,021; 165 mm)
- cemento armato (120 mm)
- cassero in legno-cemento mineralizzato (40 mm)
- intonaco di calce
Solaio interpiano, dall’estradosso:
- parquet in legno (20 mm)
- massetto (120 mm)
- lastra di fibra di legno anticalpestio (20 mm)
- cemento cellulare (100 mm)
- solaio strutturale con installazione dei tubi di ventilazione di spessore 80 mm (220 mm)
- intonaco in argilla (30 mm) che copre i tubi del soffitto radiante di spessore 12 mm
Solaio contro terra, dall’estradosso:
- parquet in legno (20 mm)
- massetto (75 mm)
- cemento cellulare (150 mm)
- platea in c a (300 mm)
- isolamento in XPS (200 mm)
- guaina impermeabilizzante
- isolamento in XPS (200 mm)
- terreno compattato


A destra, sopra la platea di fondazione viene realizzata la muratura con blocchi cassero in legno cemento mineralizzato con isolante all’interno dei quali verrà eseguito il getto in calcestruzzo




A sinistra in alto, si notano i tre sistemi costruttivi utilizzati: blocchi cassero in legno cemento mineralizzato per la struttura esterna, laterizi per le partizioni interne, legno per la copertura
A destra in alto, struttura del tetto: impermeabilizzazione e ventilazione con contro listelli. A destra in basso, vista dall’interno della copertura, una struttura scatolare con travi portanti coibentata con fiocchi di cellulosa
In basso a sinistra, controtelaio in legno sui quattro lati; a destra dettaglio del cassonetto della veneziana esterna posato interamente nello spessore dell’isolante esterno

Perkins+Will, Vancouver (CAN) 2011 PROGETTO ARCHITETTONICO
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE
Living Building ChallengeTM; LEED Platinum
(LEED® New Construction v 1.0 Platinum) in fase di certificazione
< 15 kWh/m2 anno



FOTOGRAFIE: Martin Tessler; Don Erhardt
Nato da un’idea del premio Nobel John Robinson, il Centre for Interactive Research on Sustainability ha una nuova sede progettata per essere l’edificio più sostenibile e virtuoso del Nord America: un Living Lab a energia positiva e carbon free
UN MANIFESTO PER UN FUTURO MAGGIORMENTE SOSTENIBILE
Collocato all’interno del Campus della University of British Columbia a Vancouver, il Centre for Interactive Research on Sustainability (CIRS) incarna i programmi di sostenibilità ambientale ed energetica che contraddistinguono le certificazioni LEED e LBC (Living Building Challenge) La mission del Centro è accelerare la sostenibilità nella società e così l’obiettivo per la sua sede è stato un edificio ad alte prestazioni ma anche replicabile e quindi con un costo accettabile nonostante soluzioni innovative, processi e risorse ben al di là della portata di qualsiasi edificio convenzionale La disposizione volumetrica è stata accuratamente studiata per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal sito, massimizzare le strategie ambientali passive adottate e ridurre la domanda di energia (il complesso ha prestazioni tipiche di un edificio passivo) L’edificio ha una pianta a U ed è organizzato in due ali di quattro piani collegate da un atrio a tutta altezza che funge da hall dell’edificio, ingresso dell’auditorium e camino per il raffrescamento naturale Nelle fasi iniziali di progetto era stata anche considerata una forma curva dell’edificio, ritenuta più appropriata a una costruzione sostenibile rispetto a una basata su elementi ortogo-
nali, ma si è valutato che quest’ultima fosse più adatta al semplice sistema costruttivo in legno che consente un più facile trasferimento anche a edifici convenzionali delle esperienze fatte L’architettura è caratterizzata dalle ampie vetrate che massimizzano l’illuminazione naturale e dalla facciata verde a ovest con vite a foglie decidue che si comporta come un dispositivo di ombreggiamento dinamico rispondendo ai cambiamenti stagionali e dal tetto verde dell’auditorium fruibile dagli utenti dei laboratori e degli uffici
Dal punto di vista energetico il CIRS sfrutta il calore dei fumi dell’edificio adiacente per il riscaldamento e raffrescamento attraverso pompe di calore coadiuvate da sonde geotermiche Collettori solari a tubi sottovuoto e il sistema di recupero di calore interno consentono di preriscaldare l’acqua sanitaria, mentre i pannelli fotovoltaici sul tetto e quelli integrati sulla copertura dell’atrio e in facciata producono l’energia elettrica Grazie al monitoraggio costante, con i dati visualizzati anche dai display posti nell’atrio, i ricercatori del CIRS saranno in grado di analizzare il consumo di energia e l’efficacia dei sistemi adottati così da ottimizzarne il funzionamento

Sotto, rasatura dei pannelli di una delle due torri a est che saranno rivestite con mattoni bianchi di argilla, essicati a forno e prodotti localmente.
In basso, le travi portanto sostengono l’impalcato di legname dimensionale standard “Dimensional Lumber” è il termine utilizzato per definire il legno finito, tagliato e piallato a una larghezza standard e a uno spessore specifico nei peasi anglossassoni (UK, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada)
EARTH AND OCEAN SCIENCES
CIRS
Progetto Perkins+Will, Vancouver (CAN)
Team di progettazione Peter Busby; Martin Nielsen; Maginnis Cocivera; Sebastien Garon; Brian Gasmena; Jörk Grävenstein; Horace Lai; Blair McCarry; Z Smith
Collaboratori Chessa Adsit-Morris; Clayton Blackman; Loren Cavallin; Imu Chan; William Dahl; Jeremiah Deutscher; Jeff Doble; Robert Drew; Benjamin Engle-Folchert; Bob Greig; Rebecca Holt; Ivan Illic; Herman Kao; Teresa Miller; Sarah Moran; Angelique Pilon; Roselyn Rheaume; Max Richter; Sören Schou; Nathan Shuttleworth; Ray Sun; Kathy Wardle
Strutture Fast + Epp, Vancouver (CAN)
Appaltatore Heatherbrae Construction, Richmond (CAN)
Impianti meccanici ed elettrici Stantec, Vancouver (CAN)
Ingegneria civile Core Group Consultants, Burnaby (CAN)
Acustica BKL Consultants, Vancouver (CAN)
Interni Perkins+Will
Arredi, finiture, attrezzature Haworth, Vancouver (CAN)



planivolumetrico
1 Struttura a telaio a momento in lamellare: consente ampi spazi interni
2 Pannello di taglio sotto finestra
3 Solaio strutturale: è composto da tavole affiancate rivestite di compensato
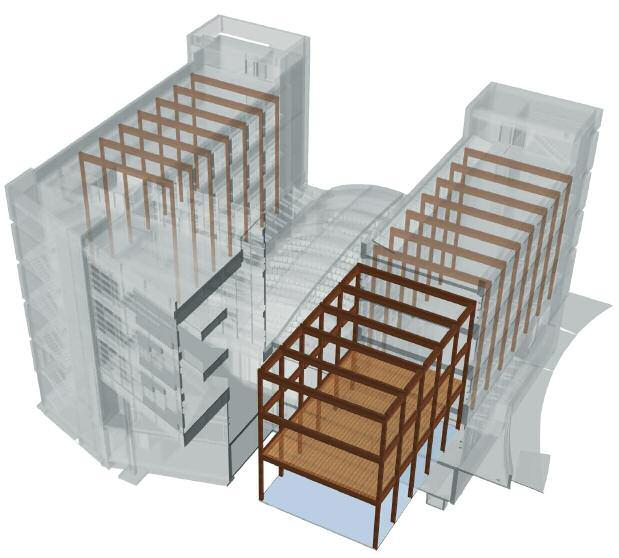
8
L’involucro e i ponti termici
Il sistema strutturale dell’edificio è realizzato con pilastri rettangolari in lamellare prefabbricati (21,5x65 cm) che supportano le travi in lamellare dei solai (sezione 21,5x68,5 cm con passo di 3 m e lunghezza di circa 10 m) Le travi sostengono un impalcato costituito da tavole di legname a dimensione standard (38x89 cm), inchiodate tra di loro e rivestite di compensato. La resistenza laterale della struttura è garantita attraverso due soluzioni: pannelli di compensato che controventano le pareti di taglio e, nella direzione opposta, un sistema a telaio a momento che combina i pilastri ai pannelli sotto finestra, realizzati su moduli di compensato (122x244 cm), prefabbricati come travi scatolari e posti tra gli elementi strutturali Questa applicazione garantisce anche la resistenza ai carichi dovuti al vento e al sisma nella direzione della lunghezza dell’edificio, consentendo l’impiego di facciate vetrate continue per massimizzare la luce naturale negli spazi interni Pilastri e travi sono leggermente sovradimensionati affinché, in caso di incendio, le loro parti marginali carbonizzino mantenendo l’integrità strutturale Oltre il 50% del legno è di origine locale e certificato FSC (Forest Stewardship Council); l’obiettivo del 100% di legno FSC non è stato raggiunto a causa dell’indisponibilità in loco di un quantitativo sufficiente per la

costruzione Per la restante parte si è così preferito legname regionale non certificato piuttosto che far giungere materiale FSC dal Cile, il luogo più vicino disponibile per la fornitura L’utilizzo del legno come materiale primario da costruzione è stato attentamente valutato confrontando le emissioni di CO2 dell’acciaio, del calcestruzzo e del legno lamellare Dall’analisi è emerso un chiaro vantaggio del legno rispetto agli altri due materiali: l’impronta netta di carbonio della struttura in legno (raccolta, lavorazione e trasporto) è di -0,09 t di anidride carbonica equivalente (CO2-e) per metro cubo, sequestrando 600 t di CO2-e; questo valore è superiore alle 525 t di CO2-e generate dalla produzione e dal trasporto di tutti gli altri materiali usati nella struttura, rendendo il CIRS carbon neutral
Al fine di raggiungere un alto livello di efficienza energetica si sono minimizzati i ponti termici; l’isolamento esterno delle facciate garantisce la continuità della coibentazione, soprattutto ai margini delle solette e in corrispondenza dei travetti di bordo
La facciata continua è allineata al piano della coibentazione esterna per ridurre al massimo le piccole perdite di calore nelle transizioni della stessa facciata e i collegamenti alla struttura portante sono di tipo puntuale, così da ridurre significativamente i ponti termici
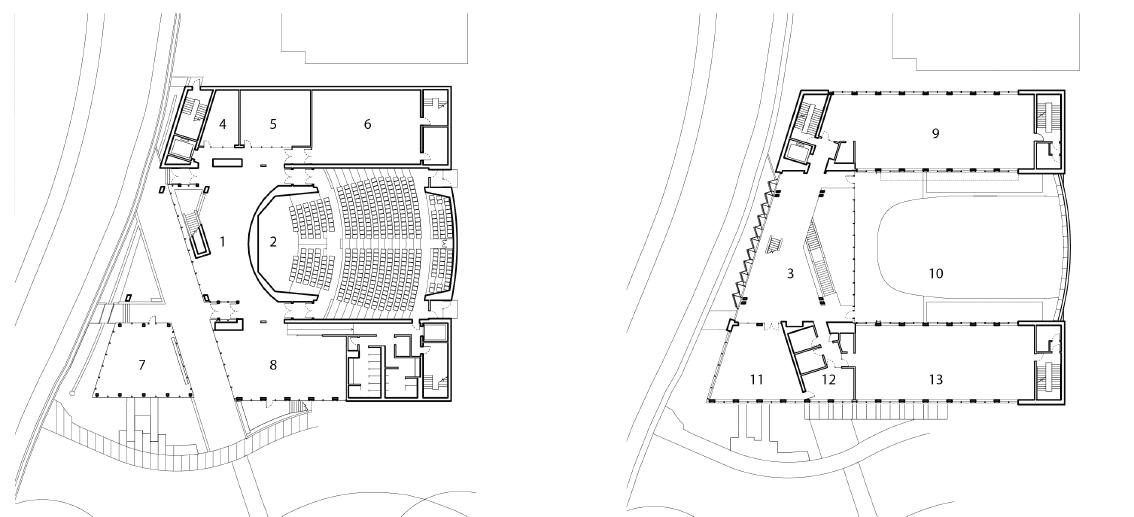
pianta del piano terra
pianta del secondo livello
Un’immagine della prima fase di cantiere, con la posa delle tubature a lvello delle fondazioni
Legenda del rendering del sistema di scambio energetico:
1 Edificio esistente, EOS (Earth and Ocean Science)
2 Scambiatori di calore: catturano energia termica dai fumi di scarico dell’EOS
3 30 sonde verticali per scambio geotermico
4 Pompe di calore: aumentano il calore proveniente dai pozzi geotermici e dall’EOS
5 Pannello radianti: scaldano l’aria di ventilazione che è distribuita attraverso un sistema ad aria sotto pavimento
6 Calore in eccesso restituito all’EOS: per il pretrattamento dell’aria di ventilazione
Energy systems
Uno degli obiettivi più importanti del CIRS era ottenere un bilancio positivo di energia netta Sfruttando fonti rinnovabili e raccogliendo e riciclando i rifiuti, l’edificio è in grado di sopperire non solo alle proprie necessità, ma anche a una parte delle esigenze dell’edificio adiacente (l’EOS - Earth and Ocean Science) del quale utilizza il calore dei fumi
Il risultato finale vede il consumo energetico totale del Campus della UBC ridursi complessivamente di oltre 1 milione di kWh/anno pur essendosi aggiunto un nuovo edifico – il CIRS appunto – di 5675 m2
I diversi sistemi (scambiatori di calore, pompe di calore, sonde geotermiche, sistemi di pretrattamento dell’aria, impianto fotovoltaico, ecc ) che concorrono al raggiungimento di questo risultato sono illustrati in questa e nelle pagine successive

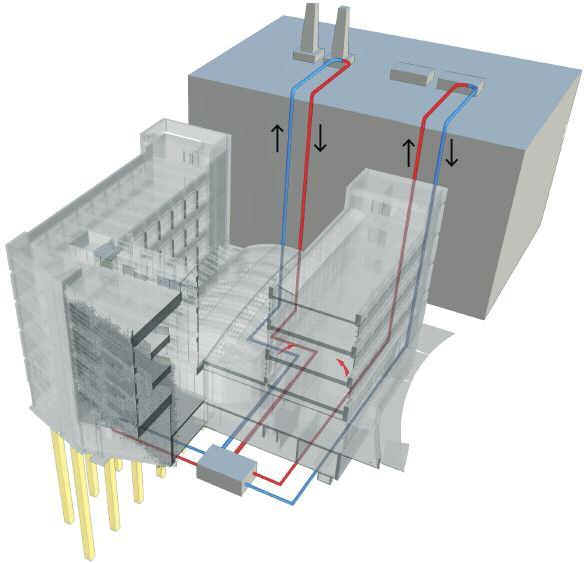
Una sezione prospettica in cui è indicato il bilancio energetico tra edificio del CIRS ed edificio dell’EOS

613,540 ekWhr/anno
ekWhr/anno
036,783 ekWhr/anno
Fasi di cantiere del CIRS, dalla realizzazione delle fondazioni al primo solaio in c.a. su cui si innalzeranno i piani superiori, con sistema costruttivo in legno








Riscaldamento, raffrescamento e ACS Riscaldamento e raffrescamento sono forniti da tre pompe di calore, localizzate nella centrale impianti al seminterrato e alimentate da tre fonti di calore La sorgente principale è il calore recuperato dalle serpentine connesse allo scarico fumi dei laboratori del vicino Earth and Ocean Science Building le quali forniscono, secondo dati monitorati in loco, 10 384 l/s di fumi, garantendo al CIRS una quantità di calore maggiore rispetto a quella necessaria: il calore in eccesso viene restituito all’EOS per il preriscaldamento dell’aria in ingresso Scambiatori collocati nel flusso dell’aria di scarico del CIRS recuperano ulteriore calore che, raccolto dalle unità di trattamento aria, dai gabinetti e dal locale tecnico che ospita le pompe di calore, è utilizzato per preriscaldare l’acqua a uso sanitario La terza fonte è un piccolo campo geotermico che integra i sistemi di recupero e permette di fornire all’EOS una quantità di calore maggiore Il calore è distribuito mediante un sistema a pavimento e, negli uffici, anche con battiscopa radianti Il raffrescamento è attuato mediante differenti sistemi; l’edificio, che è progettato per utilizzare strategie passive di ventilazione naturale nella maggior parte degli spazi interni, è coadiuvato da due unità di trattamento aria In dettaglio: negli uffici il raffrescamento avviene manualmente attraverso l’apertura di finestre a livello dei piani di lavoro o del solaio superiore, così da attuare una ventilazione naturale di tipo passante tra la facciata sud e le finestre a nord Un sistema di ventilazione meccanica distribuisce aria fresca da bocchette a livello del pavimento: velocità, flusso e temperatura dell’aria sono stabiliti dai singoli utilizzatori Il sistema automatizzato di gestione dell’edificio monitora l’apertura delle finestre, spegnendo la ventilazione meccanica quando il 30%, o più, delle finestre è aperto Per la ventilazione e il riscaldamento dell’auditorium è utilizzata una unità meccanica dedicata, mentre nell’atrio si sfrutta l’effetto camino grazie all’apertura motorizzata delle vetrate in copertura Gli spazi di servizio sono ventilati meccanicamente
Le pompe di calore e i collettori sottovuoto (40 m2) posti sul tetto garantiscono al CIRS l’acqua calda sanitaria per un totale di 15 400 kWh/anno con conseguente eccesso di produzione in estate, periodo in cui l’edificio è meno frequentato Al momento, il calore in surplus è dissipato in atmosfera, ma i ricercatori del Centro stanno studiando come recuperarlo e riutilizzarlo in futuro


1 Atrio centrale: si comporta come un camino termico per incanalare la ventilazione naturale nell'edificio
2 Prese di aspirazione per il sistema di VM
3 Aperture apribili sul tetto dell'atrio
4 Ventilazione a dislocamento attraverso la distribuzione dell'aria a pavimento
5 Elementi orizzontali a livello dei solai in facciata: favoriscono il flusso della ventilazione passante
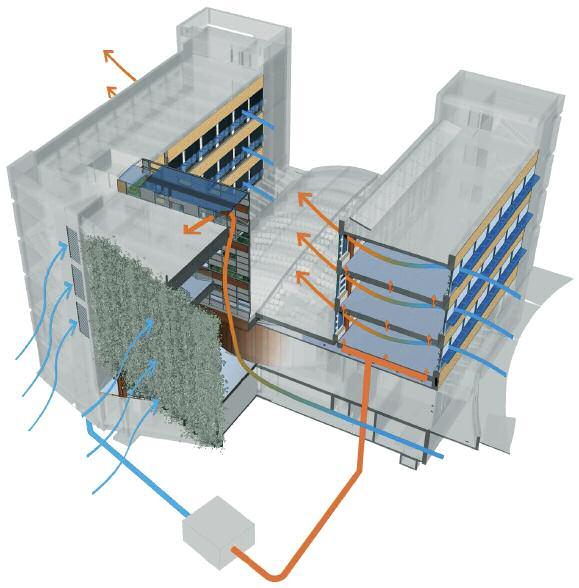
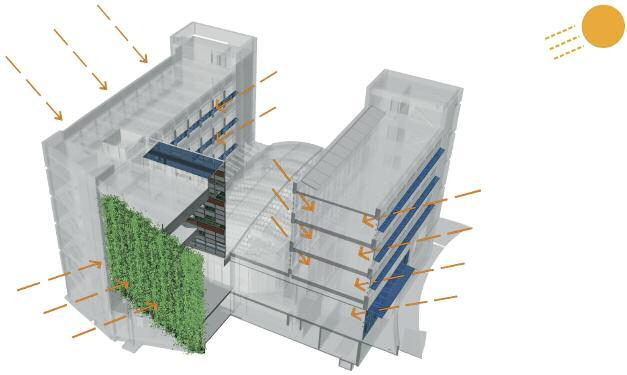
rendering del sistema di illuminazione naturale
1 Elementi orizzontali a livello dei solai in facciata: favoriscono la penetrazione della luce naturale
2 Schermature solari con integrate celle fotovoltaiche
3 Parete vivente: in estate ombreggia gli spazi interni dal basso sale pomeridiano, in inverno, cadute le foglie, lascia entrare la luce del sole negli spazi interni

rendering del sistema di produzione di energia elettrica dal sole
1 Serie di celle fotovoltaiche integrate nei lucernari vetrati dell’atrio
2 Schermature solari fotovoltaiche
3 Collettori solari a tubi sottovuoto: preriscaldano l’ACS



In alto, le aperture delll’angolo sud-ovest sono schermate da piccole tettoie fotovoltaiche
Qui sopra, la copertura fotovoltaica dell’atrio d’ingresso, integrata architettonicamente
Illuminazione ed elettricità
L’orientamento dell’edificio e la sua volumetria sono frutto della volontà di garantire illuminazione naturale in tutte le parti dell’edificio Grazie al sistema strutturale è stato possibile utilizzare grandi superfici vetrate in facciata e posizionare le aperture il più in alto possibile, così da permettere una maggiore penetrazione della luce negli spazi interni Gli elementi costruttivi, le velette, gli schermi solari e la parete verde sono stati pensati per controllare l’abbagliamento e i guadagni solari L’illuminazione diurna è completata da strategie attive a seconda dell’uso e delle esigenze dei diversi spazi: le luci artificiali sono dotate di sensori di dimmerizzazione per il controllo del livello di illuminazione e di sensori di movimento che consentono lo spegnimento degli apparecchi illuminanti in assenza di occupazione
Una serie di pannelli fotovoltaici sul tetto e celle integrate sulla copertura vetrata dell’atrio e sulle schermature delle facciate continue consentono una produzione di energia pari al 10% del fabbisogno totale (22 148 kWh/anno) dell’edificio Non è stato possibile integrare ulteriori fonti rinnovabili, ad esempio turbine eoliche, a causa delle tecnologie attuali, del clima locale e dei vincoli del sito
I collettori dell’impianto solare di produzione dell’acqua calda sanitaria occupano una parte della copertura dell’ala sud




In senso orario dall’alto a sinistra: il passo dei pilastri della struttura a telaio; orditura secondaria delle pareti e tamponamento per il controventamento delle stesse; vista della struttura dal basso con i pannelli sottofinestra prefabbricati come travi scatolari e posti in opera tra i pilastri

Alcune immagini dell’edificio in fase di costruzione
Qui sotto, due immagini di cantiere della realizzazione dell’auditorium
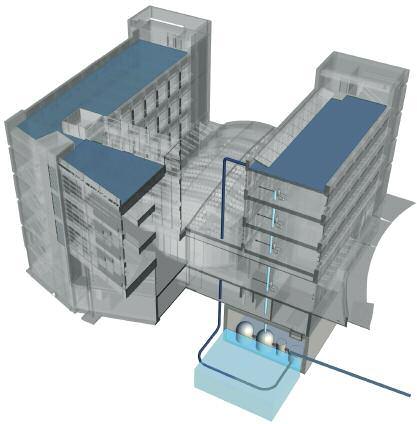
rendering del sistema di recupero delle acque piovane
1 Acqua piovana raccolta dai tetti del CIRS
2 Acqua piovana raccolta dalla copertura dell’Auditorium: non è utilizzata per usi potabili, ma viene reindirizzata alla falda acquifera
3 Sistema di filtrazione e trattamento
4 Collegamento di riserva con il sistema d’acqua municipale
5 Acqua piovana stoccata in una cisterna da 107 000 l
6 Acqua potabile filtrata, trattata e distribuita all’interno dell’edificio

rendering del sistema di recupero delle acque reflue
1 Acqua nere e grigie: sono raccolte dalle tubature dell’edificio
2 Sistema acquatico solare: è basato su un processo biologico che accade naturalmente
Filtra e tratta l’acqua per il riutilizzo
3 Acqua recuperata: è pompata all’interno dell’edificio per essere utilizzata negli sciacquoni dei wc, per irrigare il tetto dell’auditorium, le aree e la parete verde

Il giardino antistante il CIRS è utilizzato per convogliare, filtrare e gestire al 100% il deflusso delle acque piovane sul sito dell’edificio
Acque
Il CIRS è completamente autosufficiente per quanto riguarda il consumo di acqua potabile, ottenuta dal trattamento dell’acqua piovana raccolta dalle coperture Immagazzinata in una cisterna di 100 m3 sotto l’edificio, viene filtrata, disinfettata in loco e ridistribuita per uso potabile In un anno sono raccolti mediamente 1 226 000 litri, a fronte di una domanda media per questo tipo di edifici di 2 000 litri/giorno 57 000 l sono costantemente disponibili per il sistema antincendio Una particolarità del CIRS è il sistema di biofiltrazione acquatica solare, situato in una serra vetrata nell’angolo sud-ovest dell’edificio e ben visibile dal percorso pedonale che attraverso il sito Il sistema, basato sull’ingegnerizzazione di processi naturali, raccoglie tutte le acque reflue dell’edificio ed è supportato nei periodi di bassa affluenza dal sistema fognario del Campus; il liquame viene stivato in un serbatoio chiuso dove vengono aggiunti i batteri che digeriscono il rifiuto biologico Passando attraverso una serie di serbatoi di aerazione, popolati in superficie da piante acquatiche e terrestri autoctone, l’acqua è aerata prima di passare al chiarificatore a gravità con fondo a cono, dove i batteri si separano dall’acqua chiarificata per essere ripompati nel serbatoio di miscelazione iniziale Dopo il passaggio in una serie di filtri a sabbia, un ulteriore filtraggio e la disinfezione, l’acqua viene stoccata e rimessa in circolo nell’edificio per gli sciacquoni dei water e per l’irrigazione delle aree verdi
Living Building Challenge
Il Living Building Challenge è un programma di certificazione per edifici sostenibili che definisce i più avanzati interventi di sostenibilità nell’ambiente costruito, possibili al giorno d’oggi. Il Challenge è compreso in sette aree prestazionali o “Petals”: Sito, Acqua, Energia, Materiali, Benessere, Equità, Bellezza I “Petali” sono suddivisi in un totale di venti Imperativi, ognuno dei quali si focalizza su una specifica sfera di influenza Questa raccolta di Imperativi può essere applicata a quasi ogni immaginabile tipologia o progetto, sia esso un edificio (rinnovamento di una struttura esistente o nuova costruzione), un’infrastruttura, un paesaggio o uno sviluppo di una comunità
INVOLUCRO
trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,28 W/m2K; RSI-3 5 (R-20) copertura, U = 0,14 W/m2K; RSI-7 0 (R-40) serramenti, Uw = 0,91 W/m2K; g = 0,35 (tipo 1); Uw = 1,87 W/m2K; g = 0,55 (tipo 2)
IMPIANTI
Ventilazione meccanica
Pompe di calore (acqua-acqua)
Solare termico collettori solari a tubi sottovuoto (40 m2) per ACS Fotovoltaico
moduli FV sul tetto, celle FV in schermature di facciata e in copertura vetrata atrio - 22 148 kWh/anno
Recupero acque piovane per apparecchiature sanitarie e irrigazione aree verdi Biofiltrazione solare acquatica serra biofitodepurazione
Gestione automatica aperture e sistema di VM
Dimmerizzazione luci e sensori di presenza per ottimizzazione dell’illuminazione


Sopra, il lucernario fotovoltaico dell’atrio
A destra, il lato sudovest del CIRS, con le tettoie fotovoltaiche a protezione delle aperture rivolte a sud e a ovest e, nell’angolo, la sala vetrata dove avviene la fitodepurazione delle acque reflue
1 copertura fotovoltaica
2 recupero di calore
3 serie di tubi sottovuoto
4 schermature solari fotovoltaiche
5 aria esausta
6 recupero di calore
7 circuito del calore dell’edificio dell’EOS
8 circuito della fonte di raffrescamento
9 pompe di calore del CIRS
10 ventilatori delle pompe di calore
11 elettricità prodotta dal FV ad uso del CIRS
12 unità di trattamento dell’aria
13 elettricità proveniente
14 boiler elettrico
15 acqua calda sanitaria
16 pavimento radianti
17 aria esausta

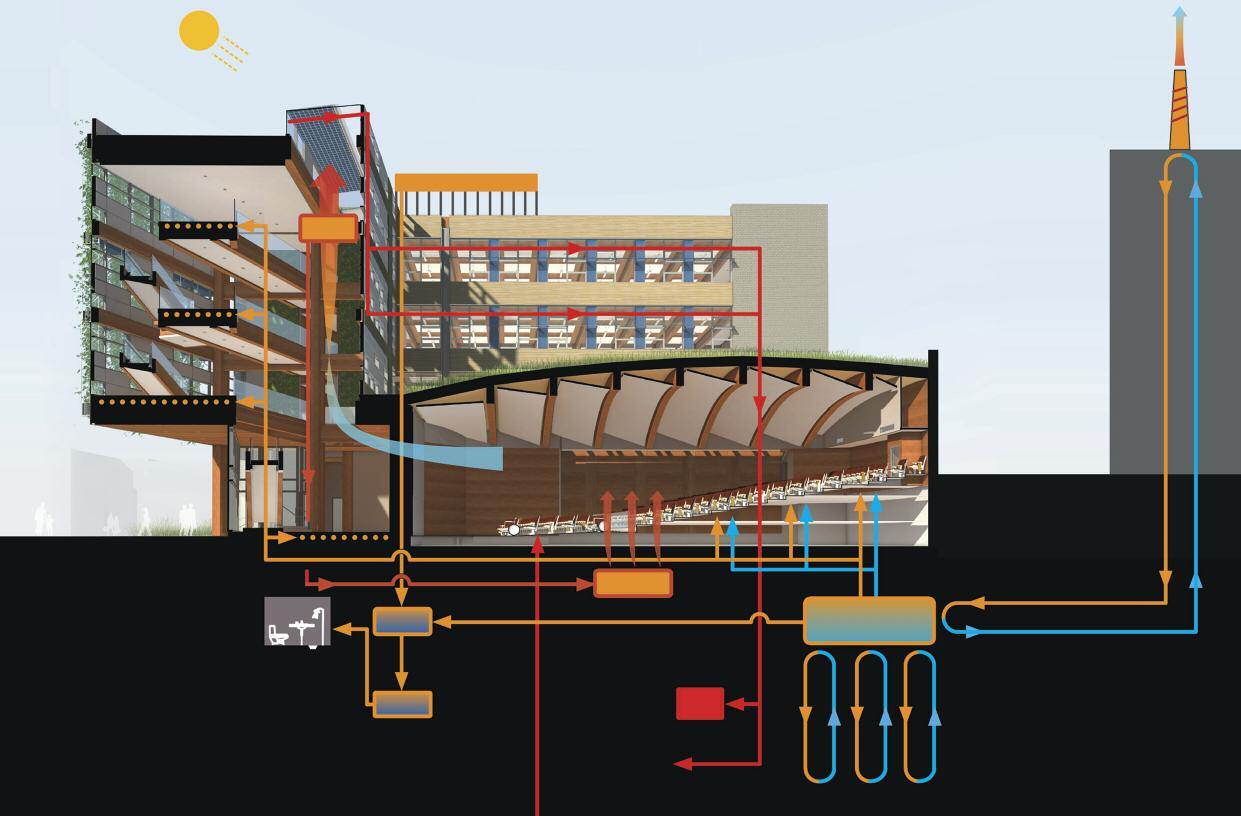
Diagramma del sistema energetico generale del CIRS

MAGK architektur + illiz architektur 2010-2011
FOTOGRAFIE: Hertha Hurnaus gemäß ÖNORM H 5055 und Richtilinie 2002/91/EG


La necessità di avere più spazi per l’infanzia in un comune a sud di Vienna ha portato alla riqualificazione e all’ampliamento della scuola elementare esistente Il nuovo complesso scolastico è caratterizzato da una struttura mista con un nucleo in calcestruzzo armato e l’involucro di legno dalla elevata efficienza energetica
UN’INFANZIA... PASSIVA
L’ampliamento di una scuola nel Comune di Maria Enzersdorf ha dato origine a un nuovo complesso con 8 nuove classi per la scuola elementare esistente, un asilo nido e una scuola materna e caratterizzato dai bassi consumi energetici Il progetto del gruppo MAGK-illiz, vincitore del concorso indetto nel 2008, spezza il volume monolitico che caratterizzava l’esistente complesso scolastico, bisognoso di riqualificazione e ampliamento, creando dei corpi a L incastrati l’uno nell’altro e nuovi spazi per il gioco e l’apprendimento
La nuova entrata principale della scuola è al contempo un foyeraula magna che collega il vecchio edificio con le nuove aule della scuola elementare e con l’edificio risanato della palestra Più a ovest, separati, si trovano i nuovi edifici dell’asilo nido e della scuola materna Il bianco dell’intonaco (alternativamente liscio o grezzo) funge da elemento unificante delle facciate, articolate da aperture di diverse dimensioni che ricordano dei “pixel“ e dalle quali ogni tanto fuoriescono dei “cubi“ che internamente si configurano come nicchie in cui i bambini possono trovare rifugio.
Gli ambienti interni sono fortemente segnati dalla combinazioni di materiali e di colori che facilita l’orientamento e l’identificazione da parte dei bambini Elementi di colore si ritrovano anche sul lato ovest, dove le aule della scuola dell’infanzia si affacciano su una loggia a due piani in cui griglie metalliche bianche, con inserti colorati in vetro disposti in maniera irregolare, svolgono una funzione anticaduta e di protezione solare
Le scelte costruttive e relative ai materiali sono state dettate da necessità di carattere economico ed ecologico Il nuovo edificio, anche al fine di garantire tempi rapidi di costruzione, è stato realizzato con struttura mista con un “nucleo” interno in calcestruzzo armato (che funge anche da massa termica) e un involucro prefabbricato di legno, altamente isolato Tutto il nuovo edificio risponde a standard passivi, raggiunti grazie a una buona geometria dei volumi, all’involucro performante nonché a un concetto di ventilazione ottimizzato
Con un costante ed efficiente controllo dei costi, inoltre, si è potuto risanare termicamente la palestra esistente e riqualificarne le aperture vetrate dotandole anche di brise-soleil orizzontali.

scuola materna
asilo nido
scuola elementare (nuovi edifici) foyer
collegamenti tra i volumi edifici esistenti (palestra e scuola elementare)
pianta piano terra
sezione AA
Struttura e involucro
La struttura portante dell’edificio è realizzata con un sistema misto in legno e c a che ha permesso una costruzione veloce, riducendo così al minimo il disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche. Grazie al principio costruttivo chiaro e alla semplice geometria dell’edificio, inoltre, è stato possibile realizzare un isolamento pressoché privo di ponti termici
Le parti dell’edificio a contatto con il terreno, così come i vani ascensore con le scale e i solai del piano terra e del primo piano, nonché gli elementi portanti sottostanti, sono stati realizzati in c a e fungono anche da massa per l’accumulo termico
Il solaio contro terra è stato realizzato sopra 40 cm di isolamento in vetro cellulare, mentre perimetralmente le fondazioni sono coibentate con XPS
Le pareti esterne sono realizzate con un sistema a telaio di legno prefabbricato, isolate con pannelli di lana di roccia di 28 cm di spessore (λ 0,34) inseriti tra i montanti della struttura Una controparete interna funge da vano tecnico per il passaggio impianti (8 cm di spessore) riempito a sua volta con lana di roccia Esternamente è stato posato un cappotto in pannelli di lana di roccia (spessore 8 cm), rivestiti su un lato e resistenti agli urti (λ 0,36), che fanno da supporto all’intonaco di finitura
Pannelli di lana di roccia (30 cm di spessore) sono stati utilizzati anche per l’isolamento del tetto verde estensivo
L’impiego della lana di roccia, dovuto al rispetto della normativa antincendio, ha consentito anche un miglior livello di isolamento acustico delle pareti mentre nei solai, per l’isolamento dai rumori da calpestio, è stato utilizzato un pannello apposito di lana minerale non infiammabile
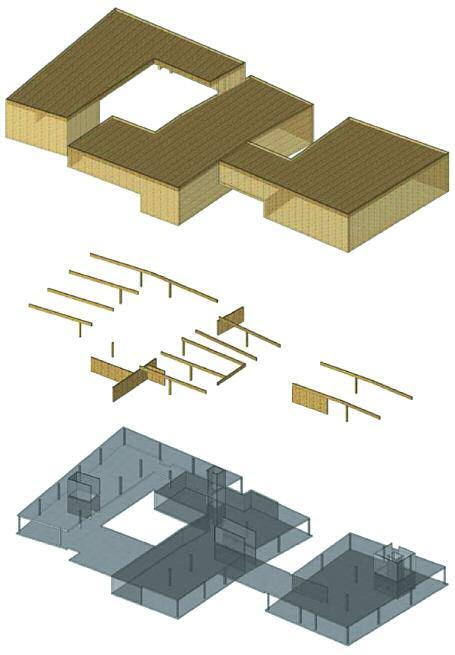
A zoccolo in c.a.; il solaio del primo piano poggia su pilastri in c a ; il rinforzo dell’appoggio avviene attraverso i vani scala/ascensori
B elementi portanti in legno interni
C l’involucro esterno prefabbricato ha struttura di legno a telaio coibentato tra i montanti; il tetto piano è in X-Lam
1 cucina
2 ingresso alla scuola materna
3 ingresso all’asilo nido
4 ingresso alla scuola elementare per i diversamente abili
5 ingresso alla sala polifunzionale/ palestra/scuola elementare
6 scuola elementare esistente
7 sala polifunzionale/ palestra esistente
8 entrata principale scuola elementare
Grazie alla geometria semplice e chiara dei volumi e al sistema costruttivo scelto non si manifestano quasi punti critici dal punto di vista fisico (ponti termici)
1 copertura con struttura portante in legno (X-Lam) 2 solaio interpiano in c a 3 piattaforma di fondazione isolata con vetro cellulare
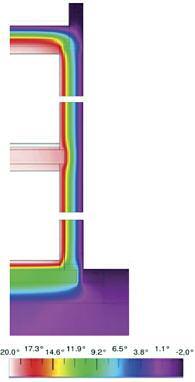
Progetto Arge MAGK illiz/ MAGK architektur aichholzer I klein
ZT OG, Wien (A); illiz architektur, Wien (A) - Zürich (CH)
Strutture RWT plus ZT GmbH, Wien (A)
Direttore dei lavori MAGK-illiz
Superficie fondiaria 9 554 m2
Superficie utile 4.100 m2
Superficie verde 5 262 m2
Costi 8,5 milioni di Euro
1 aria in entrata/ in uscita
2 aperture per la ventilazione naturale
3 aria in entrata
4 classe
5 fessura acustica
6 corridoio
7 aria in uscita
VMC nelle classi
L’impianto di VMC con recupero di calore in tutte le classi dei nuovi volumi garantisce un ricambio d’aria costante e il riscaldamento degli ambienti, mentre in estate un sistema di ventilazione naturale notturna raffredda la massa delle strutture evitando il surriscaldamento
Affinché l’aria viziata possa fuoriuscire dalle classi, è stata realizzata un’apertura acusticamente isolata di ca 0,5 m2 tra il corridoio e l’aula senza che ci sia un disturbo di tipo acustico tra questi due ambienti o tra una classe e l’altra
Un altro vantaggio della soluzione adottata è rappresentato, in estate, dalla possibilità, in combinazione con i lucernari aperti, di avere una ventilazione trasversale notturna, che consente un migliore effetto di raffrescamento grazie al maggiore passaggio d’aria

Sopra, la copertura in X-Lam con i lucernari utilizzati anche per la ventilazione notturna.
Sotto, la struttura portante in legno che ospiterà i serramenti in fase di realizzazione e a lavori conclusi


Risanamento dei serramenti
La struttura vetrata con serramento in legno presente nel corpo esistente che ospita la sala polifunzionale è stata risanata conservandone le parti principali Davanti al vecchio serramento in legno è stata posizionata una costruzione leggera in legno-alluminio-vetro: sopra e sotto di essa corrono due fasce di lamelle, tra le quali si collocano dei vetri di sicurezza di grande formato Questa soluzione ha permesso di recuperare serramenti non più performanti ma ancora in buono stato di conservazione
1 La costruzione in legno è esposta alle intemperie: perdite energetiche dovute ai vetri non attuali;
2 Lo strato d’aria tra serramento e vetro antistante svolge la funzione di isolante termico (lamelle chiuse): riduzione delle perdite di calore;
3 Il passaggio dell’aria nella parte anteriore impedisce il surriscaldamento estivo del vetro (lamelle aperte); la protezione dal sole collocata internamente è protetta dalle intemperie;
4 La corrente ascensionale di aria calda induce una ventilazione naturale della sala polifunzionale (lamelle aperte e alette aperte).
Copertura, dall’estradosso:
- substrato (10 cm)
- impermeabilizzazione antiradice (0,4 cm)
- isolamento in lana di roccia (30 cm)
- barriera al vapore (0,4 cm)
- solaio in legno massiccio tipo “Brettstapel”, con pendenza (24 cm)
- isolamento in lana di roccia (3 cm)
- cartongesso, controsoffitto acustico (1,5 cm)
Solaio primo piano, dall’estradosso:
- pavimento in pietra artificiale (4 cm)
- massetto di cemento (6 cm)
- membrana in PE (0,02 cm)
- isolamento dai rumori da calpestio (2,5 cm)
- riempimento (4,5 cm)
- solaio in c a (30 cm)
1 facciata vetrata con serramento in legno-alluminio su struttura di telaio in legno
2 elemento finestrato: alluminio rivestito
3 cassonetto per alloggiamento protezione dal sole
Dall’alto: il posizionamento in cantiere delle pareti prefabbricate con struttura di legno a telaio; la realizzazione dell’isolamento a cappotto; la copertura piana dall’intradosso, a destra è visibile uno dei lucernari apribili nella stagione estiva per favorire la ventilazione naturale passante



3
della facciata della scuola materna sul cortile interno
dettaglio

Sul tetto della palestra esistente è stato installato un impianto fotovoltaico, integrato architettonicamente
INVOLUCRO
trasmittanza media elementi costruttivi
pareti esterne, U = 0,097 W/m2K
solaio controterra, U = 0,116 W/m2K
copertura, U = 0,101 W/m2K serramenti, Uw = 1,00 W/m2K
IMPIANTI
fotovoltaico teleriscaldamento a biomassa (cippato) ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e scambiatore di calore rotativo con recupero dell’umidità riscaldamento a pavimento solo in caso di necessità poiché il riscaldamento avviene attraverso il sistema di VMC
Parete esterna, dall’esterno:
- intonaco (0,7 cm)
- isolamento in lana di roccia (8 cm)
- pannello in cartongesso (1,5 cm)
- isolamento in lana di roccia tra i montanti della struttura in legno (28 cm)
- pannello OSB (1,5 cm)
- freno al vapore (0,4 cm)
- vano per passaggio impianti + isolamento in lana di roccia (8 cm)
- cartongesso resistente al fuoco (2,5 cm)
1 finestra in legno-alluminio
2 lamiera di alluminio rivestito (0,3 cm)
3 doppio strato bituminoso (0,8 cm)
4 isolamento in lana di roccia (14 cm)
5 barriera al vapore (0,4 cm)
6 struttura in legno multistrato (9,5 cm)
7 isolamento (4 cm)
8 cartongesso resistente al fuoco (1,3 cm)
9 laminato (2,2 cm)

Sotto, a sinistra, un interno delle aule al primo piano; a destra, la realizzazione di uno dei cubi che “sporgono” in facciata e la posa del cappotto esterno in lana di roccia.

dettaglio della facciata con lo sporto

IL RAFFRESCAMENTO PASSIVO DEGLI EDIFICI
Il contesto
I consumi energetici nel settore civile in Italia
Nel 2010 i consumi energetici del settore civile (residenziale e terziario) sono stati pari a 49,1 Mtep (+5,9 rispetto al 2009) e l’intensità energetica si è attestata a 39,9 tep/M€00 (+4,6%) L’intensità energetica del settore civile, nel periodo 2000-2010, ha registrato nel suo complesso un incremento di circa il 21%, trainata dall’aumento dei consumi di gas e di energia elettrica
In particolare, nel settore elettrico, l’incremento è rappresentato dalla diffusione degli impianti di climatizzazione estiva con una stima di 1 milione di nuove installazioni/anno di condizio-
Le tecniche di raffrescamento passivo di un edificio rapresentano una valida alternativa agli impianti di climatizzazione, contribuendo al risparmio di energia elettrica e alla riduzione delle immisioni di gas serra. In due appuntamenti approfondiamo il tema, a partire dalle tecnologie di controllo solare delle chiusure opache e trasparenti.
Mario Grosso
Professore Associato, Dip di Architettura e Design, Politecnico di Torino

Nella scuola secondaria di primo grado
“L Orsini”, Imola (foto Andrea Dal Fiume) sono state adottate tecniche di controllo solare e di raffrescamento passivo
Sopra, ingresso ovest e lato nord; nella pagina a lato, controllo solare sul lato sud con sporti e schermature esterne
natori e con una valutazione sul numero condizionatori installati nel 2011 che si attesta intorno a 14 milioni di unità1
Il trend di crescita del consumo di energia elettrica ha interessato in modo particolare il settore terziario, con un incremento del 1,4% nel 2010 rispetto al 2008 e 4,1% di intensità elettrica Tale tendenza, in contrasto con quella, in diminuzione, dei consumi per riscaldamento nel settore civile, risente dell’effetto di riscaldamento globale dell’atmosfera causato dalla crescente concentrazione di gas serra – connesso all’utilizzo di combustibili fossili – che ha raggiunto la soglia critica di 400 parti per milione
L’impiego di tecnologie alternative di climatizzazione, quali quelle illustrate in questo articolo, può contribuire ad abbassare il consumo finale di energia elettrica per il condizionamento dell’aria e, quindi, ridurre il corrispondente quantitativo di gas serra connesso all’utilizzo prevalente di combustibili fossili nella produzione di energia elettrica in Italia
La Direttiva 2010/31/EU sulla prestazione energetica degli edifici
La Direttiva 2010/31/EU sulla prestazione energetica degli edifici – revisione della precedente Direttiva sull’argomento – fa compiere un balzo decisivo ai Paesi Membri nella direzione della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica degli edifici. All’articolo 9, infatti, stabilisce che: a) dal 31 dicembre 2020, tutti i nuovi edifici debbano essere a “energia quasizero”; b) dal 31 dicembre 2018, i nuovi edifici occupati e di proprietà di Enti Pubblici debbano essere a “energia quasi-zero” In aggiunta dovranno essere implementate strategie atte a favorire la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a “energia quasi-zero” La definizione di edificio a “energia quasi-zero,” e la determinazione dei relativi fattori per il calcolo dell’indicatore di consumo d’energia primaria (kWh/m2 anno), sono demandati agli Stati Membri, tenendo conto delle condizioni locali e basandosi su dati medi nazionali o regionali, nonché sulle normative europee.
Con l’applicazione di tale direttiva dovranno essere abbassati di molto i limiti della prestazione energetica per il raffrescamento estivo, stabiliti dal D P R 2 aprile 2009, n 59, all’art 4, c 3: a) 40 kWh/m2anno e 14 kWh/m3anno nelle zone climatiche A e B, rispettivamente, per gli edifici residenziali e terziari; b) 30 kWh/m2anno e 10 kWh/m3anno nelle zone climatiche C, D, E, e F, rispettivamente, per gli edifici residenziali e terziari
L’impiego di strategie e tecnologie per il raffrescamento passivo diverrà, quindi, obbligatorio e non più solamente opzionale, com’è oggi, nel caso in cui sia prevista – in norme inserite nella Legislazione Regionale o in Regolamenti Edilizi Comunali – la possibilità di rispondere a requisiti volontari sul risparmio energetico in cambio di incentivi volumetrici o finanziari
Strategie e tecnologie di raffrescamento passivo
Le strategie e le tecnologie di raffrescamento passivo degli edifici si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie
a) Controllo termico, inteso come regolazione del calore introdotto nell’edificio per effetto della radiazione solare e degli scambi convettivi, nonché degli apporti termici interni, prima che tale calore abbia fatto salire la temperatura dell’aria interna oltre il limite superiore della zona di comfort e/o si sia accumulato nella massa muraria (pareti, solai, partizioni) In particolare, in funzione del tipo di scambio termico, il controllo termico riguarda la trasmissione per:
a1) conduzione e re-irraggiamento attraverso l’involucro opaco (inerzia termica);
a2) conduzione e re-irraggiamento attraverso l’involucro trasparente;
a3) convezione per ventilazione attraverso le aperture;
a3) apporti termici interni
b) Raffrescamento naturale, riferito a tecniche di dissipazione del calore verso pozzi naturali, quando si sia già prodotto un innalzamento della temperatura dell’aria interna, oltre il limite superiore della zona di comfort, e/o il calore in eccesso si sia già accumulato nella massa muraria dell’edificio In funzione dei pozzi termici utilizzati, si distinguono i seguenti tipi di raffrescamento:

Interno della scuola secondaria di primo grado “L Orsini”, Imola (foto Andrea Dal Fiume) Lo spazio centrale a tutta altezza che unisce i due corpi dell’edificio è illuminto zenitalmente e dotato di sistemi di estrazione del calore
b1) raffrescamento microclimatico, se il pozzo termico è l’aria esterna, a temperatura inferiore a quella dell’aria interna e al limite superiore della zona di comfort;
b2) raffrescamento geotermico, se il pozzo termico è il terreno, con scambio termico attraverso il passaggio di un fluido (acqua o aria) in condotti interrati;
b3) raffrescamento evaporativo, se il pozzo termico è acqua nebulizzata nel flusso d’aria d’ingresso in ambiente, che è raffreddata nel meccanismo di evaporazione;
b4) raffrescamento radiativo, se il pozzo termico è il cielo notturno – considerato con caratteristiche di assorbimento per irraggiamento vicine a quelle del corpo nero – che scambia con le superfici esterne dell’involucro edilizio, in particolare, quelle in copertura, in condizioni di cielo sereno e bassa umidità relativa dell’aria.
Quando tali tecniche utilizzano, come fluido termo-vettore, l’aria, i sistemi relativi si identificano come sistemi di raffrescamento ventilativo
Nelle pagine che seguono sono illustrati le tecnologie di controllo solare e i sistemi di raffrescamento ventilativo microclimatico e geotermico; quelli più idonei, tra le tecniche di raffrescamento naturale sopra descritte, alle zone climatiche italiane. Per una descrizione degli altri tipi di tecnologie e sistemi si rimanda alla bibliografia [Grosso, 2011]
Tecnologie di controllo solare
Le tecnologie di controllo solare2 sono riferite alle caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio e devono conciliare le esigenze di riscaldamento con quelle di raffrescamento, di natura opposta, al fine di raggiungere condizioni di comfort termico e visivo in ogni periodo dell’anno
Le componenti di involucro interessate sono sia le chiusure opache, sia quelle trasparenti.
Chiusure opache
La radiazione solare che colpisce una superficie opaca, in funzione delle caratteristiche di finitura superficiale, viene in parte riflessa e in parte assorbita La quota assorbita provoca un incremento della temperatura della superficie esterna che, d’inverno, determina un’attenuazione del flusso termico per trasmissione e la conseguente riduzione delle dispersioni di calore, mentre d’estate e nelle stagioni intermedie – quando la

Descrizione/ Composizione
Metallo, piastra
- solfuro nero
- ossido di cobalto nero
- ossido di nichel nero
- cromo nero
Vernici
- nera
- bianca acrilica
- bianca, ossido di zinco
Carta bianca
Tegole per tetto, rosso vivo
- superficie secca
- superficie umida
Sabbia secca
- bianco brillante
- rosso opaco
Neve - fresca - ghiacciata
Acciaio
- finito a specchio
- arrugginito
Pietra rosacea
Legno
Coefficiente di assorbimento solare αs [ ] 0,92
V C Sharma, A Sharma, Solar Properties of Some Building in Energy, 1989, vol 14, pp 805-810)
Indicatori
S > 12 Fd < 0,15 12 > S > 10 0,15 < Fd < 0,30 10 > S > 8 0,30 < Fd <0,40 8 > S > 6 0,40 < Fd < 0,60 6 > S 0,60 < Fd
Qualità prestazionali
ottime Classe I
buone Classe II
medie Classe III sufficienti Classe IV mediocri Classe V
Tabella 2 – Rapporto tra sfasamento, fattore di attenuazione e qualità prestazionali degli edifici secondo D M S E 26/6/2009 e s m i
Tabella 1 – Valori dei coefficienti di assorbimento solare (onde corte) ed emissività (onde lunghe), per alcuni materiali (Fonte:
Sezione schematica di un sistema costruttivo dell’involucro a “doppia pelle” ventilata, per la riduzione della temperatura superficiale
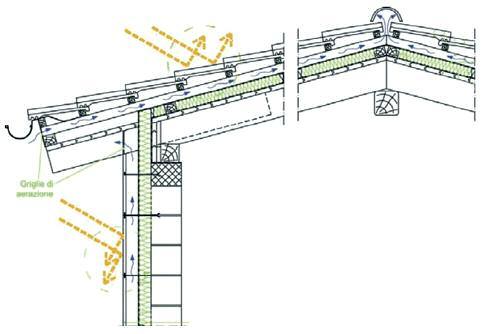
temperatura esterna è superiore a quella degli ambienti interni – origina un flusso termico di verso opposto rispetto alle dispersioni, determinando un incremento degli apporti gratuiti
Il controllo degli apporti solari attraverso le chiusure opache risulta, pertanto, necessario ai fini della riduzione del carico termico estivo che, nelle condizioni climatiche italiane, interessa maggiormente le chiusure superiori (coperture inclinate o piane), rispetto a quelle verticali, a causa della maggior incidenza della radiazione solare nei periodi caldi
Le principali strategie attuabili per una riduzione del carico termico degli ambienti interni nella stagione estiva sono:
a) controllo della temperatura superficiale;
b) controllo dell’inerzia termica
Il controllo della temperatura superficiale può essere attuato attraverso:
a) scelta di una finitura della superficie esterna con bassi valori di assorbimento solare e emissività (generalmente, associati a superfici chiare e lisce) (tab 1 a pag 50);
b) realizzazione di una discontinuità tra gli strati nella parte esterna della chiusura, tramite l’interposizione di un’intercapedine d’aria ventilata (immagine in alto a pag 50);
d) utilizzo di elementi di schermatura della radiazione solare.
Il controllo dell’inerzia termica di un componente opaco può essere attuato attraverso la valutazione di due caratteristiche: lo sfasamento termico e l’attenuazione, o smorzamento Tali caratteristiche possono essere rispettivamente definite come la capacità a ritardare, e a ridurre, l’effetto di una sollecitazione, flusso termico o variazione di temperatura, tra le due facce del componente stesso. Se si considera, ad esempio, il flusso termico generato dalla radiazione solare che incide sulla superficie esterna di un componente opaco, si può affermare che esso raggiungerà la superficie opposta, ossia quella interna, con un certo ritardo temporale, per effetto dello sfasamento, e con intensità ridotta per effetto dell’attenuazione
Al fine di ottimizzare le prestazioni dell’involucro, durante il periodo estivo, occorre progettare chiusure opache caratterizzate da un’elevata attenuazione e da uno sfasamento pari a circa 12 ore Tale configurazione permette, infatti, di ridurre la potenza del flusso termico e farlo giungere sulla superficie interna nelle ore più fresche (notturne), quando può essere facilmente dissipato attraverso la ventilazione degli ambienti
Riferimenti normativi
Il DRP 2/4/2009, n 59 all’Art 4 – Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti – al C 18-b) recita:
[...] il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti, esegue [ ] in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, sia maggiore o uguale a 290 W/m2:
a) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nordest, almeno una delle seguenti verifiche:
a1) che il valore della massa superficiale Ms sia superiore a 230 kg/m²;
a2) che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia inferiore a 0,12 W/m²K;
e) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui al comma 4, dell’articolo 2, sia inferiore a 0,20 W/m2K [ ] La trasmittanza termica periodica Yie = UxFd è definita come il prodotto tra il fattore di attenuazione Fd e la trasmittanza termica stazionaria U [W/m2K] e rappresenta sia il grado di smorza m en to, sia quello di sfa sa m en to dell’onda termica proveniente dall’esterno
Il D M S E 26/6/2009 e s m i – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici – rimanda, per quanto riguarda la verifica prestazionale delle chiusure opache, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti, a un metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi, che utilizza gli indicatori sopra menzionati e così definiti (UNI EN ISO 13786):
- il fattore di attenuazione o fattore di decremento (Fd) è il rapporto tra il modulo della trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie; - lo sfasamento è il ritardo temporale (ore) tra il massimo del flusso termico entrante nell’ambiente interno e il massimo della temperatura dell’ambiente esterno
Sulla base dei predetti indicatori, la norma individua la classificazione come indicato in tabella 2.
Tabella 3 – Coefficiente di trasmissione luminosa di alcuni tipi di vetratura (Fonte: Manuale del vetro, Saint Gobain Glass, 2000)
Tipo componente
Lastra
vetro chiaro, 4 mm
vetro chiaro, 8 mm
vetro riflettente, argento (1) , 6 mm
vetro colorato, bronzo (2) , 8 mm
Vetro camera
vetro chiaro + chiaro (3) , 4/15/4
vetro chiaro + chiaro b e (4) , 4/15/4 con aria
vetro chiaro + chiaro b e (4) , 4/15/4 con argon
vetro chiaro + riflettente (5) , 8/12/8 con aria
(1) SGG COOL-LITE SS 132;
(2) SGG PARSOL;
(3) SGG CLIMALIT;
(4) SGG CLIMAPLUS;
(5) SGG CLIMALIT SOLAR CONTROL con STARELIO
Nelle stratigrafie a lato sono rappresentati esempi di chiusure opache caratterizzate da classi prestazionali differenti
Chiusure trasparenti
Gli effetti della radiazione solare che attraversa le chiusure esterne trasparenti sono più evidenti rispetto a quelle opache: i problemi relativi al comfort e ai consumi energetici per il raffrescamento sono più rilevanti ma, nel contempo, sono più consistenti gli apporti gratuiti che possono essere sfruttati durante il periodo invernale
La funzione di controllo solare attraverso le chiusure trasparenti interessa, quindi, la quantità di radiazione incidente, la conseguente quota trasmessa e quella assorbita e accumulata dalle superfici all’interno, che dipende dai seguenti parametri.
Geometria d’involucro
1) le dimensioni, quindi l’area della chiusura trasparente; 2) l’esposizione alla radiazione solare, cioè l’inclinazione e l’orientamento;
3) la posizione rispetto all’ambiente interno, ossia la collocazione in pianta e l’altezza dal pavimento
Proprietà termofisiche e ottico-solari
1) trasparenza alla radiazione, alle varie lunghezze d’onda, espressa dai fattori di trasmissione solare e di trasmissione luminosa (tab 3), anche in relazione all’impatto visivo e all’integrazione architettonica;
2) resistenza termica del componente trasparente (tab 4) e del relativo telaio;
3) caratteristiche di assorbimento e di accumulo delle superfici interne soleggiate
Tabella 4 – Coefficiente di trasmittanza termica di alcuni tipi di vetratura
Tipo componente
Lastra
vetro chiaro, 4 mm
vetro chiaro, 8 mm
vetro riflettente, argento (1) , 6 mm vetro colorato, bronzo (2) , 8 mm
Vetro camera
vetro chiaro + chiaro (3) , 4/15/4 vetro chiaro + chiaro b e (4) , 4/15/4 con aria vetro chiaro + chiaro b e (4) , 4/15/4 con argon vetro chiaro + riflettente (5) , 8/12/8 con aria U
(1) SGG COOL-LITE SS 132; (2) SGG PARSOL; (3) SGG CLIMALIT; (4) SGG CLIMAPLUS; (5) SGG CLIMALIT SOLAR CONTROL con STARELIO
Rappresentazione schematica della stratigrafia di una parete, con le caratteristiche dimensionali e i valori dei principali parametri termofisici: configurazione di riferimento (Benchmark)
Doppio tavolato in laterizio forato con isolante nell’intercapedine d’aria
Dati generali
Spessore totale 0,373 m
Massa superificiale 200,7 kg/m2
Massa superficiale esclusi intonaci 149,7 kg/m2
Resistenza 2,97 m2K/W
Trasmittanza
Malta di cemento
Laterizi forati, 12 cm (rif 1 1 21)
Polistirene espanso in lastre stampate per termocompressione
Camera non ventilata
Laterizi forati, 8 cm (rif 1 1 19)
Intonaco di calce e gesso
Parameteri dinamici
Trasmittanza periodica
Fattore di attenuazione
Sfasamento
Capacità interna
Capacità esterna
(1) CLASSE IV
Valori invernali
0,191 W/m2K
0,567(1)
7h 14'(1)
50,6 kJ/m2K 74,0 kJ/m2K
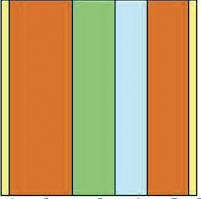
0,176 W/m2K
0,522(1)
7h 41'(1)
Valori estivi
Rappresentazione schematica della stratigrafia di una parete con le caratteristiche dimensionali e i valori dei principali parametri termofisici: configurazione con prestazioni tra buono e ottimo.
Bitume polimero su PPL, 4 mm
Polietilene espanso estruso in continuo non reticolato
Foglio in P E , 1,6 mm
Blocchi legno cemento con isolante
Malta di gesso per intonaci o in pannelli
Parameteri dinamici
Trasmittanza periodica
Fattore di attenuazione
Sfasamento
Capacità interna
Capacità esterna
(1) CLASSE I
(2) CLASSE II
Valori invernali
0,000 W/m2K
0,000(1) 11h 50'(2)
39,8 kJ/m2K 8,6 kJ/m2K Valori estivi 0,000 W/m2K 0,000(1) 11h 51'(2) 40,2 kJ/m2K 8,5 kJ/m2K

Blocchi legno cemento ISOTEX 36 + PEE con vegetazione in facciata
Dati generali
Rappresentazione schematica della stratigrafia di una parte d’involucro (parete e tetto), con le caratteristiche dimensionali e i valori dei principali parametri termofisici: configurazione con prestazioni ottimali
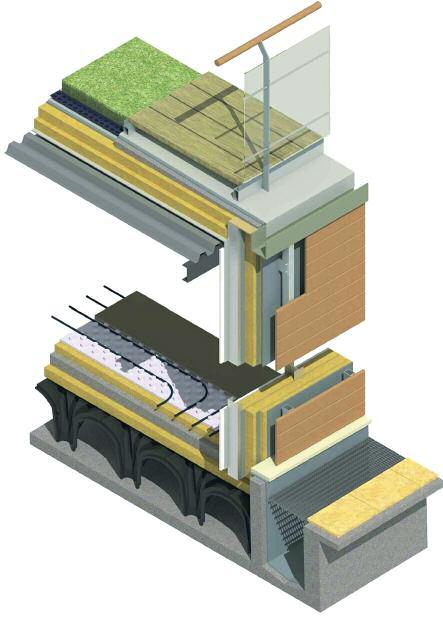
Pannello di legno tra lastre di alluminio con facciata ventilata
Dati generali
Spessore totale 0,372 m
Massa superificiale 131,1 kg/m2
Massa superficiale esclusi intonaci 110,1
(m)
Polimetilmetacrilato (PMMA)
Camera debolmente ventilata
Bitume polimero su V V , 3,2 mm
Alluminio
Pannelli di lana di legno con leganti
inorganici
Alluminio
Intonaco di calce e gesso
Parameteri dinamici
Trasmittanza periodica
Fattore di attenuazione
Sfasamento
Capacità interna
Capacità esterna
(1) CLASSE I
Valori invernali
0,039 W/m2K
0,117(1) 15h 36'(1)
38,6 kJ/m2K 36,8 kJ/m2K Valori estivi 0,038 W/m2K
15h 48'(1) 39,0 kJ/m2K 35,0 kJ/m2K
Spessore
Utilizzo di schermi
1) tipologia e caratteristiche delle schermature, quali la geometria e la tecnologia, il tipo di gestione, il materiale e la finitura, anche in relazione all’impatto visivo e all’integrazione architettonica e tecnologica (vedi immagini in pagina a fianco)
Contributo delle tecnologie di controllo solare all’efficienza energetica
Le tecnologie di controllo solare sopra descritte hanno un impatto positivo sull’incremento di efficienza energetica di un edificio, dipendente da diversi fattori, tra cui i più importanti sono: le caratteristiche climatiche della località in cui l’edificio è situato; la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo e gestione operativa dell’edificio stesso
Per valutare l’efficacia del contributo dei sistemi di controllo solare nel ridurre il carico termico di climatizzazione estiva (scambio sensibile) di un edificio, è necessario compiere, su situazioni esistenti o di progetto, simulazioni di tipo parametrico tramite l’utilizzo di programmi di calcolo dinamico, basati su dati orari dell’anno tipo, quali TRNSYS e Design Builder con Energy Plus Il monitoraggio sul campo risulta, invece, particolarmente complesso, considerata la variabilità e la dipendenza dalla gestione dell’utente dei sistemi di controllo solare delle chiusure trasparenti (schermi) o l’impossibilità di eseguire confronti in parallelo – tra configurazioni di progetto e benchmark – per quanto riguarda il contributo della massa termica
Da un’analisi parametrica svolta utilizzando il programma di calcolo on-line S P E R Aven t3 , su un caso studio relativo a un’unità abitativa di un edificio residenziale multipiano, localizzato a Torino, si è potuto evidenziare l’efficacia ai fini della riduzione del fabbisogno termico di raffrescamento: sia dei sistemi di schermatura sia della consistenza della massa termica, nell’involucro e nelle partizioni interne come evidenziato nei grafici a lato
Note
1 - ENEA, Rapporto Energia e ambiente 2009-2010, pp 61-62
2 - Raimondo, L (2011) “Il controllo termico della radiazione solare”, in: Grosso, M , Op cit Cap VII, pp 281-326
3 - Programma sviluppato attraverso la collaborazione di Mario Grosso e Luca Raimondo – ideatori e curatori della base di calcolo e di interfaccia – con Luca Colombaro e Andrea Deganutti – realizzatori e sviluppatori della parte informatica
Bibliografia
Grosso, M (2011) Il raffrescamento passivo degli edifici in zone a clima temperato, III ed , Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), IT Grosso M , Raimondo L , Colombaro L , Deganutti A , (2010) SPERAVent, Linee guida per il calcolo della riduzione potenziale di fabbisogno termico netto di climatizzazione estiva, tramite raffrescamento ventilativo microclimatico, www speraweb/vent, Torino
Variazione della riduzione, in % (asse delle ordinate), del fabbisogno d’energia netta per raffrescamento (a monte degli impianti), in rapporto all’incremento del coefficiente di ombreggiamento da schermature (asse delle ascisse), in un appartamento di un edificio multipiano, localizzato in Torino (Zona climatica E, Lat. 45° N).
Variazione della riduzione, in % (asse delle ordinate), del fabbisogno d’energia netta per raffrescamento (a monte degli impianti), in rapporto all’incremento della capacità termica areica dell’involucro e delle partizioni interne), in un appartamento di un edificio multipiano, localizzato in Torino (Zona climatica E, Lat 45° N)
A sinistra in alto –Edificio con ventilazione naturale controllata con funzione di Raffrescamento Ventilativo Microclimatico (notturno).
A sinistra in basso –Edificio con ventilazione meccanica ad un tasso di portata d’aria minimo per il ricambio igienico-sanitario



Sopra, tipologia di schermi a pannelli orizzontali operabili, con superificie ricoperta da film sottili fotovoltaici Sotto, applicazione degli schermi nel progetto Consorzio X-service, Pinerolo (TO); progetto: arch Chiabrando (immagini e fotografie: merlo srl, Orbassano TO www merlosrl com)

involucro colore e rendimento energetico
Fausto Barbolini
Architetto, Docente a contratto e Dottorando di Ricerca in Architettura presso l’Università di Bologna
Luca Guardigli
Ingegnere, Ricercatore in Architettura Tecnica presso l’Università di Bologna
COLORE ED EFFICIENZA ENERGETICA
GLI EFFETTI DELLE SCELTE
CROMATICHE SUL RENDIMENTO
DELL’INVOLUCRO
La progettazione dei componenti attivi e passivi d’involucro deve tener conto anche delle scelte sul colore, poiché queste possono influenzare fortemente il rendimento energetico dell’edificio. Un’analisi dei componenti passivi dell’involucro edilizio e delle implicazioni in termini di “risposta energetica” dello stesso.

Nella progettazione architettonica le scelte cromatiche derivano prevalentemente da ragioni estetiche, sebbene abbiano implicazioni dirette sull’efficienza energetica dell’edificio Il progetto delle componenti d’involucro richiede invece, oggi in particolar modo, un’analisi accurata delle caratteristiche cromatiche dell’edificio o, comunque, una riflessione preliminare sugli effetti che scelte sbagliate o poco ponderate possono provocare. Sempre più l’applicazione dei concetti legati all’efficienza energetica sta condizionando la colorazione degli edifici, soprattutto delle coperture I risultati sono non del tutto controllati e a volte inattesi Si pensi ad esempio all’introduzione dei nuovi componenti
solari attivi, come i pannelli fotovoltaici (FV), che diffusamente stanno mutando drasticamente la resa cromatica e la percezione degli involucri, richiedendo riflessioni approfondite sul concetto di progetto integrato
Il “progetto del colore” in architettura deve quindi essere considerato – e attentamente valutato – fin dalla fase preliminare nel sistema di scelte che indirizzano la concezione dell’involucro Esso influenza allo stesso livello, sia come giustapposizione di sistemi attivi di sfruttamento di energia rinnovabile che di mero rivestimento superficiale, la risultanza estetica e la risposta energetica dell’edificio sottoposto alle sollecitazioni del-


Edificio PEEP a Bomporto (MO), 2012
Progetto: Lipparini Architetti Associati+arch F Barbolini, Modena
In basso: casa passiva a Modena. Il colore bianco e il tetto verde contribuiscono al controllo del comfort interno in regime estivo
l’ambiente circostante Il colore, in definitiva, rappresenta la “prima barriera” tra lo spazio confinato e l’ambiente esterno e ne influenza la risposta energetica come primo elemento “regolatore” dei flussi termici che interessano l’edificio
La ricerca scientifica come proponente e il sistema produttivo come recettore stanno portando avanti una riconsiderazione delle qualità dei diversi cromatismi abbinabili ai sistemi attivi e passivi, che supportano il progetto di architettura sostenibile e a basso consumo energetico Sappiamo che il colore è una rappresentazione al nostro occhio della sola porzione della luce visibile, mentre la radiazione solare comprende altre lunghezze d’onda, tra cui l’infrarosso e l’ultravioletto; tuttavia, una relazione diretta tra il riscaldamento e il raffrescamento di una superficie e la sua tipologia di colorazione esiste
La temperatura raggiunta dalla superficie di un involucro opaco esposto al sole determina la quantità di calore che può successivamente entrare all’interno dell’edificio. Escludendo le tecniche legate all’utilizzo di sistemi schermanti sovrapposti o integrati nell’involucro, per ridurre una temperatura superficiale eccessiva durante l’estate, non si può che agire sulla finitura della superficie esterna; essa è caratterizzata dal tipo di materiale, dalla sua rugosità (o texture superficiale) e, appunto, dal suo colore In genere, superfici scure e rugose si scaldano più di quelle chiare e lisce
Un primo parametro da considerare nella progettazione croma-

tica di un edificio riguarda dunque la capacità di assorbimento della radiazione da parte dell’involucro opaco, valutabile attraverso il coefficiente di assorbimento (o assorbanza solare) che varia da 0 a 1; nella misura dell’incidenza di questo fattore, assumono un peso fondamentale la qualità e la tipologia cromatica della finitura superficiale Per esempio una vernice bianca ha un valore intorno allo 0,20 (o 20%) in base alle componenti presenti; una vernice nera può arrivare a un valore di 0,95 Un secondo parametro è il concetto di riflettanza solare che rappresenta la frazione di radiazione solare incidente direttamente riflessa da una superficie irradiata; il suo valore varia da 0 a 1, oppure spesso viene espresso in percentuale Questi due parametri, in pratica inversamente proporzionali uno rispetto all’altro, diventano perciò gli aspetti più importanti da tenere in considerazione nella scelta “energeticamente mirata” di un colore superficiale, dato un certo materiale di supporto: quest’ul-

Nel 2010 è stata condotta dall’Enea una simulazione con software TRNSYS su modelli di edifici a schiera e isolati situati in varie città del Mediterraneo
Il caso più significativo è un edificio a schiera situato a Palermo e dotato di basso isolamento (valore U dell’involucro mediamente pari a 1,4 W/m2K)
Aumentando la riflettanza della copertura dal 20% all’80% con una vernice adatta, si ottiene un ottimo risultato: un decremento del carico termico per la climatizzazione estiva del 14% a fronte di un aumento del carico invernale del 4%, con un saldo netto di circa il 10%; tale saldo netto è simile per un edificio isolato a un piano.
Il saldo netto, vantaggioso per edifici situati nel Sud d’Italia e poco isolati, si riduce, per edifici sempre nel Sud ma già ben isolati, al 7%
timo inciderà invece maggiormente sull’assorbanza, in base alla più o meno marcata rugosità (ad esempio, intonaci più o meno “rustici” per lavorazione o per granulometria degli inerti d’impasto); la tinteggiatura, e conseguentemente la sua qualità cromatica, inciderà maggiormente sulla riflettanza, in relazione al diverso livello di opacità o brillantezza della vernice utilizzata In realtà vi è anche un terzo fattore da tenere in considerazione, definito come emissività, variabile anch’esso tra 0 e 1, che rappresenta la capacità di riemettere l’energia non riflessa ma assorbita da parte dell’elemento; un alto valore di emissività è positivo poiché tende a non sovraccaricare termicamente gli strati sottostanti
Di seguito sono riportate alcune considerazioni sul rapporto colore-efficienza energetica, suddivise nelle tre macro componenti d’involucro: coperture, pareti verticali opache, chiusure trasparenti
Sotto, da sinistra a destra: dettaglio della copertura con vernice riflettente argentata di una villetta unifamiliare a Modena e vista dell’edificio tinteggiato con colorazione RAL 9001 (progetto: arch F Barbolini, 2010); la facciata vetrata di un palazzo a Valencia.

Dallo studio si può dedurre molto sinteticamente che in edifici già ben isolati l’effetto delle vernici riflettenti è leggermente più basso rispetto a case mal protette.
In zone d’Italia con un valore più elevato di Gradi Giorno, l’effetto cool roof su edifici poco isolati potrebbe risultare meno incisivo perché l’incidenza della perdita di carico nelle stagioni invernali è prevalente Se il carico termico invernale fosse superiore del 40% rispetto alla situazione di Palermo, a parità di carico estivo e di isolamento, l’effetto benefico della vernice potrebbe, in certe condizioni, essere annullato dal peggioramento di comportamento in stagione invernale (Fonte: Zinzi M , Carnielo E Impatto di tecnologie cool roof sulle prestazioni energetiche di edifici residenziali in area mediterranea, rapporto di ricerca ENEA 2010)
Un toolkit di valutazione è disponibile nel sito del progetto europeo cool roofs: http://www. coolroofs-eu eu/ Per un edificio con prestazioni di involucro e di impianto di medio livello, il software dà il risultato di un risparmio significativo di decine di euro al metro quadro per anno, passando da un tetto a bassa pendenza nero a uno del tipo cool roof Ovviamente, ogni progetto va verificato nel dettaglio, per evitare di giungere a conclusioni semplicistiche
Effetti delle vernici riflettenti di tipo cool roofs nel nord e nel sud Italia
Vernice organica bianca con alcune variazioni cromatiche bianco verde rosso giallo bruno
Tabella 1 - Riflettanza Solare, Solar Reflectance (SR): a sinistra riflettanza solare di una vernice bianca con alcune variazioni cromatiche ; a destra riflettanza di alcuni materiali utilizzati in copertura. Fonte: ENEA 2010.
Componente
Vetro singolo
Vetro chiaro 4mm
Vetro riflettente (Argento)
Vetro camera
Vetro chiaro 4 mm + 15 mm aria + vetro chiaro 4 mm
Vetro chiaro 4 mm + 15 mm aria + vetro chiaro 5 mm basso emissivo
Vetro chiaro 8 mm + 12 mm aria + vetro 8 mm riflettente
Vetro chiaro 4 mm + 12 mm Ar + vetro 4 mm selettivo
Tabella 2 - Valori di fattore solare, trasmissione luminosa e indice di selettività per componenti vetrati.


Coperture
Tinteggiare le coperture di bianco, o di un colore chiaro, contribuisce d’estate a raffreddare gli edifici, soprattutto le coperture piane esposte alla radiazione solare e con finiture superficiali molto scure (come ad esempio i capannoni industriali o le coperture degli edifici urbani più estesi con guaine bituminose a vista) Esistono anche altri sistemi più raffinati e performanti per raffreddare le coperture, come il tetto-guardino o i tetti ventilati ma, in definitiva, le vernici sono più economiche e pratiche da applicare, specie nel campo del recupero edilizio; con questa semplice azione è possibile operare contestualmente un’azione di efficientamento energetico senza dover sovraccaricare le strutture esistenti e investire cifre consistenti Questa tecnica assume effetti considerevoli soprattutto se applicata in larga scala alle grandi conurbazioni, generalmente più calde rispetto alle zone rurali, a causa del fenomeno conosciuto come effetto “isola di calore” In esse sono misurabili
Test (temp. atmosferica esterna)
irradiazione solare raffreddamento per irraggiamento raffreddamento per convezione
T sup, est (temp. sup. esterna)
q (flusso termico netto entrante)
Tint (temp ambiente interna) (catramatura) (isolamento) (solaio)
T sup, int (temp sup interna)
aumenti di temperatura media anche di 1-3 °C, in alcuni casi con picchi anche maggiori, dovuti alla più alta concentrazione di volumi edilizi in sovraccarico termico e alla ridotta capacità di ventilazione naturale (si pensi alle città della pianura padana dove sono rare e limitate le brezze serali estive) Negli USA il National Center for Atmospheric Research (NCAR), che sostiene fortemente lo sviluppo di tetti bianchi (o più propriamente cool roofs – tetti freddi) come misura di risparmio energetico, afferma che se ogni tetto fosse interamente dipinto di bianco, l’effetto del calore urbano potrebbe essere ridotto fino al 33% Tutto ciò, in regime estivo, incide direttamente sul comfort termico degli edifici, e riduce conseguentemente il ricorso agli energivori impianti di condizionamento Questa semplice tecnica di efficientamento energetico legata al colore riprende quello che storicamente l’architettura e l’uomo hanno già realizzato in molte città dell’area sud-mediterranea e medio-orientale, dove la colorazione bianca predomina come elemento primario di percezione e, a livello funzionale, scherma l’ecces-
sivo irraggiamento solare riducendo il sovraccarico termico Ovviamente i tetti bianchi diminuiscono l’apporto energetico gratuito in fase invernale, aspetto negativo nei climi freddi tipici del Nord Europa o delle nostre regioni alpine, con il conseguente mancato apporto di riscaldamento passivo all’interno degli edifici In zone climatiche caratterizzate da inverni rigidi, il guadagno in estate può essere quindi annullato dalla perdita in inverno Nel caso di edifici fortemente isolati, a energia zero o passivi, considerando perciò spessori in copertura anche dell’ordine dei 30-40 cm, l’effetto della colorazione sulla risposta energetica dell’edificio assume caratteri più attenuati ma è importante considerare gli effetti che un eccessivo accumulo termico in fase estiva, soprattutto nei primi strati dell’isolante, può portare sottoforma di deformazioni dello stesso e di conseguenti fenomeni d’instabilità e degrado del supporto di finitura superiore (guaine o quant’altro) Una problematica importante è data inoltre dall’effetto, non trascurabile, di riflessione dell’irraggiamento solare dovuto al colore bianco, con fenomeni di abbagliamento sugli edifici adiacenti e negli spazi pubblici e privati dell’intorno: anche questo è un aspetto da controllare e mitigare attraverso l’uso, ad esempio, del verde vegetazionale o appropriati sistemi di schermatura ambientale di tipo artificiale
In sintesi, la situazione ideale sarebbe quella di ottenere il vantaggio dei tetti bianchi quando fa caldo e delle superfici scure quando fa freddo Alcune ricerche del MIT (Massachusetts Institute of Technology, gruppo Thermeleon) hanno sviluppato te-
Emissione infrarossa e calore
La radiazione infrarossa (IR) è la radiazione elettromagnetica con banda di frequenza dello spettro elettromagnetico inferiore a quella della luce visibile, ma maggiore di quella delle onde radio, ovvero lunghezza d’onda compresa tra 700 nm e 1 mm (banda infrarossa) Viene spesso associata al calore e alla radiazione termica, poiché ogni oggetto con temperatura superiore allo zero assoluto emette spontaneamente radiazione in questa banda per la legge di Wien; aumentando la temperatura, il picco di emissione si sposta sempre più verso il visibile finché l’oggetto non diventa incandescente L’emissione infrarossa è dunque in relazione con la temperatura raggiunta da una superficie
L’emissione e l’assorbimento dipendono dalla frequenza della radiazione, dalla natura del corpo e dalle caratteristiche della sua superficie; un corpo avente una superficie scura è un buon assorbitore e un buon emettitore di calore per irraggiamento
Una semplificazione ingegneristica è di considerare che per una stessa superficie l’emissività e il coefficiente di assorbimento non dipendano dalla lunghezza d’onda della radiazione, così che l’emissività sia una costante
Comportamento di diversi colori al calore: temperature massime della superficie con temperatura dell’aria di 26° C.
A destra: edificio residenziale e commerciale a Modena con finitura in mattone faccia a vista e cappotto di colorazione chiara Progetto: Lipparini Architetti Associati + arch F Barbolini, 2012
MATERIALE
Vernice bianca all’ossido di zinco
Vernici colorate, laterizi, argilla, vetro
Vernice Bianca all’ossido di titanio
Vernice bianca selettiva
Vernice di alluminio brillante
Mattone rosso
Cemento scuro
Metallo in lamiera cromato nero
Vernice al nero di carbonio
Vernice nera liscia
ASSORBANZA 0,16 0,04-0,40 0,20 0,23-0,49 0,30-0,50 0,65 0,65-0,80 0,87 0,96 0,97-0,99 EMISSIVITÀ 0,93 0,90 0,90 0,88-0,90 0,4-0,6 0,93 0,85-0,95 0,09 0,88 0,97-0,99
Tabella 3 - La radiazione solare incidente su una determinata superficie viene assorbita, riflessa e trasmessa e per il principio della conservazione dell’energia si ha: Ri = Ra + Rr + Rt

In alto e sotto: esempi di membrana bituminosa bianca riflettente applicata su coperture (fonte: Derbigum).

gole di copertura che cambiano colore assorbendo il calore in inverno e riflettendolo in estate Nel loro stato bianco (estate) le tegole riflettono circa l’80% della luce solare, mentre quando sono di colore nero (inverno) riflettono solo il 30%. Questa tipologia di materiali rientra tra quelli denominati in letteratura PCM, phase change materials – materiali a cambiamento di fase; essi presuppongono perciò una riconsiderazione della risultanza estetica finale dell’edificio, assumendo questo, per alcuni elementi, diverse colorazioni nelle varie stagioni, quasi fosse un elemento naturale
In Italia la stessa norma UNI-TS 11300-1:2008 sull’efficienza energetica auspica, ai fini della riduzione della temperatura superficiale, l’utilizzo di prodotti con un basso valore di assorbimento e un alto valore di riflettanza Come esempio applicativo possiamo considerare le vernici riflettenti; esse possono essere stese nella copertura degli edifici, su membrane bituminose o granigliate, su superfici murarie più o meno intonacate ma anche su manufatti costituiti da materiali plastici, vetrosi o tessili Possono essere utilizzate
in accoppiamento ad altri tipici interventi di riqualificazione come operazioni di incapsulamento dell’amianto, trattamento antimuffa o antiallergico, di tipo ignifugo, antistatico o sanificante. In ogni tipo di trattamento, naturalmente, varia la combinazione dei componenti della miscela verniciante Esistono tipologie di prodotti che, oltre al colore, utilizzano determinate componenti che riducono l’assorbimento della frazione non visibile (IR e UV) della radiazione incidente che porta a un degrado del materiale; per esempio, nelle vernici riflettenti con solfato di bario, componente bianco poco solubile e opaco ai raggi IR e UV, la temperatura superficiale si riduce da 70-80 °C a 40-50 °C, la riflettanza supera il 92% e l’emissività è circa dell’89%
Nel caso in cui si debba operare una scelta all’interno dello stesso colore, sono interessanti le indicazioni del progetto europeo Cool Roofs, che ha previsto vari tipi di prove su superfici con colori abbinati standard e “freddi” (perciò più riflettenti); durante il giorno le superfici con colori freddi hanno avuto temperature inferiori di alcuni gradi delle superfici colorate con i

colori standard corrispondenti Le superfici con le performance migliori sono state quelle nere, marrone cioccolato, blu e antracite La differenza di temperatura più alta è stata osservata tra nero freddo e nero standard, pari a ben 10,2 °C; la differenza minore è stata osservata tra verde freddo e verde standard, pari a 1,6 °C Lo studio ha registrato anche un aumento dell’albedo (indicatore del potere riflettente di una superficie) da 0,2 a 0,85
Sulla falsariga di questi studi sono state proposte in USA tre tipologie di copertura a basso accumulo termico:
coperture metalliche riflettenti e tegole metalliche riflettenti (reflective metal roofing and reflective metal shingles & tiles); superfici metalliche di copertura emissive (re-emissive metal roof surfaces);
vernici riflettenti per coperture (reflective roof coatings)
Pareti verticali
Per le superfici verticali vale lo stesso discorso delle coperture: le colorazioni bianche aiutano ad abbassare la temperatura superficiale esterna d’estate, anche se la quantità di energia da irraggiamento è inferiore, visto il minor angolo di incidenza dei raggi solari rispetto alle superfici di copertura Allo stesso modo anche il fattore d’influenza del colore in termini di risposta energetica risulta attenuato in presenza di forti spessori d’isolamento, soprattutto se di massa consistente Volendo usare colorazioni più scure, generalmente è consigliabile scegliere tinte più fredde su superfici lisce o adottare soluzioni con pareti ventilate, in analogia con i sistemi di ventilazione per le coperture (se inclinate) Nelle tinte in commercio spesso non viene indicato l’indice di riflettanza e, conseguentemente, questo fattore viene sottovalutato in sede di progetto In un’ottica di guadagno termico gratuito si possono prevedere muri di accumulo interni, posti dietro a vetrazioni, che sfruttano i principi dell’effetto serra e dell’inerzia termica Grazie a un giusto orientamento dell’edificio, alla spiccata capacità di assorbimento termico di alcuni materiali edilizi (ad esempio pareti in laterizio o cemento, oppure le stesse pavimentazioni se realizzate in cotto o resine cementizie) e a colorazioni tendenzialmente scure o addirittura nere a bassa riflettanza, è possibile favorire un prezioso accumulo termico in regime invernale, quando effettivamente ve ne è maggiore necessità Questi dispositivi architettonici di tipo passivo, vetro + masse di accumulo, assorbono calore durante il giorno rilasciandolo gradualmente durante la notte, configurandosi come dei veri e propri “regolatori” termici È però necessario pensare a degli idonei sistemi di schermatura, fissi o mobili, che impediscano il loro “funzionamento” in estate o comunque in caso di sovraccarico termico Questi elementi saranno posizionati superiormente o frontalmente in caso di orientazioni a sud,
PRINCIPALI VARIABILI NEL RAPPORTO
COLORE-EFFICIENZA ENERGETICA. Assorbanza solare, riflettanza ed emissività termica dei materiali
Difficile districarsi tra le terminologie che riguardano prodotti edilizi e relative prestazioni Si riportano alcuni chiarimenti in merito
Assorbanza solare (Solar Absorption): è usata in spettrometria, anche se questo termine viene riportato per i materiali e i componenti usati in edilizia Rappresenta l’entità dell’assorbimento della radiazione solare da parte di un oggetto L’ irraggiamento solare si scompone in tre parti: una parte viene riflessa, una parte viene assorbita e una terza parte riesce, eventualmente, a passare attraverso la superficie, ovvero trasmessa. La parte assorbita, espressa in percentuale, è espressa dal coefficiente di assorbimento (o assorbanza) La somma delle tre parti è pari a uno per il principio di conservazione dell’energia
Riflettanza (reflectance): frazione di radiazione incidente direttamente riflessa da una superficie irradiata; il suo valore varia da 0 a 1, oppure viene espresso in percentuale Si applica molto in edilizia ai prodotti di ridottissimo spessore, come le vernici ,e non si riferisce necessariamente al solo campo del visibile ma riguarda tutte le lunghezze d’onda Se si usa il termine riflettanza solare, si intende ovviamente specificare in architettura la riflettanza rispetto alla radiazione del sole La riflettanza è inversamente proporzionale all’assorbanza La riflettività (reflectivity) è sinonimo di riflettanza ma meno usata in edilizia; secondo l’International Commission on Illumination, la riflettività è distinta dalla riflettanza per il fatto che il valore di riflettività si applica a oggetti riflettenti spessi, per i quali la riflettanza varia in ragione dello spessore Viene spesso usato il termine riflettività spettrale per definire solo la determinata lunghezza d’onda riflessa della radiazione totale incidente
Emissività termica (thermal emissivity): frazione di energia irraggiata da un materiale rispetto all’energia irraggiata da un corpo nero considerato alla stessa temperatura. È una misura della capacità di un materiale o componente di irraggiare energia Un vero corpo nero avrebbe un’emissività pari a 1, mentre un oggetto reale (corpo grigio) un valore compreso tra 0 e 1 Parametro usato a volte in edilizia perché direttamente legato al surriscaldamento delle superficie irradiata, cioè alla temperatura del corpo, rilevabile attraverso la termografia Per questo motivo si usa anche il termine di emissività termica L’emissività differisce dalla riflettanza perché riguarda la restituzione all’atmosfera, mediante irraggiamento, della frazione assorbita dell’irradiazione solare, mentre la seconda riguarda il puro fenomeno di riflessione.
Nei pannelli solari termici il coefficiente di assorbimento (assorbanza) è pari a 0,98, cioè il 98% dell’energia solare disponibile è convertita in calore Il collettore si scalda, poi una parte del calore viene riemessa (emissività) sotto forma di radiazione
Nel caso dei cool roofs la strategia è contraria: i materiali hanno bassa assorbanza ed elevata emissività




frontalmente a est e ovest Il dispositivo a massa di accumulo ha funzione nulla e non viene applicato in caso di orientazioni a nord, causa il bassissimo rendimento che si manifesta solo nella fase estiva, quando l’involucro non necessita di guadagni termici ma al contrario deve essere protetto dal surriscaldamento
Un aspetto progettuale non secondario, anche se spesso trascurato, riguarda il controllo delle colorazioni dei sistemi d’isolamento a cappotto, generate dalla pigmentazione applicata allo strato finale come finitura superficiale In un’ottica di corretto utilizzo esso deve tendere (per indicazione delle stesse ditte produttrici) a colori chiari o tendenti al chiaro Gli isolanti leggeri comunemente in uso per i sistemi a cappotto, del tipo EPS e XPS, possono raggiungere, in regime di massimo irraggiamento estivo, anche temperature dell’ordine di 70-80 °C, che possono provocare la deformazione del pannello con spiacevoli antiestetismi (fessurazioni) della finitura superficiale Recentemente sono stati immessi sul mercato sistemi a cappotto che prevedono la possibilità di colorazioni finali molto scure, tendenti al nero, per consentire maggiore libertà progettuale sul colore; questi sistemi utilizzano una verniciatura finale contenente pigmenti altamente riflettenti la porzione infrarossa della luce (non incidendo su quella visibile e perciò sul colore) o piccole incisioni praticate sul lato esterno del pannello nel tentativo di limitare gli effetti del sovraccarico termico che tenderebbero a deformare il supporto isolante
Riqualificazione energetica di una villetta bifamiliare a Modena, 2008. Progetto: arch. F. Barbolini.
Sopra, cappotto in EPS grafitato con finitura chiara RAL 9001
A sinistra, effetto cromatico di vetrata alzante-scorrevole a doppia camera con gas Argon e pellicola basso-emissiva
A sinistra in basso: dettaglio della finitura del cappotto
Componenti trasparenti
Trascurando le componenti trasparenti colorate con fini decorativi (mosaici, vetrocemento ecc ), per la scelta di vetri cosiddetti neutri bisogna considerare alcuni parametri che possono variare la tonalità cromatica e il livello prestazionale
Abbassare il fattore solare (g o FS), cioè l’attitudine di un componente trasparente a lasciarsi attraversare dalla radiazione, ha effetti sulla trasparenza e sulla tonalità del vetro. Ridurre il valore di FS comporta la riduzione anche della luce naturale entrante, conseguenza di cui tener conto nella valutazione del fattore medio di luce diurna (fmld), indice che può essere considerato ai fini di una verifica più approfondita del rapporto aeroilluminante degli ambienti interni Un parametro di controllo progettuale migliore è l’indice di selettività (IS), dato dal rapporto tra la trasmissione luminosa (TL), che si riferisce alla sola banda del visibile della radiazione, e il fattore solare; perciò IS = TL/FS
Un vetro a controllo solare ha un alto indice IS, per permettere l’ingresso della componente visibile della radiazione e il minimo di calore, associato alla componente infrarossa
Valori tipici di IS sono intorno a 1,6-1,7; valori alti di IS, e perciò migliori performance energetiche, si possono ottenere mediante rivestimenti del vetro a base di metalli nobili (es argento) in fase di produzione, in grado di incrementare la capacità di riflettere la radiazione nel campo dell’infrarosso
I vetri che associano alla funzione di controllo solare anche caratteristiche di alta trasmissione luminosa (TL) sono detti vetri selettivi (IS = 2) perché, pur lasciando passare una grande quantità di luce naturale, esercitano un’azione schermante dei raggi UV e infrarossi La riflessione dai raggi infrarossi (dall’80 al 40% circa) è direttamente proporzionale all’energia solare
respinta (dal 60 al 30% circa), variando la percentuale di energia assorbita rispetto a quella riflessa Spesso si adottano vetri selettivi con proprietà cosiddette basso-emissive; essi incorporano una sottile pellicola di ossidi metallici depositati fuori linea tramite processo magnetronico Queste vetrazioni, comunemente abbinate in due o tre lastre (pacchetto a semplice o doppia camera), spesso con l’interposizione di gas Argon o Krypton, consentono una riduzione più che significativa delle dispersioni termiche dell’edificio verso l’esterno, ma al contempo riducono la trasparenza del vetro, fino a valori del 20%, conferendo una caratteristica colorazione tendente al verde, evidenziata soprattutto nelle visuali non frontali, o di scorcio In base alla composizione del film interposto si percepiscono anche colorazioni diverse (argento e avana)
Un’altra tecnica di controllo dell’irraggiamento solare è data dai cosiddetti vetri fotocromatici, capaci di abbassare il fattore di trasmissione luminosa attraverso un cambiamento di stato (queste vetrazioni, infatti, possono essere ricomprese nella categoria dei PCM definiti precedentemente) e perciò anche della loro percezione cromatica Volendo intervenire su di un edificio esistente con ampie superfici vetrate disperdenti (come ad esempio le cosiddette facciate continue), una buona tecnica di controllo solare, soprattutto per la fase estiva, è la posa di pellicole riflettenti la radiazione solare infrarossa incidente, che in piccola parte però riducono la trasparenza del vetro Esse hanno però l’effetto di aumentare l’effetto specchiante e di aumentare i costi della manutenzione, riducendo però nel contempo le spese imputabili al raffrescamento degli ambienti interni, generalmente poco confortevoli per questo tipo di edifici Sotto l’aspetto della percezione cromatica bisogna considerare che i
SUPERFICIE
Suolo scuro bagnato
Albedo: frazione di luce incidente che viene riflessa in tutte le direzioni Se usata senza ulteriori specifiche, l’albedo si riferisce alla porzione visibile della luce Viene applicata per caratterizzare la riflessione di mari, foreste, aree urbane, alberi, neve, nuvole, anche in rapporto all’aumento di temperatura nelle varie parti del globo terrestre Quando tutta la luce incidente è riflessa l’albedo è pari a 1 L’albedo si usa a livello urbanistico o paesaggistico più che a livello prettamente edilizio Non c’è corrispondenza diretta tra albedo ed emissività termica di una superficie
Suolo chiaro asciutto deserto
Erba alta
Erba bassa Foresta decidue Foresta di conifere
Acqua (angolo zenitale ampio)
Acqua (angolo zenitale piccolo)
Neve compatta
Neve fresca
Ghiaccio di mare
Ghiacciaio
Albedo

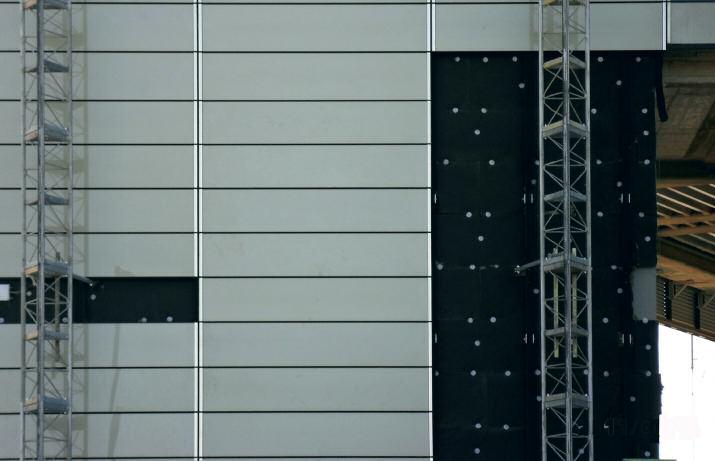
Torre UNIFIMM a Bologna
A sinistra, fasi di posa della pelle vetrata con pellicola a controllo solare, con effetto cromatico blu.
Sotto, variazione cromatica in rapporto al sistema tecnologico
La facciata (sud) è a doppia pelle in vetro; a causa della normativa antincendio è stata imposta la compartimentazione a ogni piano annullando la ventilazione naturale verticale
Per permettere il raffrescamento estivo della doppia pelle, è stato necessario implementare il sistema con dei ventilatori meccanici a flusso orizzontale.
In basso, fase di montaggio della parete ventilata a pannelli metallici grigi sul sottostante isolamento di colorazione nera

prospetti di un edificio con ampie superfici con vetri riflettenti trasmettono un’immagine influenzata da diversi fattori: lo stato del cielo (sereno o nuvoloso), l’ora della giornata, l’orientamento della facciata (a seconda del diverso grado di inclinazione dei raggi solari incidenti), le caratteristiche degli spazi interni (dimensionali e di illuminazione interna proveniente da altre direzioni)
Da queste riflessioni si deduce che il controllo delle scelte sul colore, indirizzate al rendimento energetico, può portare a risultanze molto differenti da quelle comunemente considerate in una progettazione poco attenta È il controllo continuo del progetto nel suo insieme che porta a regolare l’incidenza degli aspetti propriamente architettonici a scapito o a favore della massima efficienza energetica, comprese le scelte sul colore dei nostri edifici
PITTURE CON NANO ISOLANTI
SurfaPaint® ThermoDry Esterni
pittura termica per facciate
Descrizione. SurfaPaint® ThermoDry Esterni è una pittura acrilica termoisolante per superfici esterne in muratura
Grazie all’utilizzo della tecnologia delle sfere di vetroceramico e della nanotecnologia del silicio e del biossido di titanio (TiO2) di dimensione nano e micro che la rendono termoisolante, questa pittura riduce la conduzione del calore e riflette le radiazioni termiche (infrarossi), sia in estate mantenendo il calore all’esterno, sia in inverno riducendo la dispersione termica delle murature
Resistente ai raggi UV, è una pittura traspirante che crea una barriera contro l’umidità impedendo l’assorbimento d’acqua
L’applicazione di SurfaPaint® ThermoDry esterni previene anche lo sviluppo delle isole di calore urbane riflettendo più del 94% delle radiazioni che colpiscono la struttura opaca, migliorando l’isolamento termico e contribuendo al risparmio energetico e all’efficienza energetica degli edifici
Grazie al meccanismo di reticolazione e alle nanoparticelle, la tendenza della pittura a raccogliere particelle di sporco e inquinamento atmosferico è significativamente ridotta
Utilizzo. La pittura si applica direttamente sulle superfici esterne di edifici in muratura, calcestruzzo, cartongesso e muri a secco È adatta anche per applicazioni su murature esposte alle intemperie e per la protezione di superfici danneggiate con microfratture Eccelle nel colmare microcrepe anche in condizioni di temperatura molto basse e a grandi escursioni termiche senza rischio di sfaldamenti

Confezione 10 l
Resa 10/12 l/m2
Conduttività termica < 0,1 W/mK
Riflessione radiazione termica 94,2% (infrarossa)
Permeabilità all’acqua non permeabile
Colore Bianco
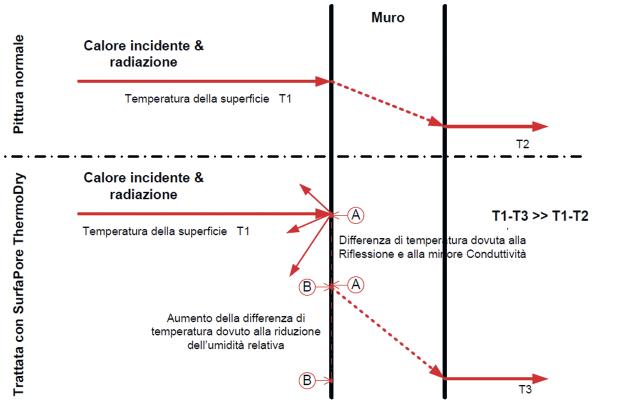
Trasferimenti del calore attraverso un muro con pittura normale e pittura trattata con SurfaPore ThermoDry
Dati tecnici
PITTURE TERMORIFLETTENTI
StoColor X-black
pittura per sistemi di isolamento termico per facciate
Descrizione. StoColor X-black è un’innovativa pittura termoriflettente per sistemi di isolamento termico, in grado di ridurre il surriscaldamento delle superfici dovuto all’irradiazione solare e di mantenere i picchi di temperatura al di sotto dei 70 °C, preservando in questo modo le facciate che, se sottoposte a temperature superiori, possono danneggiarsi o, nel tempo, mostrare fessurazioni nell’intonaco Concretamente, StoColor X-black

consente di superare il limite di fattibilità per i rivestimenti nei sistemi di isolamento in EPS e di optare per tinte con indice di riflessione inferiore al 20%, ovvero di realizzare facciate dalle tonalità intense e persino molto scure.
Tutto ciò è possibile grazie alla sostituzione dei comuni pigmenti neri, come ossido di ferro e fuliggine, con speciali pigmenti NIR (Near InfraRed) che consentono di riflettere una parte dell’energia solare nello spettro non visibile degli infrarossi a corto raggio e di ridurre i singoli picchi di temperatura di circa il 15/25% rispetto a una normale pigmentazione
La pittura è a base di acrilato puro ed è disponibile in tutte le tonalità del sistema StoColor System e in molte altre colorazioni È resistente agli alcali e svolge un’azione ritardante e preventiva contro la proliferazione di alghe e funghi
Utilizzo. La pittura, altamente idrorepellente e permeabile al vapore acqueo, è utilizzata nella realizzazione di facciate con colori intensi Deve essere applicata su supporti puliti e asciutti, possibilmente non su superfici orizzontali o inclinate sollecitate da intemperie Possiede un ottimo potere coprente e un’ottima aderenza al supporto

Dati tecnici
Consumo ca 0,15-0,18 l/m2 per mano
Permeabilità al vapore (Sd) 1,2 m
Permeabilità all’acqua (w) < 0,05 kg/(m2h0,5)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (µ) 6700
Spessore strato secco 180 µm
Granulometria < 100 µm
prodotti finiture per facciate
PITTURE CON PIGMENTI NIR
RÖFIX PE 519
pittura per facciate
PREMIUM DARK
Descrizione. La pittura per facciate Premium Dark è basata su una nuova struttura polimerica-stabilizzata di silicato/silossano con pigmenti NIR (Near InfraRed) quali ossido di titanio, mica, carbonato di calcio, silicato di alluminio, che contribuiscono a ridurre l’assorbimento delle radiazioni solari del campo dell’infrarosso La pittura, che compone il sistema di isolamento SycoTec, offre un notevole contributo alla riflessione del calore e alla riduzione della temperatura superficiale, permettendo la realizzazione di facciate dai colori brillanti, uniformi e protette dagli agenti atmosferici e biologici Possiede un elevato potere coprente, è idrorepellente, resiste allo sfarinamento e dona stabilità al colore
Utilizzo La pittura permeabile al vapore per facciate intonacate e rivestite con sistemi di isolamento termico può essere applicata a pennello, rullo o a spruzzo e durante la fase di lavorazione la temperatura del supporto non deve scendere al di sotto dei 5 °C La superficie deve essere protetta fino a totale essiccamento Il supporto deve essere asciutto, consistente e privo di impurità (polvere, efflorescenze ecc ) e la superficie deve essere protetta fino a totale essiccamento


Dati tecnici
Confezione 15 l
Consumo ca 0,15 l/m2/mano
Permeabilità al vapore (Sd) ca 0,2
Valore pH ca 8,5
Assorbimento acqua ca 0,08 kg/m2 (EN 1015-18)
Brillantezza media opaco grezzo

Descrizione. Il rivestimento per facciate ePIZ unisce il rivestimento di facciata isolato a un sistema fotovoltaico BIPV (Building Integrated Photovoltaic System), abbinando il rivestimento e l’isolamento dell’involucro alla produzione di energia elettrica Il pannello di rivestimento è costituito da un paramento in malta cementizia fibrorinforzata modificata e accoppiata a una lastra di materiale isolante in lana di roccia sviluppata appositamente per ePIZ del tipo a doppia densità e certificata al fuoco Euroclasse A1 L’elemento cementizio presenta sui bordi superiori e inferiori una scanalatura atta ad accogliere i profili di montaggio Il pannello è disponibile in vari spessori con la possibilità di variazione di ± 25 mm Il pannello fotovoltaico è progettato per evidenziare le celle come una texture della facciata stessa La disposizione delle celle è progettata per mettere in risalto il colore e l’aspetto superficiale del supporto retrostante, installando così pannelli fotovoltaici
RIVESTIMENTO DI FACCIATA FOTOVOLTAICO
isolamento e produzione di energia elettrica
senza snaturare l’aspetto estetico dell’edificio stesso Il sistema PIZ gode di certificazione europea ETA 06/0136 (European Technical Approval) moduli certificati IEC/EN 61215:2005 lEC 61730-2:2004 EN 61730-2:2007.
Utilizzo Il sistema è destinato al rivestimento di tutte le tipologie di edifici sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni La posa in opera è totalmente a secco con fissaggio meccanico e avviene utilizzando gli stessi kit profili e sistemi utilizzati per il solo pannello di rivestimento In questo modo è sempre possibile intercalare in modo complanare su una stessa facciata di un edificio pannelli a tecnologia fotovoltaica con pannelli di rivestimento di tipo tradizionale, massimizzando l’impiego dei pannelli fotovoltaici dove le condizioni di irraggiamento sono più favorevoli (facciate sud o facciate ai piani più alti limitando l’effetto di ombreggiamento) oppure dando priorità al design della facciata Dimensioni
EPIZ (sistema standard 54)
EPIZ (sistema H89)

Dati tecnici
Isolamento termico strato isolante λ 0,038 W/mK
Potere fonoisolante Δrw 12 dB
Produzione elettrica pannello da 80 a 110 W/m2
prodotti finiture per facciate
VETRI ELETTROCROMICI
ELECTROCHROME Sage Glass®
vetro attivo isolante
Descrizione. ELECTROCHROME Sage Glass® è una vetrocamera a doppio o triplo vetro che, mediante a un’attivazione di corrente a basso voltaggio, può commutare lo stato da chiaro a scuro, e viceversa, senza bloccare la trasparenza, sostituendo quindi i sistemi di ombreggiatura tradizionali Il pannello esterno del doppio e/o triplo vetrocamera è cosparso di strati di ossidi di metallo che, grazie al principio chimico dell’ossidazione e della riduzione, rendono scuro il vetro; all’applicazione di un basso voltaggio sul rivestimento, gli ioni si spostano da uno strato all’altro causando la colorazione scura e diminuendo la quantità di luce e calore che li attraversa Il cambio di polarità, sempre a basso voltaggio, permette agli ioni di ritornare nello strato originario e al vetro di schiarirsi Il fattore solare varia da 0,40 a 0,80 Questa soluzione può essere totalmente e facilmente integrata a un sistema di controllo elettronico dell’edificio BMS La vetrocamera può essere installata su telai fissi, apribili o a scorrimento ed è compatibile con la maggior parte di telai per finestre e facciate Utilizzo. ELECTROCHROME Sage Glass® è la soluzione ideale per finestre, lucernari, facciate e tutte quelle applicazioni dove sia necessario e richiesto un controllo della luce naturale e del calore entranti nell’edificio È particolarmente adatto negli edifici a basso consumo energetico. A seconda delle esigenze e
Dati tecnici
delle applicazioni è possibile adottare la soluzione vetrata di controllo più idonea in base alla localizzazione geografica, all’orientamento delle facciate e all’uso dell’edificio ELECTROCHROME Sage Glass® offre non soltanto la gestione dell’abbaglio all’interno dell’edificio/ambiente, ma contribuisce anche a una maggiore efficienza energetica ed ad una sensazione di benessere, creando un ambiente più confortevole e più produttivo

SageGlass 6 mm temperato 16 mm aria
Vetro chiaro float 6 mm temperato
SageGlass 6 mm temperato 16 mm argon
Vetro 6 mm low –e
SageGlass 6 mm temperato 16 mm argon
Vetro 4 mm temperato 16 mm argon
Vetro 6 mm low –e
PITTURE CON MICROSFERE DI CERAMICA
ThermoShield Exterieur
rivestimento per facciate


Densità 1 030 kg/m3
Permeabilità al vapore, Sd 1,3 (asciutto)
Permeabilità al vapore, Sd 0,7 (umido)
Riflessione α solar 0,86
Conduttività termica 0,02-0,04 W/mK (da laboratorio)
Calore specifico 1 165 J/kgK (da calcolo)
Superficie di evaporazione 2 250 m2/m2 (da calcolo)
Superficie piana sfere S ≈ 150 m2/m2 (da calcolo)
Diametro sfere 65 µm (da calcolo medio)
TECNOVA www tecnovabuild it
Descrizione. ThermoShield Exterieur è un rivestimento multifunzionale ad alta tecnologia per facciate che consente di ottenere benessere termico e di ridurre i costi di riscaldamento e raffrescamento grazie all’uso di micro sfere di ceramica (Ceramic Bubbles) grandi solo alcune frazioni di micron Le microsfere e il legante interagiscono contro il surriscaldamento delle facciate comportandosi come una membrana endotermica e garantendo un buon isolamento termico sia estivo che invernale Il prodotto è dotato di permeabilità variabile ed elevata resistenza alle condizioni ambientali aggressive come smog e ozono, è privo di solventi e non emette gas nocivi È resistente alla radiazione calorica solare e presenta un’altissima resistenza dei colori
Utilizzo. La pittura può essere applicata su tutti i fondi solidi, puliti, asciutti, privi di ruggine e grasso, come calcestruzzo, intonaco nuovo o esistente, sia grezzo che ricoperto Per garantire le caratteristiche isolanti è necessario assicurare la permeabilità al vapore del fondo
L’applicazione del prodotto, già pronto per l’uso, può avvenire a pennello, a rullo o a spruzzo Se utilizzato per la prima volta è necessario stendere due mani Durante il trattamento e durante l’asciugatura la temperatura minima della zona di applicazione del film non deve essere inferiore a 5 °C. È indispensabile anche assicurarsi che ci sia abbastanza luce solare durante l’applicazione, poiché il legante utilizzato è a reticolazione UV, ovvero soggetto ad attivazione in presenza di luce ultravioletta che innesca la reazione di polimerizzazione

Dati tecnici
impianti microgenerazione
Giacomo Cassinelli
Architetto, Dottore di Ricerca
MICROGENERAZIONE
DA FONTI RINNOVABILI
Valutazioni sull’integrazione architettonica
Le fonti rinnovabili hanno un’importanza strategica come soluzione per l’approvvigionamento energetico e contenimento delle emissioni inquinanti, ma l’introduzione degli impianti in stretta relazione col costruito necessita di considerazioni tecniche e percettive.
Impianti da fonti rinnovabili
Il ricorso alle fonti rinnovabili negli ultimi anni si sta prospettando sempre più come una delle soluzioni, quasi obbligate, ai problemi legati all’approvvigionamento energetico e all’inquinamento generati dallo sviluppo della società umana sul pianeta In particolare il settore dell’edilizia ne è responsabile per una quota di circa il 40% Ciò impone la necessità di mutare la nostra organizzazione, fortemente imperniata sullo sfruttamento delle fonti fossili non rinnovabili, anche in vista di un rapido raggiungimento del livello dei consumi occidentali da parte dei nuovi Paesi emergenti Rimangono da indagare le modalità con cui affrontare il cambiamento e le ripercussioni che questo avrà non solo sulla vita ma anche sul territorio e sul costruito
Attualmente l’energia elettrica viene prodotta in grosse centrali, spesso lontane dai centri abitati a causa del loro impatto ambientale e visivo, che per lo più utilizzano la combustione di gas naturale o di carbone Questo sistema ha un’efficienza piuttosto bassa, può variare dal 35% al 60%, in quanto a valle del procedimento tutto il calore generato viene di solito disperso nell’ambiente
Ricorrendo invece alle fonti rinnovabili si ha una produzione ben più distribuita, principalmente per la necessità di localizzarla dove per natura si ha la presenza di un salto d’acqua, di molto vento, di molto sole, della disponibilità di biomasse, ecc.
Tanti piccoli impianti dislocati sul territorio sarebbero in grado di sfruttare al meglio le fonti rinnovabili con tecnologie differenti, a seconda dei casi, costituendo un modello di generazione energetica alternativo e più efficiente: la microgenerazione distribuita
La microgenerazione dà quindi la possibilità – fattore non secondario – di eliminare le perdite dovute alla distribuzione dell’energia, e alla trasformazione da alta a bassa tensione, situando la generazione in stretta relazione coi luoghi di consumo e dimensionandola in funzione delle potenze richieste In quest’ottica la rete elettrica svolge un ruolo fondamentale, in quanto deve essere in grado di combinare e gestire l’energia di volta in volta dal luogo dove viene prodotta a quello in cui viene consumata, con un aumento della complessità dei flussi Flussi che non saranno più unidirezionali, dalla grande produzione





A sinistra, dall’alto: quartiere fotovoltaico in Danimarca; edificio con rotori Savonius a Melbourne; microidroelettrico portata 1600 l/s, Torrente Cerusa (GE); TOTEM, Total Energy Module, primo cogeneratore ideato in Italia nel 1973 presso il centro di ricerche FIAT dall’ing Mario Palazzetti
verso i consumatori e non più facilmente modulabili a seconda delle necessità come nell’attuale, ma dipendenti dal diverso microclima locale
La diffusione della microgenerazione e la fine di un uso massiccio del petrolio, e delle altre fonti fossili, porteranno quindi un grosso cambiamento sia nelle infrastrutture sia nella concezione delle città, degli insediamenti produttivi e anche degli edifici stessi Tutto ciò presenta da un lato notevoli difficoltà tecnologiche, dall’altro una certa ostilità degli utenti verso la presenza di nuovi impianti nel proprio spazio abitativo e lavorativo. Ostilità che spesso si esplicano in una normativa di settore piuttosto vincolante e restrittiva, ma che altrettanto spesso sono di carattere culturale; ad esempio, riguardano la comprensione della necessità di prassi più sostenibili o la difficoltà ad accettare la percezione visiva degli impianti Ostilità forse frutto della percezione del paesaggio, sostantivo spesso usato in ambiti di tutela, come mero panorama e non come ambiente vivo in continuo mutamento e sviluppo, specchio della società che lo abita.
Un metodo di valutazione
Può essere dunque utile un metodo di valutazione che tenga presente le particolarità di ogni caso specifico e agevoli il progettista e il committente a scegliere un sistema di generazione energetica maggiormente sostenibile, funzionale, efficiente, utile, ma anche in grado di armonizzarsi con il contesto e con l’edificio che deve servire; soprattutto per non adottare una soluzione senza vagliare tutte le possibilità, ma semplicemente perché proposta dalla pubblicità di settore, da installatori abituati alla messa in opera di una singola tecnologia, o per i benefici economici e agevolazioni normative particolarmente favorevoli solo verso alcune di esse In quest’ottica si propongono una serie di verifiche successive organizzate in modo gerarchico, dalla più vincolante a quella legata alle intenzionalità e volontà soggettive, in relazione a ogni specifico intervento (vedi schemi a pag 74)
In questo studio sono state prese in considerazione le quattro tecnologie di microgenerazione più diffuse: fotovoltaico, eolico, idroelettrico, cogenerazione La prima è sicuramente la più famosa e propagandata come soluzione innovativa di conversione dei raggi solari in generazione energetica; sebbene i pannelli siano prodotti nella forma attuale fin dalla fine degli anni ‘50 L’eolico e l’idroelettrico, seppur a prima vista così distanti, hanno invece un funzionamento assimilabile; l’energia del vento o dell’acqua viene sfruttata da un motore elettrico, dal basso contenuto tecnologico, facilmente riparabile, dalla lunga durata e in grado di fornire grandi quantità di energia Tuttavia, entrambe le tecnologie sono spesso osteggiate anche dagli ambientalisti più estremi e criticate per l’impatto visivo e ambientale, a prescindere dalla taglia installata Gli impatti tra la
macro e la microgenerazione, però, non sono paragonabili e la diffusione di piccoli impianti in un paese come l’Italia ricco di vento (sulle coste, sulle isole, sui crinali) e di corsi d’acqua è assolutamente auspicabile
Infine, la cogenerazione consente la produzione, nello stesso processo e utilizzando il medesimo vettore energetico primario, di energia elettrica e termica Un motore endotermico, una turbina, un motore Stirling, ecc bruciano biocarburanti o metano (eventualmente prodotto dalla decomposizione di rifiuti organici) per muovere un motore elettrico, nel contempo viene sfruttato anche il calore prodotto In questo modo il rendimento complessivo della macchina raggiunge valori anche del 98%, impensabile con la generazione separata Per questo l’applicazione è particolarmente vantaggiosa dove la richiesta di energia termica è alta, ad esempio nel caso di utenze come alberghi, bar, ristoranti e mense, edifici detentivi, impianti sportivi, palestre e centri benessere, piscine, lavanderie, centri e stabilimenti per il benessere fisico. La comparsa sul mercato di macchine di piccola taglia in parallelo alla possibilità della loro installazione senza mutare quasi nulla dell’organizzazione attuale – si pensi all’immagine degli edifici o alla capillarità della distribuzione del metano – rende la cogenerazione una tecnologia dalle grandi potenzialità di diffusione, sebbene non sfrutti sempre le risorse rinnovabili
La possibilità di sfruttamento delle risorse rinnovabili non è certo una scoperta del XXI secolo, da sempre l’umanità si è dovuta misurare con le risorse energetiche disponibili e la maturazione della rivoluzione industriale ci ha dato tutti gli strumenti per farlo Solo ora però l’informatica è in grado di gestire la complessità della microgenerazione distribuita Il metodo proposto permette di escludere gli impianti che darebbero scarsi risultati nel sito di intervento e di includere quelli che in prima istanza potrebbero non essere presi in considerazione Infatti potrebbero presentarsi casi particolarmente fortunati dove è possibile il ricorso a più tecnologie, ad esempio in presenza di più di una fonte rinnovabile disponibile, oppure casi in cui diverse tipologie di integrazione risultano ugualmente idonee anche per lo stesso impianto Sarà allora l’approccio culturale del progettista a determinare un processo di affinazione della scelta Per contro, ci possono essere casi di architetture la cui immagine è riconosciuta come intoccabile e pertanto alcune integrazioni non possono essere prese in considerazione: sarà l’ultima verifica a operare come feedback negativo sulle precedenti negando l’adozione di quelle tecnologie che influiscono sulla percezione visiva del manufatto.
Nella definizione di indicazioni progettuali, volte ad agevolare la diffusione degli impianti e a garantirne una buona integrazione, non si dovrebbe imporre una soluzione formale determinata (come invece accade per molte norme vigenti come il conto energia fotovoltaico), piuttosto una modalità di approccio a se-
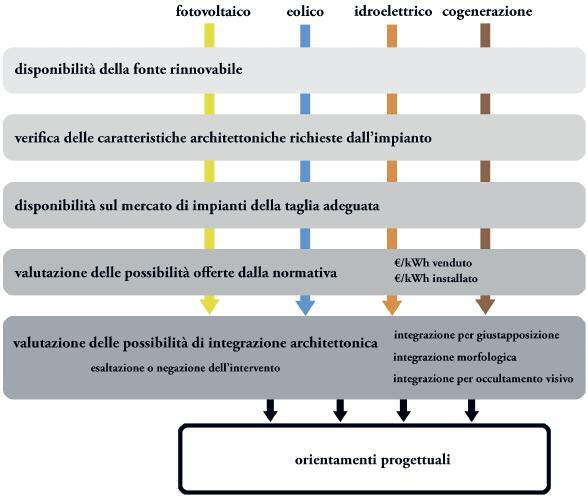
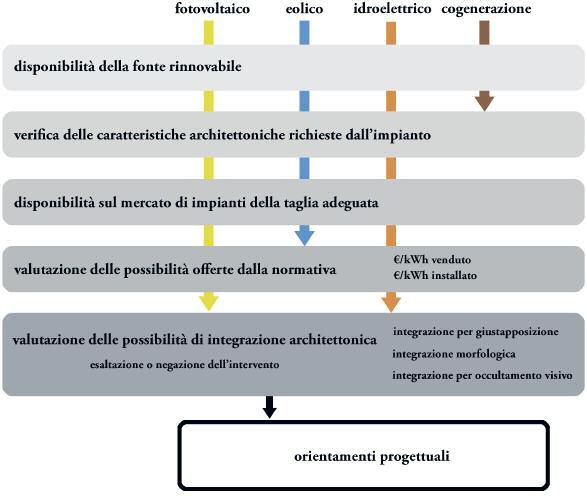
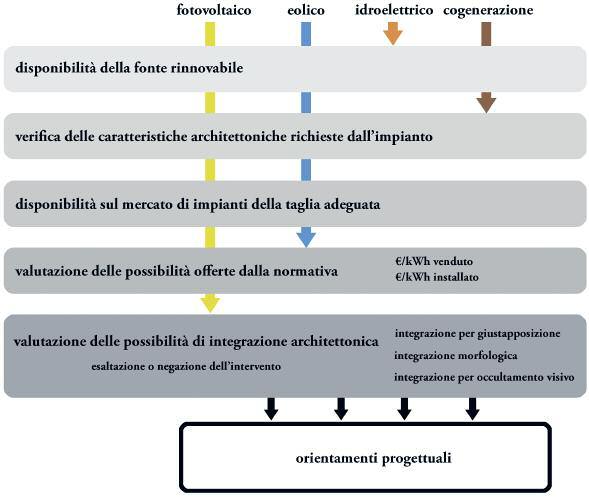
Metodo decisionale, sequenza verifiche
Caso 1: possibilità di adozione di più tecnologie.
Caso 2: possibilità di adozione di differenti integrazioni architettoniche
Qui accanto: l’ascensore di Palazzo Rosso e, più a destra, l’ascensore di Piazza Valoria, entrambi a Genova

conda dei diversi contesti e ambiti di tutela Sarà poi compito e responsabilità del progettista definire gli aspetti formali e tecnologici dell’impianto
In dettaglio, il metodo prevede una serie di passaggi come indicato di seguito
1. Verifica della disponibilità della fonte rinnovabile: è necessariamente il primo campo di indagine che verifica la presenza in sito delle fonti rinnovabili e la loro possibilità di sfruttamento
A tal fine occorre effettuare un’analisi ambientale e climatica del contesto di progetto con strumenti propri di ogni tecnologia stabilendo degli indicatori minimi per definirne l’inclusione o l’esclusione
2 Verifica delle caratteristiche architettoniche richieste dell’impianto: perché possa essere garantito un corretto funzionamento l’edificio che lo accoglie deve garantire alcune caratteristiche di base
- Fotovoltaico: superficie con buona esposizione, struttura in grado di reggere il peso dell’impianto, allaccio alla rete elettrica/locale per batterie
- Cogenerazione: locale tecnico, accumulo di acqua calda, insonorizzazione (vibrazioni), canna fumaria, impianto integrativo (tradizionale), allaccio alla rete elettrica, allaccio alla rete gas (o altra fonte primaria)
- Eolico: punto di installazione con buona esposizione, struttura in grado di reggere il peso dell’impianto, allaccio alla rete elettrica/locale per batterie
- Microidro: opere di regimentazione delle acque, locale tecnico, insonorizzazione, allaccio alla rete elettrica/batterie
3 Disponibilità sul mercato di impianti della taglia adeguata: oltre ai requisiti tecnici di base, è importante poter valutare se vi sono sul mercato generatori che si adattano alla richiesta dell’utenza e all’andamento nell’arco dell’anno della fonte rinnovabile specifica. Solitamente è preferibile un generatore di taglia inferiore, ma che sia in grado di lavorare a pieno regime, piuttosto che uno più potente con funzionamento irregolare o

difficoltoso
4 Valutazione delle possibilità offerte dalla normativa: è interessante poter fare un confronto principalmente in funzione dei costi (euro/kW installato) e dei potenziali ricavi (euro/kWh venduto), in modo tale da verificare quale risulti essere la più conveniente dal punto di vista economico; è possibile, infatti, che alcune tecnologie presentino costi molto elevati a fronte di guadagni maggiori Dal punto di vista ambientale, invece, può risultare più conveniente installare una tecnologia che, a parità di investimento iniziale, o di potenza installata, assicuri una produzione maggiore, evitando di conseguenza l’emissione di maggiori quantità di CO2 nell’atmosfera
5 Valutazione delle possibilità di integrazione architettonica: gli interventi si possono suddividere in tre tipologie principali di integrazione: per giustapposizione, per occultamento visivo o mimesi e morfologica
- La giustapposizione è un’operazione di semplice sovrapposizione dell’impianto sul costruito senza un evidente legame formale con esso
- L’integrazione per occultamento visivo tende a nascondere l’intervento cercando di renderlo invisibile, almeno dalla distanza alla quale normalmente si percepisce il manufatto; può essere ottenuta o prediligendo quelle tecnologie che non risultano essere visibili o mascherando le altre con forme e colori del manufatto destinato ad accoglierle
- L’integrazione morfologica è quella ottenuta inserendo gli elementi dei nuovi impianti in componenti architettonici già esistenti, o tradizionali (ad esempio finestre, coppi, camini, antenne ecc ) riprendendone le forme o le funzioni, senza però che ne sia previsto l’occultamento
Le problematiche legate all’inserimento della generazione energetica da fonti rinnovabili nell’architettura possono essere considerate analoghe a quelle sollevate dall’introduzione di nuovi impianti tecnologici nelle preesistenze, spesso storiche, o dagli adeguamenti funzionali di cui sono oggetto L’approccio all’in-
tegrazione architettonica può essere molto diverso Ci saranno integrazioni che tutelano l’immagine storica consolidata degli edifici e ci saranno integrazioni che mostrano una volontà di rinnovamento funzionale dell’architettura
L’inserimento di un nuovo ascensore nel Museo di Palazzo Rosso a Genova (vedi imm a pag 73 in alto), in Via Garibaldi, patrimonio dell’Unesco, è stato risolto usando materiali quali l’acciaio e il vetro che denunciano la contemporaneità dell’intervento e lo rendono in una certa misura reversibile Diversamente è stato fatto per un’occasione simile in un edificio in una zona del centro storico poco distante (vedi imm a pag 73 in basso), Piazza Valoria, dove l’ascensore è stato inserito in modo mimetico senza creare soluzioni di continuità della facciata e riprendendone le forme e i colori, nel tentativo quasi di negare l’operazione architettonica Questo secondo caso non è meno percepibile del primo: date le dimensioni e l’altezza non può che apparire subito come un vano di servizio prima inesistente e ora incombente nella piccola piazza le cui geometrie risultano immancabilmente modificate Nel primo caso invece l’inserimento di un nuovo elemento è stato caricato anche di significati altri: si è deciso di esaltarne l’estraneità grazie alle potenzialità dei materiali che lo costituiscono tanto da elevarlo quasi a simbolo della rinnovata architettura e della funzione che ospita, senza per questo apportare modifiche radicali alla percezione precedente dell’oggetto e mantenendo un’autonomia tra le parti.

Integrazione per giustapposizione

Integrazione per occultamento visivo

Integrazione morfologica
Per comprendere meglio il funzionamento del metodo proposto, può essere utile affrontare un caso studio esemplificativo: un edificio storico del centro di Genova, sede dell’Istituto dei Ciechi David Chiossone L’edificio è stato scelto perché attualmente oggetto di riqualificazione architettonico-funzionale, è sottoposto a vincolo monumentale e presenta una notevole complessità impiantistica Il progetto prevede l’adozione di pompe di calore per la climatizzazione (invernale ed estiva) con un conseguente aumento non solo dei consumi elettrici (attualmente circa 400 MWh/anno) ma anche della complessità di gestione dei flussi d’aria dove vivono e lavorano molte persone diverse per mansioni, età e abilità psicofisiche, mentre parte dell’edificio continuerà ad essere servita da due vecchie caldaie (da sostituire) che forniscono acqua calda sanitaria e acqua per il riscaldamento a radiatori È dunque importante valutare le diverse possibilità di generazione energetica in loco attraverso sia lo sfruttamento delle fonti rinnovabili presenti sia l’uso di impianti a elevata efficienza quali la cogenerazione
Data la conformazione dell’area e l’assetto morfologico degli edifici circostanti, l’adozione di un impianto fotovoltaico è stata valutata positivamente; in corrispondenza del livello di copertura, infatti, non ci sono ostacoli significativi che potrebbero produrre ombre portate sui pannelli e il profilo d’orizzonte risulta libero, mentre le facciate sono spesso in ombra come pure il giardino ll regime ventoso non è sfruttabile e non vi sono corsi d’acqua né tubature per il microidroelettrico Invece, data la continuità nell’arco dell’anno di un consumo ingente di ACS, l’adozione di un cogeneratore a gas è stata valutata positivamente.
Per quanto riguarda la taglia, il fotovoltaico non ha particolari restrizioni mentre, nel calcolo del dimensionamento del cogeneratore, si è partiti dal fabbisogno di ACS, costante nell’arco dell’anno e stimato di circa 5 m3/giorno (media dei prelievi degli ultimi 3 anni), ipotizzando che questi ultimi possano essere utilizzati interamente per ACS. Nello specifico, è interessante sottolineare come tale valore si discosti molto dalle previsioni di consumo indicate nella normativa per la metratura dell’Istituto e usualmente adottate nei dimensionamenti: 12 m3/giorno Tali premesse, così lontane dalla realtà, potrebbero portare non solo a un dimensionamento dell’impianto non corretto, ma a una stima di ritorno economico errata Per i 5 m3/g di consumo (pari a 180 kWh/g) basterebbe una macchina da 7,4 kWh termici, mentre la normativa ne richiederebbe una da 18 kWh Sul mercato sono presenti macchine di taglia leggermente maggiore e quella scelta è in grado di fornire 13,5 kWh termici e 5,5 kWh elettrici
La normativa nazionale consente inoltre l’adozione di entrambi gli impianti, che possono accedere ai benefici dello scambio sul posto L’impianto proposto nell’ipotesi 1 di pag 79 da 35 kWp, e da circa 75 000 € di investimento, è in grado di produrre 40 MWh/anno, circa il 10% dei consumi, assicurando un risparmio in bolletta di 8 000 euro/anno (considerando un costo di 0,2 €/kWh) e tempi di ritorno di circa 9 anni Il cogeneratore richiederà un investimento iniziale di circa 50 000 €, ipotizzando per sicurezza 20 ore di funzionamento giornaliero l cogeneratore richiederà un investimento iniziale di circa 50 000 €, ipotizzando 20 ore di funzionamento giornaliero sarebbe in grado di produrre gli stessi 40 MWh elettrici; funzionamento sovrastimato per sicurezza in quanto con la macchina da 13,5 kWth basterebbero 13 ore per soddisfare il fabbisogno giornaliero di 180 kWh termici Per quanto riguarda il fotovoltaico, la Soprintendenza potrebbe dare un parere negativo in quanto muta l’aspetto esteriore dell’edificio, mentre il cogeneratore rappresenta un’integrazione architettonica per occultamento che non influisce sulla percezione visiva dell’edificio
L’adozione del fotovoltaico è stata spesso mossa più dalla convenienza economica della normativa che dall’effettiva necessità di autoproduzione dell’energia: a parità di investimento, questa tecnologia produce meno e il suo funzionamento non è assicurato oltre i 25 anni, un motore elettrico dell’eolico o del microidroelettrico mantiene l’efficienza anche per 50 e oltre Questo in parte delegittima l’installazione dei pannelli in grossi impianti lontani dai centri di consumo e conferma l’interesse dell’utilizzo in architettura anche con valenze simboliche legate all’estetica contemporanea
Un caso studio: l’Istituto Chiossone
Ipotesi 1

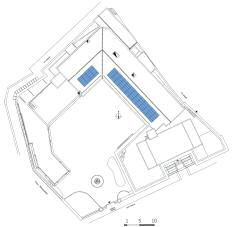
35 kWp - 105 moduli azimut 47° W, tilt 28°; 35 moduli azimut 43° E, tilt 28° - produzione 40 MWh/anno I moduli sono sovrapposti alla copertura tradizionale in abbadini di ardesia con un’integrazione per giustapposizione complanare alla superficie del tetto, secondo quanto prescritto dall’Allegato 2 del DM 5 luglio 2012 (vigente conto energia) Pregi: l’impianto potrà essere ventilato e svincolato da particolari esigenze di forma e dimensione. Difetti: il costo dell’impianto si sommerà a quello della copertura tradizionale.
Ipotesi 2


19,8 kWp - 330 moduli elettrotegola azimut 47° W, tilt 28° - produzione 20 MWh/anno I moduli sostituiscono il manto esterno della copertura tradizionale con un’integrazione morfologica, secondo quanto prescritto dall’Allegato 2 del DM 5 luglio 2012 (vigente conto energia) Pregi: risparmio del costo della copertura tradizionale Difetti: questi moduli sono attualmente fuori produzione, non assicurerebbero la tripla sovrapposizione dell’ardesia per la tenuta all’acqua; inoltre, c’è la necessità di studiare una soluzione particolare per il compluvio e la fine della falda in quanto non esistono moduli lunghi la metà.

Ipotesi 3
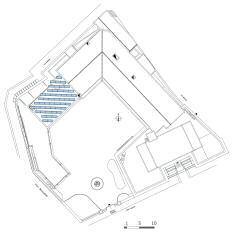
12 kWp - 50 moduli azimut Sud, tilt 33° - produzione 16 MWh/anno Integrazione di moduli vetro-vetro per giustapposizione in una pensilina di ombreggiamento del terrazzo vivibile del terzo piano. Pregi: l’impianto risponde a una precisa esigenza d’uso della terrazza oltre che di generatore energetico, avrà un’immagine architettonica indipendente e autonoma, coerente con le sue funzioni senza sostituire o simulare componenti tradizionali, sarà ventilato e svincolato da particolari esigenze di forma e dimensione, inclinazione e orientamento sono ottimali Difetti: al costo dell’impianto si sommerà quello della struttura portante della pergola, avrà un incentivo economico minore rispetto agli impianti considerati integrati su edifici, è possibile che una tale soluzione, anche se di valenza maggiore, non sia coerente con le linee di indirizzo adottate dagli uffici preposti per la tutela degli edifici storici con vincolo monumentale

Ipotesi 4
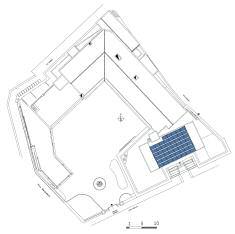
13 kWp - 54 moduli azimut 25° E, tilt 10° - produzione 13,5 MWh/anno. Integrazione architettonica per giustapposizione senza particolare attenzione formale, semplicemente seguendo la forma della copertura piana del teatro, ed escludendo le coperture piane laterali con i parapetti, che farebbero ombra, e dalla forma eccessivamente irregolare Pregi: l’impianto potrà essere leggermente ventilato e svincolato da particolari esigenze di forma e dimensione; estrema facilità e rapidità di installazione Difetti: costo aggiuntivo di strutture in alluminio per l’ancoraggio e l’inclinazione dei moduli, scarsa o nulla integrazione architettonica, anche se si sono seguite le prescrizioni per “impianti installati su edifici del DM 5 luglio 2012”
sistemi microgenerazione
COGENERAZIONE
Vitobloc
microgeneratore con tecnica della condensazione
Descrizione. I gruppi di cogenerazione Vitobloc 200, in abbinamento a caldaie che coprono il picco di carico termico, rappresentano la soluzione ideale per impianti condominiali, hotels, case per anziani, piscine, ecc.
I moduli sono compatti e pronti per l’uso e sono in grado di produrre energia elettrica necessaria all’utenza ed energia termica per il riscaldamento L’energia elettrica non utilizzata viene immessa nella rete elettrica nazionale
Composti da un telaio che riunisce il motore e il generatore elettrico, una struttura isolata acusticamente e un sistema di regolazione con quadro elettrico incorporato, essi si adattano alle necessità specifiche di progetto
I cogeneratori sono disponibili con potenza elettrica da 5,5 a 401 kW elettrici e sono dotati di regolazioni digitali in grado di modulare il carico in funzione dell reale fabbisogno di energia. Tutti i componenti sono testati in fabbrica
Utilizzo. Il gruppo di microcogenerazione ha un rendimento complessivo pari al 96,4% ll microcogeneratore a condensazione raggiunge un’efficienza molto elevata ed è l’ideale per i nuovi impianti e per le riqualificazioni degli edifici esistenti

A sinistra:Vitobloc 200 EM-20/39, ideale per i casi di riqualificazione e per i nuovi impianti
Sopra: Microgeneratore Vitobloc 200 EM-20/39
Dati tecnici
Potenza 20 kWel, 39 kWth
Rendimento elettrico 32,2%
Rendimento termico 62,7%
Rendimento complessivo 94,9%
T di mandata ammessa dell'acqua di riscaldamento
min 60 °C - max 80 °C
T di ritorno ammessa dell'acqua di riscaldamento
min 40 °C - max 60 °C
Lunghezza 1920 mm
Larghezza 840 mm
Altezza 1305 mm
Peso a vuoto 900 kg
Livello di pressione sonora 57 dB(A)

VIESSMANN www viessmann it
Ewind Sky Line SL-10 / SL-30
micro turbina eolica ad asse verticale
Descrizione. Design, leggerezza, alto rendimento e facilità di installazione sono le caratteristiche principali delle turbine eoliche della serie Sky Line di Ewind che, grazie ai diversi livelli di potenza personalizzabile, consente di soddisfare una grande varietà di campi di applicazione sia in ambienti industriali sia in aree cittadine o rurali Le micro turbine sono realizzate con materiali tecnologicamente innovativi, in fibra di carbonio, e i loro punti di forza sono le dimensioni e i pesi ridotti

Dati tecnici SL-10
specifiche dimensionali
Diametro medio 2 m
Altezza 2 m
Peso 68 kg
specifiche materiali
Pale composito – fibra di carbonio
Braccetti alluminio
Alternatore alluminio – armatura
specifiche di funzionamento
Potenza nominale (12 m/s) 1000 W
Potenza massima 1200 W
Velocità di avvio 2 m/s
Velocità di inizio produzione 3 m/s
Max velocità del vento 42 m/s
Utilizzo. SL-10 con potenza di 1 kW è la turbina con il migliore rapporto potenza dimensioni che la rende adatta a qualsiasi tipo di installazione e ambientazione – anche su copertura in contesto urbano – ed è la soluzione ideale per utenze di medio e basso consumo anche per un utilizzo in serie SL-30 con 3 kW di potenza è stata ideata per coprire in maniera ottimale le necessità energetiche di utenze medio piccole, domestiche e industriali Utilizzata in serie, questa micro turbina può formare sistemi più grandi per sostenere le necessità energetiche di attività quali agriturismi, stazioni balneari, piccole e medie imprese, industrie, oltre a utenze private
Le micro turbine possono essere utilizzate anche in sistemi stand alone, immagazzinando l’energia in assenza di connessione alla rete di distribuzione e in abbinamento con moduli fotovoltaici per la realizzazione di sistemi ibridi.
Dati tecnici SL-30
specifiche dimensionali
Diametro medio 3,2 m
Altezza 3,5 m
Peso 190 kg specifiche materiali
Pale composito – fibra di carbonio
Braccetti alluminio
Alternatore alluminio – armatura specifiche di funzionamento
Potenza nominale (12 m/s) 3000 W
Potenza massima 3600 W
Velocità di avvio 2 m/s
Velocità di inizio produzione 3 m/s
Max velocità del vento 42 m/s

sistemi microgenerazione
SOLARE FOTOVOLTAICO
Emmeti Sun
sistema fotovoltaico
Descrizione. Il sistema Emmeti Sun è costituito da una serie di componenti di elevata qualità e affidabilità che soddisfano le esigenze e le richieste di questa tipologia di impianti Dai pannelli policristallini agli inverter, dai cavi ai supporti, ai kit di fissaggio, il sistema raggruppa in un’unica soluzione elementi innovativi e all’avanguardia
Il sistema produce energia pulita e consente di usufruire della rendita del Conto Energia che garantisce per 20 anni un incentivo fisso per ogni kWh prodotto A ciò aggiunge anche il guadagno derivante dalla vendita dell’energia prodotta, e immessa in rete, o dalla riduzione della spesa elettrica in seguito all’adozione del regime di Scambio Sul Posto, compensando l’energia elettrica prodotta, e immessa in rete, con quella prelevata dalla rete nazionale
Utilizzo. Emmeti Sun è composto da: moduli fotovoltaici, quadro di campo, inverter, contatore di energia prodotta, quadro di consegna, quadro elettrico generale contatore bidirezionale I moduli fotovoltaici possono essere installati su tetti piani, parzialmente integrati su tetti a falde (tegole, coppi, ondulati con lamiera grecata) e totalmente integrati su coperture inclinate


Dati tecnici
Modulo fotovoltaico policristallino EP1 230
Formato 1665x998 mm
Spessore 35 mm
Peso totale 20 kg
Telaio alluminio anodizzato grigio
Vetro prismatico temprato
Numero celle 60
Dimensioni celle 156x156 mm
Potenza nominale Pmpp 230 Wp
Tensione nominale Vmpp 29,55 V
Corrente nominale Impp 7,78 A
Tensione a vuoto Voc 37,98 V
Corrente di corto circuito Isc 8,41 A
NOCt 45,3 K
Garanzia prodotto 5 anni
Garanzia di rendimento al 90% 12 anni
Garanzia di rendimento al 80% 25 anni
Scambiatore Geotherm
sistema
con scambiatori geotermici
Descrizione. Geotherm con scambiatori geotermici compatti per il riscaldamento degli edifici e per la produzione di acqua calda sanitaria è un’innovazione tecnica brevettata e testata nelle rigide condizioni dei paesi del nord e rappresenta una soluzione ideale dove non sia possibile l’installare estesi scambiatori orizzontali, come ad esempio in giardini di piccole dimensioni, e un’alternativa alla perforazione, spesso costosa, per installare sonde verticali

GEOTHERM www geotherm it
I moduli sono realizzati in polietilene con altezza di 2 metri e lunghezza di 1,8 metri, sono posati a 1 metro dalla superficie e sono assemblati in serie tra di loro nella parte alta con giunti meccanici o saldati. Gli scambiatori compatti vengono collegati tra di loro in modo semplice, modulare e posizionati in orizzontale o di taglio in scavi accuratamente progettati a seconda delle caratteristiche termiche dell’abitazione e dello spazio a disposizione Grazie al design compatto si ottiene il massimo dell’output da un’area di scavo minima
Vantaggi Collegato alle pompe di calore geotermiche e a sistemi di recupero dell’aria viziata e/o a pannelli solari termici, il sistema è una soluzione che consente di ottenere grandi risparmi economici e un ambiente interno salubre e comfortevole
La connessione ad altri sistemi porta a uno scambiatore che si ricarica grazie al surplus di calore quando l’edificio non necessita di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, aumentando in modo significativo l’efficienza energetica

GEOTERMIA
approfondimenti dettagli di cantiere
VILLA DINA Vado (BO)
progettazione e ottimizzazione energetica ing. Paolo Veggetti (studio E2Project Engineering srl) geom. Piero Fortini
realizzazione 2011 Impresa Fortini srl
consumo da 415,1 kWh/m2 anno a 16,8 kWh/m2 anno
fotografie
geom. Piero Fortini


Un edificio in sasso ampliato negli anni ‘60 è stato oggetto di un retrofit energetico che ne ha significativamente ridotto i consumi. A partire da questo numero analizziamo nel dettaglio le soluzioni adottate.
Villa Dina, ubicata sulle colline dell’Appennino tosco-emiliano, è un fabbricato in sasso, ampliato con una struttura in c a e laterizio negli anni ‘60, dalla tipologia e dalle caratteristiche costruttive tipiche di queste zone dell’Emilia-Romagna L’intervento di riqualificazione energetica attuato presenta alcune possibili soluzioni per un ampio numero di costruzioni presenti in questa parte d’Italia e non solo Il retrofit energetico ha interessato sia l’involucro, con posa del cappotto e sostituzione di serramenti e scuri – prestando particolare attenzione ai ponti termici –, sia gli impianti La produzione di energia termica è demandata alla pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico e la produzione di ACS ai collettori solari; in questo modo la bassa richiesta energetica è interamente coperta da fonti energetiche rinnovabili I primi interventi effettuati sono stati dedicati all’eliminazione dell’umidità di risalita (con una barriera chimica e vetro cellulare a ridosso dei muri contro terra) e all’isolamento degli elementi a contatto con il terreno





UMIDITÀ DI RISALITA
Non essendo state previste adeguate opere di impermeabilizzazione delle fondazioni, l’edificio presentava seri problemi di risalita dell’umidità nei muri al piano terra Per eliminare tali fenomeni di risalita per capillarità o di ristagno lungo le pareti a diretto contatto con il terreno, non è sufficiente coibentare l’involucro edilizio, anzi: un alto tasso di umidità della struttura abbatte in modo sensibile la trasmittanza termica e quindi il raggiungimento dell’obiettivo energetico finale Si è dunque provveduto a risanare la muratura mediante barriere chimiche idrofobizzanti a base polisilossanica inserite a lenta diffusione : il liquido contenuto nelle sacche penetra nella muratura saturando i pori e i capillari e costituendo così una barriera all’umidità di risalita Prima della rasatura con intonaco di finitura si è completata la barriera con la stesura di una boiacca antisalina che chiude definitivamente il ciclo umidità/sali






FONDAZIONI E SOLAIO CONTRO TERRA
La coibentazione delle pareti contro terra è stata effettuata con ghiaia di vetro cellulare che offre, oltre a buone prestazioni termiche, anche una buona capacità drenante È stato eseguito uno scavo lungo la parete perimetrale a diretto contatto col terreno dentro cui è stato posato un telo di geotessuto, un tubo drenante rivestito in fibra di cocco e il vetro cellulare opportunamente costipato con rana meccanica Considerato, inoltre, che al piano terra dell’edificio erano presenti locali abitati e che le altezze degli ambienti erano sufficienti, si è intervenuti coibentando il solaio contro terra con pannelli di poliuretano espanso, sui quali sono stati posati pannelli in EPS con bugnatura per il supporto delle tubazioni del sistema radiante a pavimento Questa soluzione permette, infatti, di riscaldare anche la massa, risolvendo in maniera attiva il ponte termico in corrispondenza dell’attacco parete/solaio






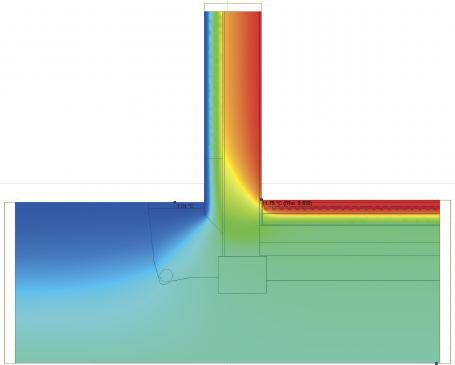
MURO ESTERNO E PONTI TERMICI
La parete esterna, tenendo conto del diverso comportamento dei materiali all’acqua, è stata coibentata nella parte più bassa con XPS (14 cm), che in parte è annegato nella ghiaia di vetro cellulare (circa 20 cm) utilizzata per la coibentazione della parte contro terra al fine di garantire continuità all’isolamento La parte fuori terra del pannello protegge la base del cappotto, evitando che la lana di roccia, utilizzata per la coibentazione in elevazione, assorba acqua Merita infine un approfondimento la risoluzione dinamica di un ponte termico critico quale l’attacco tra la parete esterna e il solaio contro terra Lo studio a elementi finiti ha evidenziato che anche con l’impianto spento la temperatura nello spigolo, grazie al vetro cellulare, all’XPS e all’isolamento interno con pannelli di poliuretano all’estradosso del solaio, è di 14,8 °C Con l’impianto radiante acceso , con una temperatura di mandata di 32 °C e una temperatura superficiale del pavimento di 27,9 °C (29 °C imposti da UNI 1264), la posizione più fredda raggiunge i 16,6 °C, valore molto vicino ai 17 °C richiesti nei punti più freddi, per esempio, per una CasaClima Gold
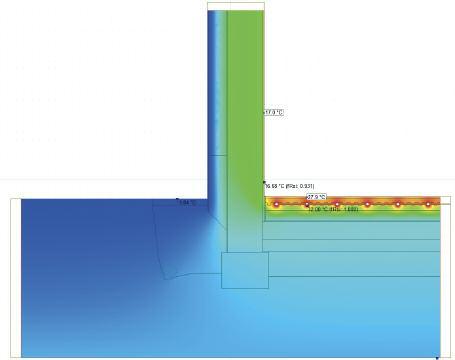
innovAzione Habitat Lab
HABITAT LAB
Un laboratorio per l’edilizia green
Promuovere un nuovo modello di edilizia attraverso un edificio in cui l’innovazione tecnologica per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, il benessere e il comfort si incontrano: è questo il concetto su cui si basa Habitat Lab, il nuovo centro e laboratorio di ricerca per l’edilizia del futuro realizzato a Corsico, alle porte di Milano, da Saint-Gobain Obiettivi principali del progetto sono stati l’isolamento termico per evitare dispersioni e attenzione al microclima interno e agli apporti solari, oltre all’uso di fonti energetiche rinnovabili e pompe di calore per migliorare le prestazioni energetiche del fabbricato Habitat Lab, che si estende per circa 1200 m2 all’interno dell’area industriale della divisione abrasivi della azienda, è il risultato di un’opera di ristrutturazione di un edificio esistente di circa 700 m2 e di una nuova edificazione di 500 m2 che ha richiesto due anni di lavoro e un investimento complessivo di 4 milioni di euro Questo spazio polifunzionale ospita lo showroom delle soluzioni e dei prodotti utilizzati per costruire l’edificio, tre sale riunioni, un ambiente dedicato agli incontri e alle pause di lavoro, strutture per le attività didattiche e spazi attrezzati per le dimostrazioni di applicazione dei prodotti È un edificio passivo, nonché classe energetica A+ Regione Lombardia, progettato per permettere l’autonomia energetica, calibrando ogni soluzione al fine di raggiungere le migliori prestazioni energetiche e di comfort
A rendere il Centro altamente performante è la quantità di sistemi integrati adottati per raggiungere gli obiettivi di risparmio stabiliti all’interno di un concept, Multi-Comfort Saint Gobain, un programma che tiene conto anche di tutta una serie di aspetti, quali l’acustica, la qualità dell’aria, la luce naturale e le prestazioni estive, garantendo agli occupanti ottimali condizioni di comfort e benessere.
L’involucro: prestazioni energetiche e comfort interno
Esterni
L’involucro opaco della parte oggetto di ristrutturazione è stato efficientato mediante la realizzazione di un cappotto da 20 cm in lana minerale a base di vetro riciclato e di una controparete interna, coibentata con 10 cm dello stesso materiale, portando la trasmittanza della parete a 0,11 W/m2K Stesso valore per la parete a secco adottata nel nuovo edificio ed esposta a est e medesima tipologia di cappotto messa in opera; in questo caso però la parete è isolata con un doppio strato di pannelli isolanti (20 cm spessore totale), di cui uno fissato a una lastra di cemento alleggerito, ed è finita all’interno con lastre di gesso rivestito La parete sud si compone di una struttura portante in laterizio, coibentata con 20 cm di lana di vetro esternamente, mentre all’interno è stata realizzata una controparete anch’essa isolata (10 cm) con controparete in gesso rivestito A ovest il prospetto è completamente trasparente con vetri di ultima generazione costituiti da unità a triplo vetro con lastra esterna che assicura un fattore solare di 0,24 e che scherma oltre il 75% del calore incidente; la lastra interna con trattamento basso emissivo alloggia uno strato in PVB (polivinilbutirrale) che garantisce le prestazioni acustiche La stessa tecnologia è stata adottata per i quattro lucernari che consentono di ottimizzare la luce naturale a vantaggio degli occupanti e le cui prestazioni meccaniche delle vetrocamere sono state aumentate per garantirne la sicurezza. La trasmittanza del vetro è di soli 0,6 W/m2K. L’elemento energeticamente predominante del Centro è sicuramente la copertura, vista la sua superficie (1200 m2), per la

Saint-Gobain, noto gruppo internazionale fondato nel 1665 e presente in tutto il mondo, produce e distribuisce materiali per l’edilizia sostenibile, per l’efficienza energetica e il comfort abitativo L’impegno nella ricerca è finalizzata alla creazione di soluzioni innovative dalle performance elevate e rispettose dell’ambiente.
Tutte le immagini e i disegni presenti in queste pagine sono di proprietà del Gruppo Saint-Gobain


Sopra, una vista dell’ingresso dell’Habitat Lab
A destra, la sala riunioni con i vetri elettrocromici
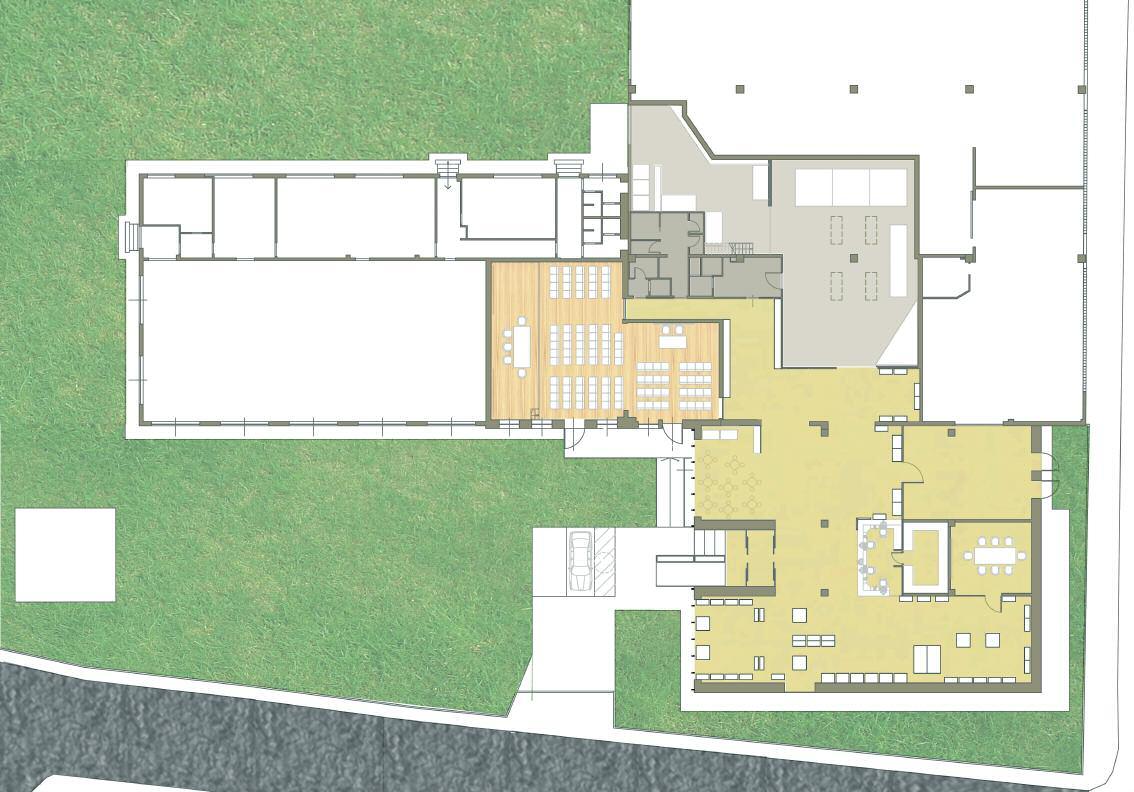
quale è stata prevista una coibentazione di 39 cm a base di isolante minerale in vetro riciclato, la cui struttura porosa con fibre dal diametro regolare intrappola l’aria fornendo isolamento termico e acustico. Oltre alla necessaria impermeabilizzazione, sul tetto è stata applicata una innovativa membrana ad alto indice di riflettanza solare, che riduce in periodo estivo la temperatura superficiale di circa 30°, contribuendo non solo ad abbattere i costi di raffrescamento ma anche a minimizzare l’effetto locale di isola di calore La trasmittanza ottenuta è inferiore a 0,09 W/m2K
Interni
Grande attenzione è stata rivolta alla qualità dell’aria degli ambienti interni, impiegando esclusivamente prodotti a ridotte, o nulle, emissioni di VOC per gli arredi, le tinteggiature o gli incollaggi Tuttavia, poiché tali accorgimenti potevano risultare non sufficienti per gli alti standard previsti dal progetto, tutti gli elementi in cartongesso (pareti divisorie e controsoffitti) sono realizzati con un additivo innovativo che consente di catturare il 70% della formaldeide presente nell’ambiente I divisori interni sono costituiti da una struttura metallica, il 30% più resistente all’ossidazione rispetto all’acciaio zincato, pannelli isolanti e finitura su entrambe le facce con lastre in cartongesso e pittura minerale, priva di VOC
Altro parametro fondamentale del progetto è da ricercarsi nella qualità acustica degli ambienti, attuata attraverso il corretto dimensionamento e scelta di tutte le soluzioni più idonee ad as-
sicurare ottime prestazioni in trasmissione del suono e il controllo dei tempi di riverbero negli ambienti A tal fine i divisori interni sono stati realizzati con tecnologia a secco, impiegando pareti a quattro lastre in gesso con interposto materassino in isolante minerale a base di vetro riciclato, una soluzione con un isolamento Rw pari a 58 dB che garantisce la privacy all’interno delle diverse sale, ma anche l’assenza di interferenze tra le differenti attività che il centro può ospitare in contemporanea
La sala conferenze è stata progettata impiegando un sistema costituito da un pannello in lana di roccia a elevato assorbimento acustico, decorato con una struttura in legno di faggio certificato PEFC e FSC, per l’esecuzione del controsoffitto La zona del palco è stata, al contrario, realizzata con materiali fono riflettenti, in modo da poter convogliare più efficacemente la voce dell’oratore verso la platea. Il risultato è un ambiente con una bassissimo rumore di fondo, in cui è possibile anche tenere conferenze per un centinaio di persone senza dover utilizzare i microfoni
La sala inoltre è divisibile in due parti – al di sopra della parete mobile è stato creato un setto acustico – e, considerato che la piccola superficie a soffitto disponibile in una delle due mezze sale non consentiva di ottenere i tempi di riverbero auspicabili, si è posato un sistema costituito da un tessuto in fibra di vetro, un pannello fonoassorbente a parete in lana di vetro ad alta densità dalle ottime proprietà acustiche rivestito da un tessuto che può essere personalizzato a seconda delle scelte di progetto (tempo di riverbero della sala conferenze 0,8 s)
Pianta dell’Habitat Lab.
1 ingresso
2 sala espositiva
3 sala applicativa
4 sala conferenze
5 area verde con piante autoctone
6 edificio esistente
pianta
Dimensioni di produzione Fattori
Spessore nominale (mm)
Peso (kg/m2)
Trasmittanza (%)
Riflettanza esterna (%)
Riflettanza interna (%)
Trasmittanza (%)
Riflettanza esterna (%)
Riflettanza interna (%)
Assorbimento A1 (%)
Assorbimento A2 (%)
Assorbimento A3 (%)
Fattore solare g
Coefficiente di shading

Sunlight
Aperture vetrate
Le grandi aperture vetrate della sala conferenze a sud, 30 m2 di superficie trasparente, suddivise in sei blocchi di serramenti a tutta altezza, sono attrezzate con vetri attivi elettrocromici, in grado di regolare la propria trasparenza luminosa e il proprio fattore solare in base alle condizioni esterne; la commutazione dallo stato chiaro allo scuro, e viceversa, avviene in cinque minuti, grazie all’uso di corrente a basso voltaggio (la trasmissione luminosa passa dal 63% al 2%) Tale tipologia di vetri permette di sfruttare al meglio gli apporti solari nelle stagioni e nei periodi freddi: in estate il caldo rimane all’esterno (fattore solare da 0,47 a 0,06) mentre in inverno si possono sfruttare gli apporti energetici gratuiti, grazie al valore solare variabile da 0,17 a 0,06 mediante sensori installati a bordo finestra, che consentono alle vetrate di autoregolarsi o di essere gestite in autonomia mediante pulsanti installati a parete Oltre a ciò, la migliore luminosità consente di ottimizzare il comfort visivo all’interno, a seconda delle condizioni esterne, senza tuttavia compromettere la trasparenza
Il laboratorio infine è separato dalla zona espositiva e di formazione da una parete vetrata, che garantisce ottimo isolamento acustico, sicurezza antinfortunio e antieffrazione, pur
Sunlight
S



lasciando passare il massimo della luce naturale, anche con vetri di grande spessore come questi
Impianti
La copertura ospita 3 campi fotovoltaici per una superficie lorda di 160 m2, posizionati in modo ottimale in relazione al rischio di ombreggiamento degli alberi lungo i confini del lotto per massimizzare la produzione di energia elettrica (orientamento d riferimento 30° sud)
I moduli fotovoltaici, per una potenza di picco di 19,87 kWp, sono in grado di generare 22 MWh di energia all’anno I moduli utilizzati sono di diversa tecnologia: in particolare, sono stati installati 42 moduli policristallini, 60 celle da 235 Wp, sul tetto piano, 43 moduli in silicio monocristallino, 24 celle da 93 Wp, integrati architettonicamente nel tetto a falda e 48 moduli a film sottile CIGS da 125 Wp in tre stringhe da 12 moduli sul tetto piano
Certificazioni
L’edificio nasce con lo scopo preciso di essere sostenibile a tutti gli effetti e pertanto si è scelto di certificarlo secondo il Proto-
In alto, a sinistra, i controsoffitti acustici sospesi nell’area relax Qui sopra, l’area espositiva delle soluzioni edilizie di Saint-Gobain per la sostenibilità
A sinistra, l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’Habitat Lab

Divisori interni - stratigrafia, dall’interno:
• Pittura ai silicati
• Lastra in gesso rivestito
• Lastra in gesso fibrato ad alta densità
• Pannello in isolante minerale (10 cm), idrorepellente, trattato con resina termoindurente, posato tra montanti metallici
• Lastra in gesso fibrato ad alta densità
• Lastra in gesso rivestito
• Pittura ai silicati
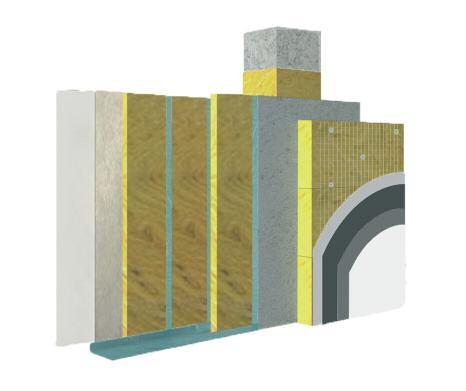
Parete est - stratigrafia, dall’interno:
• Pittura ai silicati
• Lastra in gesso rivestito
• Lastra in gesso fibrato ad alta densità
• Pannello in isolante minerale (10 cm), trattato con resina termoindurente e rivestito con velo di vetro su una faccia, posato tra montanti metallici
• Lastra in gesso fibrato, fibre cellulosiche e additivi minerali
• Pannello in isolante minerale (10 cm), trattato con resina termoindurente e rivestito con velo di vetro su una faccia, posato tra montanti metallici
• Barriera al vapore
• Lastra in cemento alleggerito
• Cappotto in isolante minerale trattato con resina termoindurente
• Rivestimento esterno ai silicati

Parete sud - stratigrafia, dall’interno:
• Pittura ai silicati
• Lastra in gesso rivestito
• Lastra in gesso fibrato ad alta densità
• Pannello in isolante minerale (10 cm), trattato con resina termoindurente e rivestito con velo di vetro su una faccia, posato tra montanti metallici
• Struttura portante in laterizio
• Cappotto in isolante minerale trattato con resina termoindurente
• Rivestimento ai silicati
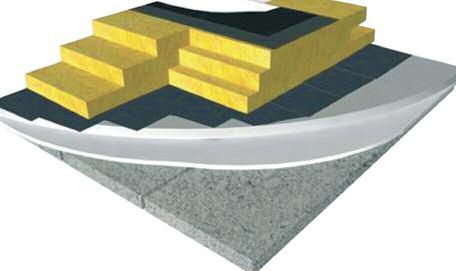
Copertura - stratigrafia, dall’interno:
• Controsoffitto acustico
• Struttura portante in c a prefabbricato
• Membrana bituminosa , polimero modificato
• Pannello isolante minerale (triplo strato) ad altissima densità, idrorepellente, trattato con resina termoindurente
• Membrana elastoplastomerica (BPP) con speciale armatura in lamina di alluminio goffrata, ad alto SRI in alternativa
• Pittura ceramizzata monocomponente per la riduzione della temperatura di superficie
Sotto, la colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici A destra, dall’alto: lavori di installazione della copertura fotovoltaica; un’immagine di cantiere della sala espositiva; lavori di posa dei controsoffitti nella sala Multicomfort.
collo volontario LEED con l’obiettivo di raggiungere il livello Platinum Per conseguire il massimo livello, sono stati curati moltissimi aspetti, tra cui ad esempio: - acqua: all’interno del centro sono stati realizzati due circuiti distinti per l’acqua, entrambi dotati di dispositivi per il risparmio idrico; il primo fornisce acqua potabile ai lavandini, alle docce e al bar, il secondo distribuisce acqua non potabile ai wc e al rubinetto dove si lavano gli attrezzi utilizzati nel laboratorio e nella sala applicativa; - verde: anche le specie erbacee e le essenze arbustive presenti nel giardino sono state scelte tra le varietà autoctone, che meglio si adattano al clima e non richiedono irrigazione, un modo semplice per risparmiare acqua senza rinunciare al verde; - mobilità: la sostenibilità di un edificio è data anche dall’utilizzo che se ne fa e dalla sua accessibilità Per questo, Habitat Lab è un edificio facilmente raggiungibile con la ferrovia e gli autobus ed è stato pensato anche per la mobilità del futuro: una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, così da rendere sostenibile anche il traffico automobilistico, è stata messa a disposizione degli ospiti Ma la forma di trasporto più ecologica sono le gambe degli uomini: per questo chi volesse raggiungere il Centro in bicicletta trova non solo una pratica rastrelliera per riporla, ma anche docce e spogliatoio per cambiarsi
Programma Multi-Comfort
Habitat Lab rispetta anche i parametri del Programma Multiconfort che Saint Gobain si è data a livello internazionale per i suoi edifici. Il Programma è focalizzato sulle dimensioni del comfort, secondo le diverse culture abitative e in tutti i tipi di edifici, sia di nuova costruzione, sia quelli oggetto di ristrutturazione L’attenzione è rivolta in particolare al comfort termico e acustico, al comfort dell’aria interna, al comfort visivo e allo sfruttamento dell’illuminazione naturale, alla facilità e sicu-




rezza di posa dei prodotti e alla bassa manutenzione nel tempo
I sistemi e le soluzioni adottate devono, inoltre, garantire sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica
Monitoraggio
Oltre a essere un Centro formazione, Habitat Lab è anche un laboratorio dove le soluzioni dell’azienda vengono testate in condizioni reali di utilizzo È una “macchina architettonica” controllata da un sistema di rilevamento domotico dotato di 26 sensori: i dati raccolti ogni 5 minuti vengono trasferiti al centro di elaborazione che trasforma le informazioni in grafici, resi visibili a dipendenti e visitatori su schermi ultrapiatti I sensori rilevano in tempo reale le prestazioni in termini di consumi, qualità abitativa degli ambienti, riduzione delle emissioni inquinanti monitorando: consumo energetico, illuminazione, acqua calda sanitaria, fotovoltaico, ricarica vetture elettriche, qualità dell’aria, concentrazione di formaldeide e di CO2, ventilazione Il monitoraggio consente anche di migliorare le prestazioni globali, essendo possibile variare i comportamenti di utilizzo dell’edificio da parte dei fruitori e rilevare la produzione del campo fotovoltaico e i consumi di qualsiasi linea elettrica

Sezione parete esistente della sala riunioni
Località di progetto: Corsico (MI)
Gradi giorno: 2404
Zona climatica:
E (> 2100 ≤ 3000)
Irradianza media mensile sul piano
orizzontale: 278,94
Parete esistentesala riunioni. Caratteristiche
della struttura:
Ti: 20 °C
Te: 1,7 °C
U R i: 65%
U R e: 86%
Vento: 1,2 m/s
Spessore totale: 625 mm
Resistenza totale: 9,15
Massa: 576,35
Trasmittanza teorica di calcolo della sezione: 0,109 W/m2K
Progetto
Committente Saint-Gobain Italia, Milano
Progetto/direzione lavori/strutture arch Davide Stroppa, Corsico (MI)
Termoidraulica ST studio termotecnico ass.to De Nardi-Bottari, Corsico (MI)
Acustica Saint-Gobain Italia, Milano
Fotovoltaico Saint-Gobain Italia, Milano
Impianto elettrico ing Berrini, Corsico (MI)
Appaltatore PR Color, Corsico (MI)
Lavori settembre 2011-settembre 2012
Superficie fondiaria 2 000 m2
Superficie utile 1.200 m2
Superficie verde 800 m2
Certificazioni Leed Certificate
Fornitore materiali costruttivi Saint-Gobain Italia, Milano
Fornitore impianti tecnologici Daikin
Fornitore Sistemi Domotici Schneider Electric
Fornitore serramenti Alvi System
INVOLUCRO
trasmittanza media elementi costruttivi
pareti esterne, U = 0,11 W/m2K
solaio contro terra, U = 0,23 W/m2K
copertura, U = 0,09 W/m2K
superfici trasparenti, Ug = 0,6 W/m2K
PRESTAZIONI ENERGETICHE
per riscaldamento, 1,1 kWh/m3 anno
(classe A+ Regione Lombardia)
emissioni di CO2 evitate rispetto a un edificio di pari cubatura in classe C, 63,7 CO2 t/anno