

MARCO CONTINI LA GIUSTA MISURA
Marco Contini
La realizzazione della pubblicazione è stata finanziata in parte dall’Azione 1.3.1 del Programma Regionale FESR 2021/2027 “Bando per il rafforzamento e l’aggregazione delle attività libero professionali”.
Questo libro, ”costruito” con immagini, disegni e testi vuole semplicemente testimoniare un percorso progettuale nel rispetto di luoghi, persone e comunità e forse… anche altro. Un ringraziamento a tutti gli amici, colleghi, collaboratori e committenti che hanno condiviso questo cammino ancora in corso.
M.C.
EdicomEdizioni
Monfalcone (Gorizia) tel. 0481/484488 e-mail: info@edicomedizioni.com www.edicomedizioni.com www.edicomstore.it
© Copyright EdicomEdizioni
Vietata la riproduzione anche parziale di testi, disegni e foto se non espressamente autorizzata. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e delle convenzioni internazionali.
Copertina: foto di Davide Galli
ISBN 979-12-81229-22-8
Questo libro è stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate
Stampa Press Up, Roma Prima edizione settembre 2025
LA GIUSTA MISURA
LUOGHI E LAVORO
RIUSI COLLETTIVI

Costruire adeguatamente
Giovanni Vragnaz
Non chiediamo di essere immortali. Chiediamo soltanto che le cose non perdano tutto il loro significato. Antoine de Sant-Exupéry
Il titolo di questa introduzione dichiara in modo diretto obiettivi e carattere del lavoro di Marco Contini e del suo studio: una sua analisi non può che originare da come concetti così generali concretamente assumano, e come essi siano in grado di descrivere, una posizione non usuale entro il panorama della cultura architettonica contemporanea. Una posizione la sua che porta a una architettura che è risultato di un percorso difficile, quanto può esserlo quello che conduce, nei suoi migliori risultati, a una architettura che non teme la “non autorialità”. Infine, l’incontro fisico, concreto, con la costruzione ordinata dalla sua razionale semplicità, spesso sembra capace di produrre una esperienza non attesa per come descritta dalle immagini. Questo può avvenire solo portando a coerente evidenza i suoi principi, indifferente a ogni spettacolarizzazione come a ogni ammiccante graziosità.
Costruire
Il progettare di Marco Contini ha avuto sempre chiaro, fin dalle prime esperienze, l’obiettivo primario della costruzione1, la consapevolezza del suo essere l’ovvio
1 Significativo al riguardo è stato il suo percorso scolastico: dopo la maturità scientifica, prima di iscriversi all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia ritiene utile ottenere un secondo diploma tecnico. Proviene altresì da una famiglia che ha una tradizione di impegno nelle costruzioni come tecnici e responsabili di cantiere. Anche Contini è convinto che “l’architettura serva per fare una cosa, non per dire una cosa”, lo si evince anche dalle parole a illustrazione dei suoi progetti, dove la coerenza fra principi generali e scelte costruttive appare stringente, logica e diretta: con tutta la prudenza necessaria per l’accostamento, essa ricorda il celebre “Avaro di sogni, concepisco come eseguissi (...) ciò che io faccio può essere fatto, e ciò che faccio è intellegibile ... “Eupalino o dell’architettura” di Paul Valery (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, Pordenone, 1988 p. 24.).
Nella citazione, oltre al “concepisco come costruissi” per altro molto nota, riporto qui anche le parole “Avaro di sogni... e ciò che faccio è intellegibile..”, che nel caso di Contini ritengo significativo essere mantenute indicando questioni cruciali che possono orientare la lettura del suo lavoro, nella relazione fra razionalità, semplificazione formale, trasmissibilità, condivisione e su cui questa breve presentazione vuole riflettere. La figura di Paul Valery, rinvia ad un momento della cultura francese che fu importante per coloro che furono i maestri della nostra generazione, a sua volta a loro trasmessa da una figura della rilevanza di E.N. Rogers.
obiettivo ma anche il fondamento dell’architettura2, che è fatto concreto prima di ogni scelta linguistica o spaziale.
La apparente ovvietà di questa affermazione va contestualizzata entro gli anni della sua (la nostra) formazione universitaria, quando l’insegnamento orientato dalle riflessioni teoriche in difesa dell’autonomia disciplinare spesso poneva in secondo piano la concretezza del fatto costruttivo, trascinato impropriamente entro la critica al “professionismo” quale manifestazione di una architettura svuotata a semplice espressione del mercato.
Il privilegiare un approccio all’architettura giudicata sulla base del risultato costruito e dell’incontro con la sua fisicità, non è mai stato indifferenza verso gli studi sulla città storica, riguardanti in primis il rapporto fra morfologia urbana e tipologia edilizia, sui quali si era alimentato il dibattito sulla forma della città e l’autonomia disciplinare.3
Anche attraverso lo studio di questo rapporto fra tipi edilizi, manufatto architettonico e forma urbana e gli studi sulla lettura del paesaggio, si vengono consolidando due fondamentali convincimenti che Contini dimostra di fare propri nel procedere del suo lavoro. La costruzione della città come del paesaggio sono fatti storici e collettivi per antonomasia e il loro permanere nel tempo è condizione necessaria per la sopravvivenza della loro ragion d’essere: scenario fisico delle vicende umane, testimonianza e al contempo veicolo del legame fra le generazioni.
Nella durata risiede quindi la condizione di senso dell’architettura: il costruire è atto primo contro il tempo.
Il termine costruire nella sua etimologia con-struere (con – assieme; struere – ammucchiare, raccogliere), oltre al significato del comporre con ragione più materiali verso un fine guidato dal progetto, sembra anche rinviare implicitamente all’azione di un gruppo, di nuovo di una collettività.
Adeguatamente
È evidente che l’avverbio “adeguatamente” associato al verbo costruire non è riferito esclusivamente alla dimensione costruttiva, esecutiva o economica delle opere qui presentate. Queste, per altro sono sempre oggetto di una cura particolare che vi appare evidente, condizione per ogni altro significato si voglia associare alle stesse. Ma l’adeguatezza è qui definizione ben più ampia, riferita alle diverse, molteplici e complesse attenzioni e campi di confronto che l’atto del progetto deve sempre considerare quando aspiri ad una forma dotata di senso civile e responsabile. Rinviare qui all’uso di una categoria come l’adeguatezza, rischiosa se non definito l’oggetto a cui applicarla, è certamente già giudizio sintetico sul lavoro di Contini: al contempo non è assente un contenuto critico nei confronti del mainstream dell’architettura attuale, “l’architettura nell’epoca dell’incessante”, della continua variazione formalistica, del diverso non necessario, del forzato tentativo di
2 cfr. Kennet Frampton: “Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture“ trad. italiana ”Tettonica ed architettura - poetica della forma architettonica nel XIX e XX secolo”. Si veda anche la introduzione e premessa al medesimo volume – entrambe rilevanti – di Harry Francis Mallgrave e Vittorio Gregotti.
3 Fra questi studi Contini si interessò prevalentemente a quelli maggiormente scientifici come quelli di Gianfranco Caniggia.

distinguersi in omaggio alle regole della comunicazione di massa. Disinteressata quindi alla, certamente oggi ardua, responsabilità alla durata.
Adeguatezza la cui etimologia è ad-aequare (eguagliare): quindi è in senso lato misura di un confronto ed è sinonimo di opportuno, idoneo (ad un uso, ad un sito, alle tecniche, ma anche di proporzionato, ecc.).
Siamo prossimi all’idea di modificazione, come, all’opposto, distanti da ogni soggettiva neo avanguardia, anche perché da tempo siamo consapevoli che le “condizioni sono cambiate”4
La prima forma di confronto per l’architettura rimane quella con il sito. Il lavoro di Marco Contini lo dimostra in modo continuativo ed esemplare.
Non è privo di significato che questo libro si apra con il più piccolo lavoro realizzato dallo studio, quello che però si misura con il contesto “più grande” (il paesaggio appenninico) e sia fatto di “quasi niente” e per questo rivelatore di scelte radicali e degno di attenzione.
L’ex ricovero dei pastori sull’Appennino tosco-emiliano, a Tufi d’Agna, isolato e difficilmente raggiungibile, come privo di ogni utenza, è stato sottoposto a una ricostruzione e restauro quasi filologico, modificandolo unicamente con l’aggiunta di un piccolo porticato (esemplarmente posto non in continuità fisica con la preesistenza), realizzato anch’esso con materiali reperiti sul luogo.
La trasformazione è minima in quanto protagonisti sono il luogo e il vasto paesaggio.
Le funzioni essenziali come l’acqua, l’energia, il riscaldamento, la depurazione, sono anch’esse risolte con i mezzi minimi e rispettosi in tutto dell’ambiente esistente: propriamente e autenticamente sostenibili.
Il manufatto esistente può apparire – superficialmente – architettonicamente poco significativo, ma lo diviene sia in quanto memoria delle fatiche che trasformarono e letteralmente costruirono il paesaggio circostante – in quanto cioè “colmo di tempo” – che in quanto elemento essenziale di un quadro più grande, che ne riceve un significato specifico. La prevalenza del sito e del paesaggio che impongono la semplice riproposizione del manufatto ribaltano la successione del procedimento progettuale.
4 Titolo dell’intervento di Bernardo Secchi in Casabella n. 498-499, 1994 numero dedicato alla “Architettura come modificazione”.
Piccolo rifugio in Appennino a Tufi d’Agna, Corniglio (PR)
Qui diventa evidente che gerarchicamente – e concettualmente – origine del progetto è il luogo e l’architettura che è già presente deve essere ri- progettata come parte di esso, subordinata alla scala più grande. Un atteggiamento di consapevole e perseguita modestia realizza un piccolo manifesto che affronta interrogativi disciplinari – sul tempo che ha a che fare con qualsiasi genealogia e archeologia del fare architettura – e globali, oggi imprescindibili – la necessità cioè di pensare al progetto come azione che innova e modifica conservando.
La sensibilità per i valori ambientali e l’impegno concreto per la loro conoscenza e quindi salvaguardia, è meditato e ben antecedente all’attuale mantra, politicamente corretto, ambientalista ed ecologista.
Nel lontano 1982 e ancora ai primi anni del corso di studi universitari, Contini propone e si impegna nella redazione di una “Proposta didattica attraverso la lettura del paesaggio”, rivolta alle scuole medie e realizzata con la supervisione di una figura della rilevanza di Lucio Gambi.5
La laurea con Vittorio Gregotti, nel cui corso diviene anche assistente all’IUAV per un anno all’inizio degli anni 90, appare quindi coerente con tale interesse e da Gregotti apprende, tra le altre cose, la rilevanza del rapporto fra architettura e scala geografica.6
Questo percorso culturale ha contribuito a far sì che relazione di immedesimazione affettiva, di empatia (Einfühlung) con un luogo o una geografia, si alimenti e si approfondisca la consapevolezza del suo significato, diventando materiale cosciente e operante per e nel progetto.
Analogo rapporto mi sembra si possa instaurare fra gli acquerelli che Contini con frequenza accompagna ai progetti, i progetti stessi e le architetture realizzate.
I primi fanno parte, con le sue parole, di “una relazione fluida e sfuggente dello spirito, in cui a volte è necessario immergersi”; poi il progetto con la sua realtà operativa, che è sempre anche strumento di conoscenza, mette a fuoco ciò che precedentemente era una suggestione, un’intuizione.
La “adeguatezza” delle relazioni da instaurare e considerare si declina in modalità diverse, ma il lavoro dello studio traccia un percorso che manifesta, da subito, una inusuale maturità e sicurezza.
Contini nel momento dell’accesso alla professione, ha già alle spalle, oltre che l’esperienza universitaria, tracciata con chiara consapevolezza, la tradizione familiare e l’esperienza del lavoro presso uno studio di ingegneria, dove comprende i modi della necessaria organizzazione professionale.
Subito dopo la laurea lavora dapprima presso la Gregotti Associati a Milano e successivamente collabora a Parma con Guido Canali – architetto già allora significativo – da cui riceverà importanti insegnamenti come l’attenzione necessaria al rapporto fra le diverse scale dell’architettura e alle preesistenze.
5 Lucio Gambi (1920-2006), ravennate, è ritenuto il più importante geografo italiano del secondo novecento. Intellettuale dall’alto impegno civile, con un approccio alla lettura del paesaggio che coniuga valori naturalistico-ecologici e umanistico-storici, rileva così il significato delle strutture territoriali nel lento lavoro di trasformazione degli uomini, rivolto ad adattare e trasformare i quadri naturali.
6 Gregotti, che è stato colui che con maggior insistenza e lucidità ha descritto il rapporto fra progetto di architettura e le condizioni storiche presenti, è stato anche come progettista “il maestro del 1:500” cioè della scala in cui si decide il “principio insediativo” il rapporto con il suolo e fra le parti della città e del contesto.

Nella costruzione di una ipotetica famiglia culturale di appartenenza, la figura di Mies van der Rohe è centrale, tanto di più in quanto la sua opera non è un diretto riferimento formale: l’interesse è per la lezione di rigore tipologico, il controllo di tutte le scale del progetto e in esso il ruolo del dettaglio costruttivo, sempre rilevante ma mai autonomo, come per la sua “linea di condotta”, di adesione alla tecnica, allo spirito del tempo: difendendo autonomia e significato del fatto architettonico nella pratica di una riflessione che è tettonica e come tale sovratemporale.
Ma autonomamente mi permetto di utilizzare un’altra figura, non casualmente oggi inattuale, certamente non lontana da Mies, per cercare di delineare alcuni dei caratteri delle opere di Marco Contini: quella di Heinrich Tessenow. Questo accostamento non riguarda assonanze figurative bensì caratteri non secondari dell’architettura di Contini, spesso non rilevabili dalle immagini fotografiche ma rilevabili in sito.
Per descrivere il lavoro di Tessenow si utilizzano parole come semplicità, onestà costruttiva, ordine, misura, infine, naturalezza e serenità. L’architettura di Contini sembra aspirare al raggiungimento di analoghi, difficili risultati, dove il cogliere “la giusta misura” è strumento primo e obiettivo (insieme a materia e luce).
La genericità di tale affermazione trova una più semplice, concreta, verifica nel progetto delle case d’abitazione, dove le giuste misure permettono la “abitabilità” non in senso tecnico ma in senso complessivamente percettivo.
Nella trasformazione del mulino di Chiastrone, oltre al rafforzamento della tesa geometria delle tracce nel sito come quella dei manufatti, il progetto, trasversalmente all’andamento di tale regola generale, porta a unità spazi interni e quelli non climatizzati, ma coperti, del lungo percorso.
Qui le scelte di misure sono evidentemente determinanti per giocare la partita –difficile – di garantire l’adeguata domesticità ai vani climatizzati garantendo la loro illuminazione attraverso il percorso – illuminato anche zenitalmente – così come le viste trasversali. Altezza dei vani, uso dei materiali, luce sono gli elementi messi in gioco, per giungere a un’atmosfera domestica, alla percezione di un tono, un carattere specifico e perseguito.
Ancora diverso è il caso della casa a patio di Monticelli, un edificio a un piano su un appezzamento orizzontale. Queste tipologie insediative sono solo apparentemente di semplice soluzione.
Recupero di edifici agricoli a Chiastrone, Langhirano (PR)


Qui il primo atto è stato quello di chiarire i caratteri tettonici, con la tesa copertura orizzontale, sottile nel limite del possibile e massimamente estesa, poggiante su setti murari del colore del suolo circostante. La copertura traccia un limite, un recinto rettangolare nel quale vengono ricavate tre corti che ne giustificano l’estensione. Il dispositivo spaziale caratterizzante è costituito dalla corte interna alla parte abitativa, che diventa una serra: perimetralmente a essa è possibile distribuire la casa, con il minimo sviluppo dei convenzionali corridoi.
La percezione dello spazio interno è filtrata e, contemporaneamente, orientata dalla presenza delle pareti vetrate della corte. Viste diagonali, quasi inaspettate per lo schema ortogonale che guida il progetto, dilatano lo spazio verso l’esterno, come le infilate visive dotate di una fonte di luce naturale alla loro estremità.
Il carattere complessivo della casa si manifesta con una preziosità non ostentata, un’aulicità legata all’altezza del piano come alla natura dei soffitti in legno, alle aperture che sono a tutta altezza, alla sezione – percepita oltre che reale – dei percorsi.
La lezione di Mies è certamente presente ma con minore, e qui nuovamente adeguato, esercizio di astrazione. La serra modula continuativamente la luce nell’arco del giorno. Le giuste misure fra i blocchi costitutivi l’attacco a terra dell’edificio modulano intimità e apertura verso il paesaggio.
La risposta ai caratteri dell’intorno assume modi sempre specifici. Il rapporto con il paesaggio agricolo o con la vastità delle viste verso la pianura, a partire dal comune desiderio di costruire architetture non invasive, va dalla ricerca di non interrompere la visione – come nella stalla di Tiorre, dove nascondere (la stalla preesistente) e salvaguardare la visione (del paesaggio) divengono gesti complementari, sottolineando l’orografia del suolo con il lungo corpo parallelo alle linee di livello – al privilegiare la trasparenza e la visione, come nell’edificio plurifunzionale a San Michele, che di fronte alla vastità del paesaggio della pianura padana si pone perpendicolarmente alle linee di livello, diventando così da lontano poco visibile, oggetto astratto ma che coglie la misura della sua collocazione in relazione agli allineamenti della casa preesistente. Qui il vedere dall’esterno (la collezione di auto d’epoca) e poi il vedere verso l’esterno, con la costruzione con la massima semplicità e coerenza strutturale di uno spazio proiettato verso l’amplissimo
Casa a patio a Monticelli Terme (PR).


paesaggio, sono complementari. La soglia segnata dal muro di sostegno del suolo che diviene, emergendo, parete interna, delimita un luogo orientato ed esclusivo contemporaneamente raccolto quanto proiettato verso il vuoto.
Speciale è altresì il caso dell’edifico sportivo a Parma, costruito vicino al torrente Parma e con collocazione vincolata dai campi di gioco preesistenti da proteggere; qui gli alberi del parco e il parco stesso in cui è inserito sono gli unici elementi con cui confrontarsi.
Una copertura ad arco con 85 metri di luce che per forma non sembra avere elementi che ne indichino la misura: scelta appropriata sia per le sue grandi dimensioni reali sia per il rapporto enigmatico che stabilisce con la natura circostante.
Un espediente apparentemente minimo trasforma una figura spesso adottata, quella propria delle grandi travi lamellari in legno (dai risultati abitualmente più che discutibili), in architettura: la trave non è visibile, essendo arretrata, ed emerge la sottile linea della copertura. Questo grazie una struttura di minori dimensioni che sostiene, collaborando con gli elementi verticali a cui sono collegati i serramenti, le travi secondarie delle copertura. La vetrata è resa opaca con un ulteriore espediente che consiste nel realizzare una vetrata isolante ove è interposta della lana di vetro. Ne consegue che la struttura dall’esterno non è trasparente e la vetrata assume consistenza, ma è garantita la trasparenza alla base. Dall’interno si evita l’abbagliamento e le strutture verticali esterne proiettano le loro ombre sulla superficie opalina così come, in alcune condizioni, emergono le trame degli alberi. Un’architettura che pare inevitabile nella sua logica, quasi una non-architettura, ma che per raggiungere tale pregevole risultato è meta di un lungo percorso.
Costruire e imparare nei centri storici
Il lavoro dello studio Contini ha dato un contributo, che è importante sottolineare, all’ampio e difficile tema dell’intervento nel tessuto dei centri urbani minori. A questo tema si affianca la – concettualmente contigua – ricerca di modi significativamente ordinati di espansione edilizia residenziale, in assenza di contesti dotati di caratteri forti: la condizione, frequentissima dell’intervento fra i vuoti lasciati dall’edificazione del recente passato.
Edificio multifunzionale a San Michele Tiorre, Felino (PR)
Struttura sportiva polivalente (PR).


L’importanza di tali esperienze è rilevante anche in proporzione alla scarso numero di esempi analoghi convincenti.7
L’assenza in Italia di esempi è anche dovuta a una oggettiva mancanza culturale e più specificatamente disciplinare, la quale, figlia ancora della nozione di espansione continua che proviene dalla storia stessa della modernità, non ha prodotto strumenti adeguati, urbanistici e architettonici e concettuali.
Nella piccola cittadina di Langhirano (comune di circa undicimila abitanti) e nel suo territorio, per una serie favorevole di coincidenze, Contini è riuscito ad applicare la sua capacità di lettura del tessuto urbano e delle emergenze storica in alcuni interventi limitati ma importanti anche per il loro portato metodologico.
A partire da uno studio urbanistico di scala ampia che si poneva l’obiettivo di ripristinare ove possibile il vecchio legame del centro storico con il torrente Parma, ragione stessa dello sviluppo del borgo grazie alle derivazioni idrauliche che ne alimentavano i mulini, Contini ha l’occasione di procede per interventi pubblici puntuali di riuso di manufatti esistenti (il vecchio macello convertito in centro culturale e uno spazio della produzione convertito in Museo del Cibo) ma anche di iniziativa privata.
Gli interventi privati di nuova edificazione e recupero originano da una lettura accurata delle stratificazioni storiche volta alla loro salvaguardia. La riproposizione di precedenti caratteri morfologici, come l’edificazione a corti aperte, i percorsi pedonali di attraversamento, i tracciati delle rogge: strategie che cercano di fondare il nuovo su antecedenti principi, quando nelle città la separazione tra spazi pubblici e privati era articolata e il passaggio graduale. Avvalersi di elementi stabili attraverso il recupero di manufatti significativi e riflettere con mestiere ed esattezza su rapporti oramai persi di scala e misura, dove lo spazio pubblico e le sue qualità orientano i singoli interventi: tutto ciò si manifesta e si trasferisce anche nei nuovi interventi nelle aree impropriamente definibili come “periferiche”. Contini sa come i tessuti storici dei piccoli borghi sono un valore e costituiscono un insegnamento ineliminabile per coloro che “sappiano vedere”.
7 Sono certamente condizioni strutturali a determinare tale realtà: frammentazione delle proprietà, stagnazione economica dei centri minori, assenza di strumenti urbanistici dedicati – entro un tramonto complessivo, in Italia, della disciplina stessa e, in primis, la scarsa volontà politica che sola può spingere verso un ambiente di qualità e più giusto, capace di rinnovare e correggere conservando.
Residenze con tipologie miste a Collecchio (PR).
Insediamenti residenziali a Langhirano (PR).
Le tipologie di case a corte e monofamiliari a Langhirano, e con tipologie miste a Collecchio, riflettono nuovamente sulla necessità di separazione dei percorsi meccanici da quelli pedonali, sulla omogeneità dei fronti strada, sulla privatezza dei cortili, sulla dignità necessaria dell’affaccio pubblico.
Le scuole
Lo studio Contini si è impegnato costantemente, negli ultimi anni, nella progettazione di edifici scolastici che sono particolarmente significativi anche in quanto espressione di alti risultati, architettonici, prestazionali e tecnologici in una battaglia costante con la scarsità delle risorse economiche disponibili. In questi lavori è stato di grande importanza per qualità professionale e personalità il contributo di Sara Chiari, architetto, socia dello studio e con un interesse particolare per le forme della didattica nel loro rapporto concreto con il progetto aprendo a modelli educativi non tradizionali quali le esperienze della scuola Waldorf. Essi raggiungono la dignità dovuta a un edificio pubblico anche ricercando sempre relazioni urbane che sottolineino delle scuole il ruolo di infrastruttura civile e di riferimento per l’intera comunità.
La loro semplicità di impostazione planimetrica, e la conseguente razionalità costruttiva e distributiva, come delle risultanti partiture dei prospetti,8 fanno si che la loro giustezza possa apparire evidente nella qualità degli spazi, nella loro adeguatezza d’uso per i piccoli utenti, nel rapporto con l’esterno, un rapporto d’uso ma anche visivo.
Nel Polo Scolastico di Felino il progetto si organizza su un percorso ciclopedonale che arriva dal paese e fa propria, con grande naturalezza, la necessità di essere realizzato per fasi, prevedendo, al suo completamento, la realizzazione di una grande corte, un recinto aperto che costruisce un luogo in un contesto debolmente caratterizzato. Gli spazi delle aule, entro la pacatezza del linguaggio complessivo dell’edificio, manifestano la loro eccezionalità nella quantità della luce e nella dimensione delle finestre, pensate per i piccoli utenti.9
Le scuole sono anche il campo di prova per l’adozione delle più avanzate, è sostenibili tecnologie, costruttive ed impiantistiche.
Nessuna utopia regressiva si accompagna al profondo legame con i luoghi, la loro storia e l’ambiente naturale, che Contini rivendica costantemente. Come ogni architettura significativa a noi contemporanea anche la sua è un equilibrio di tensioni, tanto più consapevolmente perseguito quanto meno appariscente.
8 Non deve apparire sorprendente ricordare come la (semplice) coerenza tipologica, strutturale e conseguentemente figurativa di questi edifici, fa sì che acquistino “involontariamente” forte identità entro il panorama architettonico attuale, dove a tutto ciò, con allarmante frequenza, si è volutamente indifferenti.
9 Rigore e pacatezza del linguaggio, disinteresse al manifestare attraverso lo stesso una dimensione autoriale del lavoro fino all’ascetismo, interesse per l’architettura minore, possono far aggiungere alla “famiglia spirituale” di cui sopra il nome di Giuseppe Pagano: architetto, editorialista e intransigente polemista (che infine “ha pagato di persona”), oggi sottovalutato. Non è privo di interesse, qui, il giudizio di G.C. Argan sulla nota mostra sull’“Architettura Rurale Italiana” del 1936 organizzata da Pagano stesso con G. Daniel. “Quelle forme non erano per lui, iniziali o primarie: erano il prodotto di una selezione secolare, la somma dell’esperienza di innumerevoli generazioni e sarebbe cosa poco corretta scorgere in questa intenzione sentita e profonda un qualsiasi effetto naturalistico, un tardivo primitivismo o “fovismo“ architettonico” in ”Progetto e destino”, Saggiatore, Milano, 1965 pagg. 229-234.

Le chiese e gli spazi comunitari
La volontà di perseguire, attraverso l’architettura, la costruzione di spazi comunitari, capaci di offrirsi ad attività collettive, si esprime massimamente nella progettazione delle chiese (a Varedo e a Castel di Lama) e delle opere parrocchiali a esse collegate. Alla scala urbana la qualità specifica di questi interventi è nella loro capacità di costruire degli ambiti architettonicamente definiti e diventare elementi di ordine e di riferimento di scala entro contesti preesistenti di scarsa qualità – come per Varedo – o di fondare nuovi elementi di urbanità – attraverso percorsi e spazi aperti – dove questa è assente, come a Castel di Lama, qui appoggiandosi e sottolineando la topografia del suolo.
A Varedo, la scelta della giusta misura nella dimensione e disposizione dei corpi delle opere parrocchiali, separate da corti aperte definite dal percorso vetrato di reciproco collegamento, permette di costruire, utilizzando anche le piantumazioni, un fronte che consolida il ruolo e la percezione della strada. Il corpo della chiesa che non poteva avere il proprio ingresso verso la strada e un parcheggio sul lato opposto, è rispetto alla stessa ruotato e definisce un sagrato non profondo. Una chiesa che ha nel battistero circolare la sua relazione visiva con la via e che con la sua pianta quadrata orienta e presidia il lotto. La pianta quadrata, ovviamente di antichissima ascendenza, ha in questa forma geometrica e nei suoi assi il registro a cui rispondono con rigore tanto assoluto quanto sottile tutti gli elementi presenti. Il quadrato dichiara il suo carattere ordinatore nel grande recinto sospeso (la memoria di una cupola?) rivestito in legno: la percezione delle “soglie interne” a questo spazio, definite dal grande quadrato sospeso, è legata prioritariamente alla misura della sua distanza dal pavimento e richiede di essere assolutamente “esatta”. Pur in presenza delle ferree regole geometriche che regolano tutti i rapporti dimensionali, la qualità della luce naturale come i caratteri tattili dei materiali producono infine uno spazio uno spazio indubitabilmente “sacro” ma “cordiale”, privo di ogni retorica.
A Castel di Lama un grande impegno pare essere stato rivolto come primo atto al misurarsi con il vasto e aperto paesaggio agricolo e a cercare il giusto carattere (le giuste misure) dello spazio del sagrato per rapporto alle dimensioni da affidare alla chiesa.
Il lungo telaio-porticato che conduce a unità la successione dei manufatti delle attività
Polo scolastico di Felino (PR).


parrocchiali, posto secondo le linee di livello del suolo, misura gli altri elementi. Esso costruisce e forza la lunga prospettiva che affianca la chiesa, da questo autonoma costruendo un cono ottico. L’assenza di elementi che possano definirne la misura reale è, ritengo, ricercata. L’alta porta della chiesa ha l’inusuale altezza del porticato: da lontano la chiesa appare più alta e grande delle sue dimensioni reali. In questi luoghi la luce è intensa: la scansione delle ombre verticali del porticato, ma soprattutto la soluzione del dispositivo della facciata della chiesa, gli rendono omaggio.
La chiesa appare in un equilibrio molto sofisticato fra elementi storici della millenaria tipologia ecclesiastica – solo evocati – e uno sguardo asciuttamente contemporaneo. L’interno è direzionato dall’asse maggiore del recinto ellittico “sospeso” che definisce lo spazio dell’assemblea, asse che si prolunga fino all’esterno nel giardino con il simbolico ulivo, e definisce gli orientamenti di tutto il complesso, portico e mura del sagrato.
Come in una chiesa barocca non c’è corrispondenza diretta fra interno ed esterno e il tema – storico – dell’articolazione per profondità della facciata attraverso la luce – come nelle facciate gotiche – trova qui il suo corrispettivo nella facciata di ombre proiettate dalle lastre marmoree appese al telaio metallico.
Ma un ulivo appare nello spazio che intercorre fra murature della chiesa e telaio delle ombre, mettendo in crisi ogni schematismo accademico.
Le sofisticate strategie messe in atto a Castel di Lama e negli altri progetti vengono, nel lavoro di Contini, da lontano, a cominciare dal piccolo e delicato lavoro del Giardino per l’infanzia nel piccolo borgo di Gaiano, a Collecchio, in provincia di Parma, una delle sue primissime opere.
Qui si manifestano proprio per la natura limitata e quindi più libera dell’incarico, attenzioni e strategie che, approfondite e arricchite, diventeranno ricorrenti nel suo lavoro, ma qui già descrivono un’atmosfera e carattere che rimarranno riconoscibili. Attenzione al paesaggio, ma anche alla qui fragile e per questo ancora maggiormente cruciale natura della soglia fra costruito e natura, riflessione e rispetto per le tracce rinvenute, che sono qui minime ma significative.
Ma soprattutto questo piccolo lavoro dimostra, programmaticamente, una particolare attenzione per la percezione alla scala e misura dei bambini e alla loro esperienza sensoriale nei confronti dello spazio costruito. O molto più
Chiesa e centro parrocchiale a Varedo (MI). Chiesa e centro comunitario a Castel di Lama (AP).


semplicemente per come ci si possa divertire nel nascondersi, vedere attraverso, passare soglie e fessure, costruire recinti immaginari o percepirli, vedere e intravedere, sbirciare e nascondersi, toccare la terra e l’erba. I recinti aperti realizzati da muri mai invalicabili sono pensati per il gioco dei bambini e alla loro scala, che è non solo visiva ma anche sensoriale. Come sono al contempo dispositivi semplici, che lasciano autonomia e spazio all’immaginazione.
Questo lavoro delicato e quasi poetico, per come i muri appoggiano nell’erba, per come il passaggio dal percorso pavimentato all’erba sia controllato e graduale, e che non è mai occasione di narcisistici particolari esecutivi, ha valore esemplare e va posto insieme e parallelamente al piccolo rifugio di Agna che apre questa presentazione. Esso indica infatti in modo chiaro una ricerca che Contini ha consapevolmente perseguito e che – pur essendo propria di ogni buona architettura – è la stazione finale e misura importante della sua “adeguatezza”: la nostra reazione all’esperienza concreta, sensoriale, dell’architettura.
Una esperienza “che la critica architettonica ha espulso da quasi tutte le teorie del significato in architettura. (...) come fosse un fenomeno interamente concettuale. (...) All’interno di questa linea di pensiero il corpo e la sua esperienza non partecipano affatto alla costruzione e alla realizzazione del significato in architettura”10.
Un’attenzione che prescinde dalle scelte definite propriamente di “linguaggio architettonico”.
Un lavoro, quello di Contini e dei suoi collaboratori, certamente difficile in quanto collocato sulla linea sottile che divide la nobile semplicità dalla semplificazione, la raggiunta e ricercata pacatezza e cordialità dalla banale consuetudine. Una architettura sobria11 che riesce a non essere mai retorica o afasica, come nel minimalismo ridotto frequentemente a comoda cifra stilistica. Il “saper rinunciare” di cui ci parlava Wittgenstein12 si esprime, con esemplare chiarezza, nel trattamento
10 Scott Gartner, manoscritto inedito citato in K. Frampton, op cit. pagg. 29-30.
11 Il rinvio immediato è all’appartenenza a quella tradizione della migliore architettura razionalista italiana e al suo “orgoglio della modestia”. Si rinvia al breve testo di G. Pagano “Una lezione di modestia”, ora in Cesare de Seta, “Architettura e città durante il fascismo”, pag. 155, originariamente in Casabella, n. 111, 1937. Ma ritengo che Marco Contini non sia indifferente al dibattito che si anima intorno ad una necessaria “nuova sobrietà”, scelta obbligata di fronte alla crisi, in primis ambientale. Cfr. ad esempio, in “La sobrietà come nuovo stile di vita“, Arcisolidarietà Toscana, 2010.
12 “La differenza fra un buon architetto e un cattivo architetto consiste oggi nel fatto che quest’ultimo soccombe ad ogni tentazione, mentre l’altro le resiste”.
Giardino per l’infanzia a Gaiano, Collecchio (PR).
dei dettagli esecutivi: di fronte alla costante attenzione nella scelta delle tecnologie più opportune per il caso specifico non c’è mai il così frequente oggi indugiare sul particolare, sui giunti, come occasione espressiva, sorta di risarcitorio virtuosismo a debolezze globali.
Molti anni fa avevo intitolato un breve testo su Contini “La provocazione della semplicità”, ricordando il paradosso dell’accostamento, non essendoci architettura meno “provocatoria” di quella di Marco. Prevale in essa, invece, il senso della misura, cioè il suo “essere misurata” in senso materiale, metrico, dimensionale di controllo percettivo ma anche – e soprattutto – in senso etico.
Nella lingua italiana l’“essere misurati” indica infatti anche un modo di comportamento fondato sull’attenzione, sull’equilibrio, sulla discrezione verso le persone: per noi architetti anche verso i luoghi e la loro storia. E sottolineavo accanto a questo doppio significato della parola tale “necessità della misura”13. Da allora il lavoro suo e del suo studio non ha cambiato rotta, come è stato dimostrato: si è specificato nei singoli casi e ha acquisito in profondità e chiarezza data dall’esperienza.
La pacata serenità che traspare dai progetti esprime anche la rara costanza e sicurezza di un percorso.
La griglia interpretativa, certamente parziale e tendenziosa, che orienta questo breve testo e che si è focalizzata sul rapporto di Marco Contini con un paesaggio naturale – che è il suo ed è un paesaggio amato –, sui caratteri della architettura, sull’impegno civile e l’attenzione ai luoghi come nel disegno di spazi comunitari, sulla attenzione per l’adeguatezza in tutte le sue forme, sul valore della semplicità come obiettivo finale di un percorso di progetto e sua forma di trasmissibilità, ha, infine, nel tema problema e interrogativo sulla “durata”, l’elemento che tutti li lega. Molto del significato è legato alla dimensione temporale, cioè della responsabilità verso il futuro come della risposta e del dialogo con il passato.14
“Nella grammatica stessa del progetto è iscritto il desiderio della durata (...) l’aspirazione alla persistenza nel tempo esprime la tensione che è propria di un progetto che immunizzi rispetto alla contingenza, all’intermittenza, alla deformazione, percepite come disvalore, perdita e dissipazione rispetto il desiderio categorico di forma”.
Ma la riflessione genera una domanda, ai tempi dell’architettura dell’incessante: vi è oggi spazio per una responsabilità della durata? “Vi sono molte ragioni per ritenere che questo spazio sia terribilmente esiguo, quando non letteralmente indisponibile (...) La filosofia e l’architettura, nella forma della consapevolezza ai tempi della società liquida ci dicono che l’esito suggerito è arduo. È molto difficile.
Ma da nessuna parte sta scritto che esso sia, per questo, impossibile.”15
13 “La provocazione della semplicità” in “Piranesi” autunno 2015, n. 36 vol 23, pagg. 86-93.
14 Questo doppio vettore di responsabilità verso il passato e proiezione verso il futuro, che comprende anche la necessità di consapevoli scelte di campo entro la “tradizione del nuovo”, è stato veicolato dall’insegnamento universitario che fu impartito alle nostre generazioni. Ricordarlo, anche per la sua genericità, può apparire superfluo, se non per un utile confronto con l’attuale insegnamento universitario.
15 Salvatore Veca, in “Festschrift per gli ottant’anni di Vittorio Gregotti” pagg. 282-284.

Parma
Fidenza
Felino
Collecchio
Langhirano
Corniglio
Nido d’infanzia e centro bambini e famiglie, Sorbolo
Campus scolastico, Sorbolo
Struttura sportiva polivalente, Parma
Residenze con tipologie miste, Collecchio
Giardino per l’infanzia, Gaiano
Casa a patio, Monticelli Terme
Polo scolastico, Felino
Edificio multifunzionale, San Michele Tiorre
Costruire per un territorio
Marco Contini
La maggior parte dei progetti presentati in questa pubblicazione sono collocati all’interno o in prossimità dell’Appennino parmense, parte di una zona più ampia dell’Appennino tosco-emiliano riconosciuto recentemente come MAB Unesco e all’interno dei cui confini sono situate le aree emiliane dell’Appennino parmense e reggiano e quelle toscane della Lunigiana e Garfagnana, storicamente legate da percorsi e attività di scambio economiche e culturali.
La presenza di una forte economia agroindustriale, con due prodotti tipici quali il prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano, assicurano a questo territorio una solida base economica, grazie anche all’indotto in altri settori come l’edilizia e l’industria meccanica.
Queste economie, insieme alla viticultura, hanno influenzato e modellato il paesaggio della prima fascia appenninica: la produzione del parmigiano con il suo habitat di foraggere, quella del prosciutto con il consolidarsi di centri di produzione con i caratteristici edifici lungo l’asta fluviale, la viticultura con la piantumazione a vite di ampie zone del territorio collinare.
Riqualificazione del borgo alto del castello di Torrechiara
Recupero e riqualificazione nel borgo basso di Torrechiara
Ampliamento cantina vitivinicola, Casatico
Edificio commerciale, Langhirano
Museo del cibo, Langhirano
Centro culturale e biblioteca, Langhirano
Residenze monofamiliari, Langhirano
Case a corte, Langhirano
Insediamenti residenziali, Langhirano
Ampliamento del camposanto, Castrignano
Recupero di edifici agricoli, Chiastrone
Montagna
Piccolo rifugio in appennino, Tufi d’Agna
Centro culturale, Berceto
Polo dell’infanzia, Berceto
Restauro e valorizzazione dell’area archeologica del Castello, Berceto
Ostello per i pellegrini, Berceto Costruzione
La parte montana del territorio, ricca di insediamenti e percorsi storici, ha invece subito durante gli anni un processo di progressivo spopolamento a favore della pianura, fenomeno riscontrabile in quasi tutti gli ambiti montani italiani. Questo territorio è il luogo-laboratorio in cui lo studio ha realizzato, nelle sue fasi iniziali, la maggior parte dei progetti quasi come una serie di esperimenti su temi che fanno parte della normale attività di uno studio di progettazione: la casa singola, la cantina, le residenze accorpate, l’edificio agricolo, ma anche edifici pubblici come scuole e centri civici o piani di recupero urbanistico.
Il vivere e operare all’interno di un territorio in cui la stratificazione storica del paesaggio è percepibile e intuibile praticamente in ogni luogo aiuta, se si è attenti e disponibili, ad agire alla ricerca della giusta misura per ogni progetto con la consapevolezza che la costruzione è, contemporaneamente, un segno all’interno di questo paesaggio sempre mutevole e un luogo di osservazione del paesaggio così come è venuto a formarsi.
La conoscenza della geografia dei luoghi e della loro storia è una discriminante che noi tendiamo a considerare in ogni progetto e ne assicura in qualche modo il fondamento, l’essere parte del territorio.
D’altra parte, è nella storia dell’architettura che possiamo osservare quanto il rapporto con l’ambiente abbia influenzato le soluzioni tipologiche e insediative degli abitati, oltre alle tecnologie costruttive. È per questo che contestualizzare l’idea di sostenibilità è oggi quanto mai necessario per chi agisce con l’architettura.
Pianura
Collina
NATURA

Piccolo rifugio in Appennino
Tufi d’Agna, Corniglio, Parma
Questa realizzazione è situata a Tufi d’Agna, un piccolo nucleo abitato nel comune montano di Corniglio, all’interno dell’Appenino tosco-emiliano. Il piccolo edificio, un fabbricato rurale un tempo destinato al ricovero dei pastori e degli animali, è stato recuperato come “rifugio” il cui l’uso abitativo, considerata la posizione isolata e le difficoltà per il suo raggiungimento, è saltuario e per poche giornate consecutive. Per raggiungere l’edificio dal piccolo centro abitato è infatti necessario percorrere a piedi a una stretta carrareccia, che si inoltra nel bosco, seguendo l’andamento orografico in forte pendenza. Originariamente al piano terra del fabbricato era collocata la stalla mentre al piano superiore il fienile era usato anche come dormitorio dai pastori.
L’edificio versava in uno stato di forte degrado, in special modo le parti lignee della copertura, soggette a dilavamento per le condizioni precarie del manto.
La condizione di isolamento, anche rispetto alle reti impiantistiche, ma con la disponibilità di acqua sorgiva e di legname del sottobosco, ha portato a scelte in cui gli obiettivi di sostenibilità sono stati raggiunti mantenendo i caratteri originari dell’edificio e utilizzando tecniche di recupero e materiali tradizionali, integrati con le sole e necessarie componenti tecnologiche, al fine di conservarne l’aspetto di semplice costruzione rurale isolata nella radura del bosco.
Allo scopo di rendere autonomo dal punto di vista energetico e impiantistico il rifugio sono stati utilizzati pannelli fotovoltaici collocati sopra la copertura del portico ligneo, integrati con due accumulatori alloggiati nel locale tecnico. Questo sistema garantisce completa autonomia fornendo l’energia elettrica necessaria per l’illuminazione e quella termica per l’acqua calda.
Il riscaldamento avviene tramite un’adeguata stufa a legna; l’approvvigionamento idrico per le esigenze sanitarie è garantito da una vasca d’accumulo collegata a una sorgente, mentre il sistema di smaltimento delle acque reflue utilizza un impianto di fitodepurazione.
Il prato circonda ovunque il fabbricato, l’unica area pavimentata con lastre di pietra si trova sul lato ovest in corrispondenza del nuovo porticato realizzato con tronchi di legno.
Nei pressi dell’edificio è stata collocata anche una piccola centralina metereologica, alimentata da celle fotovoltaiche, che permette a chiunque di conoscere le condizioni del sito attraverso una semplice connessione internet.






STRUTTURE VERTICALI
Muratura in sasso consolidata con cuci scuci e stuccatura in malta, cordolo perimetrale superiore in calcestruzzo armato
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimentazione in piane
Sottofondo 10 cm
Soletta in c.a. 20 cm
Vetro cellulare 20 cm
SOLAIO PIANO PRIMO
Doppio assito in legno di rovere 3+3 cm Travetti in legno 10x14 cm
SOLAIO DI COPERTURA Lastre in ardesia
Listello e controlistello in legno 4+3 cm
Guaina impermeabile Tavolato in legno 2 cm
Isolante in Celenit 16 cm Freno al vapore
Tavolato in legno 2.5 cm Travetti in legno 10x12 cm
SOLAIO LOCALE TECNICO
Pannelli fotovoltaici
Listelli e controlistelli in legno 5+5 cm
Guaina impermeabile
Soletta in c.a. 25 cm


Ampliamento del camposanto
Castrignano, Langhirano, Parma
Il cimitero di Castrignano è situato su una costa del primo Appennino parmense, caratterizzata dalla presenza di ampie zone a bosco ceduo e dai resti delle fortificazioni di un castello medievale, su cui è oggi presente una chiesa del sedicesimo secolo.
Il vecchio cimitero, nonostante gli ampliamenti sui due lati più corti, si presenta con le caratteristiche del “campo santo” con i due muri di recinzione in sassi ancora esistenti; inoltre, per la sua collocazione altimetrica è un luogo privilegiato per l’osservazione del paesaggio circostante.
Il progetto cerca di mantenere inalterata l’attuale percezione interna del cimitero nascondendo l’ampliamento dietro al muro di recinzione a sud.
L’ampliamento è caratterizzato da una serie di otto elementi volumetrici, che raggruppano otto loculi ciascuno, serviti da un corridoio la cui quota di calpestio è ribassata di circa un metro e sessanta rispetto alla quota del vecchio cimitero. Particolare attenzione è stata rivolta allo studio del prospetto lungo la strada di accesso, riprendendo l’allineamento visivo con i resti del bastione del castello e caratterizzando il sistema di affaccio con un’alternanza di volumi e vuoti.
La struttura dei volumi è formata da setti in calcestruzzo armato ancorati alla roccia tramite micropali. Il cemento è lasciato a vista con diverse finiture. Un rivestimento in sassi reperiti sul luogo caratterizza il basamento dei volumi verso strada.





Struttura sportiva polivalente
Parma
Il progetto si colloca all’interno di un’ampia zona sportiva, situata lungo le sponde del torrente Parma in un’area di notevole pregio ambientale prospiciente il centro della città.
Questa condizione privilegiata è stata motivo di riflessione lungo tutto l’iter progettuale, nella definizione delle scelte dimensionali e nell’uso dei materiali costruttivi.
Il luogo, pur situandosi all’interno della città, ha infatti una sua forte autonomia, quasi ad appartenere più alla naturalità del greto fluviale che alla regolarità della maglia urbana.
L’intervento riguarda la copertura e la riconversione di una pista di pattinaggio esistente con al centro un campo da hockey, in pista per atletica indoor e in un campo utilizzabile per differenti attività sportive (hockey, pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano). Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di ridurre la presenza visiva del nuovo volume verso l’esterno pur ottenendo all’interno dimensioni regolari per tutte le attività previste. La struttura ad arco ribassato, la collocazione dei montanti in legno verso l’esterno e l’uso di vetrate non riflettenti ma opacizzate contribuisce a raggiungere questo obiettivo, armonizzando il grande volume con la natura circostante.
Il progetto si caratterizza per l’uso di una struttura di copertura in legno lamellare formata da cinque travi ad arco con una lunghezza complessiva di circa 85 metri dagli appoggi e un’altezza massima di 12 metri da terra. Gli archi appoggiano tramite piastre metalliche su una serie di setti in cemento armato.
Le grandi pareti verticali che definiscono i fronti dell’edificio sono formate da una struttura in alluminio con montanti e traversi resi solidali ai montanti in legno lamellare collocati verso l’esterno. Sulla struttura in alluminio sono collocate le pannellature in vetro: i vetri sono trasparenti fino all’altezza di 3,75 metri per tutto il perimetro dell’edificio, mentre alle quote superiori si è utilizzato un vetrocamera con all’interno uno strato di lana di vetro al fine di ridurre l’abbagliamento e il fattore solare e nello stesso tempo ottenere un piacevole effetto di diffusione della luce. Questa soluzione favorisce all’interno la pratica delle attività e una relazione visiva con l’esterno lungo tutto il perimetro della pista di atletica.


LUCERNARIO
Lamiera di chiusura
Controlistello per appoggio lamiera 4x4 cm i: 100 cm
Lamiera grecata preverniciata 0.6 mm
Listoni di contenimento 6x8 cm i: 66 cm
Guaina impermeabile posata a freddo
Coibentazione in lana di roccia 5 cm
Barriera al vapore
Pannelli in legno
lamellare a tre strati sp. 4.2 cm 226x500 cm
Lamiera di rivestimento 6 mm
Serramento in acciaio apribile elettricamente per ricambio aria
COPERTURA
Lamiera grecata preverniciata 4 cm
Controlistello per appoggio lamiera 4x4 cm i: 100 cm
Listoni di contenimento 6x8 cm i: 66 cm
Guaina impermeabile
Coibentazione in lana di roccia 5 cm
Barriera al vapore
Pannelli in legno lamellare a tre strati sp. 4.2 cm 226x250 cm
Trave curva in legno lamellare di abete
H. 200 cm sp. 22 cm
Setto in legno lamellare 50x12 cm
VETRATA OPACA
Serramento facciata continua in alluminio con montanti e traversi
Vetro float dello spessore 4 mm
Lana di vetro bianca 1.5 mm
Vetro float dello spessore 4 mm
Intercapedine con aria disidratata 12 mm
Gas argon termico
Vetro float basso emissivo 4+4 mm
Frangisole a lamelle di alluminio
estruso inclinate a 50°
VETRATA TRASPARENTE
Serramento facciata continua in alluminio con montanti e traversi
Vetro interno stratificato float 5+5 mm
Intercapedine con aria disidratata 16 mm
Vetro esterno 8 mm temperato
PAVIMENTAZIONE INTERNA
Pavimento vinilico sportivo/ legno massello 1 cm
Massetto autolivellante ad alta resistenza e tubazioni in polietilene per pavimento radiante 4.5 cm
Barriera al vapore
Pannelli isolanti in XPS 8 cm
Soletta in calcestruzzo esistente
0 50 100 150 cm


PAESAGGI DOMESTICI

Recupero di edifici agricoli
Chiastrone, Langhirano, Parma
La località “Chiastrone” è da sempre legata alla presenza del mulino di Chiastrone-Cattabiano risalente alla prima metà del Cinquecento. Nel territorio comunale langhiranese, caratterizzato dalla presenza del torrente Parma e dall’abbondanza di acque e canali, il numero dei mulini è sempre stato piuttosto elevato: essi erano collocati tutti vicino al torrente Parma, su canali più o meno lunghi derivati da esso, in modo da permettere la regolarizzazione del flusso delle acque.
Per quanto riguarda i due edifici rustici oggetto di ristrutturazione, un fienile e un piccolo mulino con annessa abitazione, si può dedurre dalle cartografie storiche che la loro costruzione sia da collocarsi tra fine Ottocento e inizi Novecento. In considerazione della storia e della natura del luogo, il progetto si è proposto, fin dall’inizio, di salvaguardare le principali caratteristiche ambientali, intervenendo in modo da renderli adeguati all’essere abitati, ma conservandone i caratteri planivolumetrici, i materiali di facciata e di copertura e la modularità e la linearità dei prospetti. Sì è perseguito l’intento di una relazione con gli elementi principali dell’ambiente attraverso una percezione continua fra gli interni e gli esterni, le pietre e il legno, il portico e il fiume.
In questo recupero è stato utilizzato il legno di rovere sia per le ampie coperture che per le pareti di tamponamento, per i solai, per la struttura delle scale e per gli arredi e i serramenti realizzati su nostro disegno.
Nelle parti esterne in forte relazione con gli edifici, si è intervenuti semplicemente recuperando la vegetazione esistente e consolidando le murature in sassi che accompagnano i canali.
Il fienile ora abitazione principale
Il grande spazio interno coperto che funge da passaggio, caratterizza tipologicamente questo edificio e la sua distribuzione. Il progetto accentua la sua importanza con i grandi tamponamenti rivestiti in tavole di rovere che dividono l’interno dall’esterno. Gli spazi abitati collocati nella parte sud si affacciano contemporaneamente sul giardino e su questo percorso, permettendo una continua relazione visiva fra le varie parti sia al piano terreno sia al piano superiore.
Il mulino ora casa per gli ospiti
L’edificio mantiene sostanzialmente la propria originaria destinazione residenziale oltre che i principali caratteri distributivi e formali, le aperture nei fronti murari, la pietra a vista, la copertura in coppi. All’interno dell’edificio, in corrispondenza dell’ingresso, è stato riportato alla luce il canale che alimentava la macina del mulino.







SOLAIO DI COPERTURA
Manto in coppi
Lastra sottocoppo tipo onduline
Controlistello 40x40 mm
Intercapedine ventilata
Guaina impermeabile traspirante
Assito 25 mm
Isolante 12 cm
Barriera al vapore
Assito 25 mm
Travetto 100x120 mm
SOLAIO PIANO PRIMO
Pavimento in legno 15 mm
Riscaldamento a pav. con massetto 65 mm
Strato isolante in polistirene 30 mm
Membrana anti-calpestio
Sottofondo alleggerito per impianti 65 mm
Soletta in cls con rete 60 mm
Tavolato in legno 30 mm
Travetti in legno 120x160 mm
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimentazione in calcestruzzo 5 cm
Ghiaia stabilizzato 10 cm
Guaina impermeabile
Massetto con rete elettrosaldata 10 cm
Vetro cellulare 20 cm
Tessuto non tessuto
SOLAIO TERRAZZO
Pavimento 15 mm
Massetto cementizio 65 mm
Strato isolante in polistirene 100 mm
Soletta in cls con rete 60 mm
Tavolato in legno 30 mm
Travetti in legno 120x160 mm
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimento 15 mm
Riscaldamento a pavimento con massetto 65 mm
Strato isolante 4 cm
Sottofondo alleggerito per impianti 10 cm
Guaina impermeabile
Massetto con rete elettrosaldata 10 cm
Vetro cellulare 20 cm
Tessuto non tessuto
Calcestruzzo magro 10 cm
Sezione AA
Sezione BB
Sezione CC
Sezione DD
Sezione EE
C

Ristrutturazione di una villa sul lago di Como
Cernobbio, Como
Villa Perti è posta in posizione dominante sul primo bacino del lago di Como, a circa trecento metri di altitudine dal lago.
La villa è inserita all’interno di un’ampia proprietà organizzata a terrazzamenti su un forte declivio. All’interno della proprietà, oltre alla villa, si trovavano una serie di piccoli edifici con diverse funzioni: a fianco dell’edificio principale una struttura porticata probabilmente usata in origine come limonaia e poi chiusa sui quattro lati, più in basso una serra oggi tamponata e, all’ingresso, un fabbricato che fungeva da deposito e rimessa auto.
Il primo nucleo sembra trovare un riscontro nel Catasto Teresiano del 1720; è ben leggibile planimetricamente nel corpo centrale della casa a cui nel tempo sono stati aggiunti sul perimetro nuovi volumi e il loggiato nella zona sud.
Considerando la particolare evoluzione storica dell’edificio, il progetto di recupero, ha voluto riportare a una logica costruttiva e coerenza distributiva le varie parti succedutesi nel tempo, mantenendo e rafforzando l’immagine della villa.
L’entrata è stata ricavata dalla demolizione della vecchia scala; tale intervento ha generato uno spazio d’ingresso che unisce i due volumi: la vecchia limonaia trasformata in giardino d’inverno con il corpo della villa destinata ad abitazione. Questo spazio filtro è rimarcato dalla presenza di un lucernario che lo caratterizza e differenzia dalle stanze della villa.
Il tetto, realizzato con una struttura in legno e acciaio, presenta un’ampia parte vetrata che porta la luce all’interno dei locali che si affacciano verso il vano scala. Sui fronti sono stati realizzati lievi spostamenti delle bucature al fine di consolidare l’immagine della villa e nello stesso tempo garantire un’illuminazione a norma dei locali interni. L’intero edificio è stato intonacato e tinteggiato con prodotti a base minerale naturale. Il colore di facciata è stato scelto a seguito di analisi degli strati sottostanti alla ricerca del colore originario. Particolare importanza ha all’interno del progetto la sistemazione degli spazi esterni. Il piano di recupero presentato ha previsto la valorizzazione e il disegno delle sistemazioni a verde da parte dello studio Pejrone di Torino.








Casa a patio
Monticelli Terme, Parma
Il progetto di questo edificio residenziale si caratterizza per la presenza di tre patii di dimensioni e funzioni diverse.
Mentre all’esterno il primo patio ha la funzione di separare la parte padronale da quella dei servizi, all’interno gli spazi della casa si dispongono attorno a un patio coperto da un grande lucernario che contribuisce al benessere climatico indoor. Un terzo patio è dedicato esclusivamente alla zona del bagno.
L’articolazione degli spazi è apparentemente semplice, ma la ricerca effettuata sulla disposizione delle aperture ha permesso di definire una moltitudine di rapporti visivi da ogni singolo ambiente della casa verso il grande giardino.
L’idea che ha guidato la distribuzione spaziale è quella di scoprire gli ambienti interni in modo progressivo ruotando attorno al patio centrale, con un chiaro riferimento allo schema tipologico della domus romana.
I fronti si caratterizzano per la presenza alternata di parti piene in muratura nel fronte d’ingresso verso nord e per la grande vetrata ad angolo della zona sud.
La lastra di copertura definisce in modo netto il perimetro esterno dell’edificio e, grazie all’articolazione delle parti murarie verticali, è stato possibile ottenere una serie di differenti aree esterne coperte a servizio dell’abitazione.
La struttura è formata da setti murari e lastra di copertura in cemento armato. I materiali di finitura sono per le pareti interne ed esterne l’intonaco lavato e la pietra, per le pavimentazioni il cemento mentre i controsoffitti interni sono in legno di larice.
Il sistema di riscaldamento e raffrescamento è stato realizzato con impianto radiante a pavimento e ventilazione meccanica controllata. I pannelli fotovoltaici in copertura alimentano le pompe di calore per il condizionamento dell’edificio.






SOLAIO DI COPERTURA
Membrana impermeabile
Isolante Stiferite pendenzato 2% sp. 20 cm
Barriera al vapore
Solaio in calcestruzzo armato 20 cm
Controsoffitto in doghe di pino 21x100x2000 mm
SPORTO DI COPERTURA
Membrana impermeabile
Isolante Stiferite pendenzato 5% sp. 10 cm
Barriera al vapore
Solaio in calcestruzzo armato 20 cm
Isolante Stiferite pendenzato 5% sp. 10 cm
Controsoffitto in doghe di pino termotrattato per esterno 21x100x2000 mm
Canale di scolo acque con doppia membrana impermeabile
Copertina in lamiera di acciaio zincato e preverniciato
Finitura: ciclo Calchera con intonaco lavato sabbia 5 mm per c.a.
SERRAMENTO ESTERNO
Porta scorrevole a due ante
Guide di scorrimento incassate nel pavimento e nel controsoffitto
Telaio in alluminio a taglio termico
Doppio vetro basso emissivo
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimentazione in cemento nuvolato 8 cm con rete
Pannello isolante 4 cm
Massetto alleggerito per impianti 10 cm
Barriera al vapore
Getto in calcestruzzo con rete sopra vespaio 5 cm
Vespaio aerato con casseri isolati in EPS 112 cm
Platea di fondazione in calcestruzzo armato 30 cm
Calcestruzzo magro 10 cm
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
Marciapiede in cemento nuvolato antiscivolo
Massetto in cemento armato 15 cm con rete
Ghiaia sp. minimo 40 cm
Sistema di drenaggio della fondazione


TESSUTI URBANI

Insediamenti residenziali
Langhirano, Parma
Langhirano è un importante centro abitato della provincia di Parma, noto per la produzione tipica del prosciutto. Collocato in posizione geografica invidiabile, alle prime pendici dell’Appennino lungo il torrente Parma, ha avuto un grande sviluppo urbanistico ed economico a partire dagli anni Sessanta del Novecento e, trainato dall’industria agroalimentare, si è trasformato da borgo in piccola cittadina. La riorganizzazione e il conseguente trasferimento delle attività produttive dalle zone centrali dell’abitato a quelle più esterne, ha posto negli anni problemi legati a una riconfigurazione complessiva del tessuto urbano di questo centro. Un esempio è fornito dalla progettazione di tre aree industriali dismesse, di cui due poste in continuità con il centro storico e una all’interno di questo. Nonostante le proprietà e gli operatori economici fossero differenti, la vicinanza delle aree ha incoraggiato un’attenta analisi delle vicende storiche e della struttura morfologica e tipologica dell’abitato e l’individuazione dei principali elementi di permanenza storica a cui relazionarsi.
Questa serie di osservazioni, accompagnate da una particolare conoscenza dei luoghi, hanno permesso di ricucire e mettere in relazione spazi originariamente legati da percorsi, canali, muri, giardini le cui tracce, seppur debolmente presenti, possono ancora essere testimonianza dell’identità del paese di Langhirano. Particolare importanza ha avuto lo studio della disposizione dei volumi in relazione agli spazi aperti, al fine di ottenere, oltre a una loro significativa alternanza e identità, anche una effettiva vivibilità.
Lo sviluppo del progetto edilizio ha riguardato un’area di nuova edificazione e un’altra posta all’interno del centro storico in cui sono stati recuperati i volumi edilizi esistenti e fra questi la struttura di un antico mulino del ‘600.
Lo schema insediativo del nuovo intervento è caratterizzato dalla disposizione semplice dei volumi a formare una corte aperta in continuità con la struttura edilizia del centro storico. Il nuovo complesso edilizio, orientato secondo l’originaria disposizione dei campi e di un canale oggi interrato, si compone tramite volumi separati e collegati dai vani scale, a richiamare l’articolazione tipica delle corti aperte del centro storico. Negli affacci a sud e a est i volumi edilizi sono caratterizzati da spazi/ filtro fra l’interno degli alloggi e l’esterno: si tratta di una serie di balconi con struttura in ferro e legno appesa tramite cavi in acciaio a un grande portale in cemento armato. La struttura muraria dei volumi è realizzata per i primi due piani – destinati ai servizi – in cemento armato, mentre per i tre piani fuori terra – occupati dalle residenze – con blocchi in termolaterizio intonacati. I garage sono completamente interrati e ricoperti da un giardino pensile su quale si affacciano le abitazioni.












Recupero e riqualificazione nel borgo basso di Torrechiara
Torrechiara, Langhirano, Parma
Gli interventi progettuali riguardano la riqualificazione di due aree collocate all’interno del nucleo storico del ‘borgo basso’ di Torrechiara, nato attorno alla piazza e confinante con le aree agricole che tuttora lo circondano. Il nucleo del borgo nasce all’incrocio della strada che collega Parma a Langhirano con il percorso che conduce al Castello e il ‘borgo alto’, costruiti da Pier Maria Rossi nella seconda metà del XV secolo. Nella mappa curata da Smeraldo Smeraldi nella prima metà del XVI secolo e riguardante il territorio lungo il torrente Parma fra Langhirano e la città di Parma, il borgo basso è rappresentato con una sorta di edificio a L porticato verso la piazza.
Lo schema urbano rimarrà inalterato fino a oggi anche se gli edifici hanno subito durante gli anni evidenti modifiche e sopraelevazioni.
Il castello e il borgo alto costruiti da Pier Maria Rossi nella seconda metà del XV secolo, così come la Badia Benedettina sorta nelle vicinanze del paese e prospiciente al torrente Parma, trovano invece conferme iconografiche fin dalla carta del 1460 riguardante il territorio del parmense curata da Alessandro Sanseverini. Il complesso edilizio è formato da un insieme di edifici destinati originariamente a diverse attività, residenziali, agricole e produttive.
L’intervento di recupero ha portato alla definizione di un insieme di residenze e spazi aperti di pertinenza, con un disegno molto semplice e rispettoso della matrice originaria dei volumi e degli allineamenti storici dei percorsi.
A questo scopo sono stati demoliti i volumi incongrui edificati nella seconda metà del 900 a funzione produttiva, restituendo al complesso edilizio una relazione percettiva e funzionale con le aree agricole circostanti. Il progetto prevede la ricostruzione della volumetria demolita con un nuovo edificio a formare una corte-giardino interna all’insediamento.
Gli edifici più antichi, in quanto legati al tessuto storico, risultano ancora avere una funzione testimoniale e contribuiscono con la loro presenza alla definizione di spazi comuni di relazione. I materiali utilizzati nell’intervento di recupero sono quelli tipici della tradizione locale: muri intonacati con aperture regolari e serramenti in legno, solai e coperture con struttura lignea, falde con manto in coppi.















Riqualificazione del borgo alto del castello di Torrechiara
Torrechiara, Parma
L’area e l’edificio oggetto dell’intervento sono collocati nel borgo antico del castello di Torrechiara, all’interno della prima cinta muraria in posizione sopraelevata rispetto alla pianura circostante.
Il borgo, costituito da tre file di fabbricati disposte parallelamente, mantiene lo schema costruttivo originale pur con vari rifacimenti negli edifici.
L’eccezionalità del sito è data, oltre che dalla contiguità con il sistema fortificato del castello risalente nella forma attuale alla seconda metà del XV secolo, dall’intero scenario paesaggistico circostante formato dalle prime pendici appenniniche che delimitano gli spazi della pianura padana.
L’attenta analisi delle vicende storiche del borgo, strettamente correlate con quelle del castello, ha permesso di comprendere l’evoluzione degli spazi aperti di accesso alla fortificazione con la definizione degli spazi pavimentati che dall’ingresso del rivellino si sviluppano all’interno del borgo; il percorso perimetrale originario del castello, intercluso oggi dal muro posto ad ovest, è rimarcato da inserti di verde e alberature. La pavimentazione in acciottolato e la collocazione di spazi verdi con tre nuove alberature rende più chiaro e vivibile questo ambito in precedenza del tutto marginale e informe.
Anche la rampa di accesso al portone d’ingresso del castello è stata ridefinita, uniformandola alla pavimentazione del borgo, con una nuova pendenza più adeguata al suo utilizzo.
Aspetto qualificante del progetto è il recupero di un edificio all’interno del borgo, frutto di vari rifacimenti e sopraelevazioni, evidenti nella tessitura muraria in sasso e mattoni. L’intervento di recupero ha permesso di destinare gli spazi a ufficio informativo allo scopo di fornire un servizio adeguato ai flussi turistici richiamati dal castello di Torrechiara e dall’intera Val Parma, considerata la Food Valley italiana. Al piano terra si è ricavato un locale di accoglienza e informazione oltre ai vari servizi, al piano primo una sala polifunzionale per ospitare piccole mostre, convegni o attività legate alla didattica.
Il collegamento fra i due piani è stato realizzato all’esterno, attraverso una scala metallica collocata dove era possibile utilizzare aperture già esistenti e dove l’impatto visivo verso gli spazi pubblici è ridotto; una pensilina costituita da pannelli in legno rivestiti in acciaio e sorretti da pilastri metallici, anteposta alla facciata d’ingresso dell’edificio, permette di proteggere gli accessi al piano terra e al piano primo senza particolari problemi di sovrapposizione dei percorsi.
Nel percorrere la scala è possibile affacciarsi verso i resti archeologici fra il muro di cinta e l’edificio.

Vasca di raccolta acque in lamiera liscia
COPERTURA PENSILINA
Lamiera aggraffata in rame
Listelli e controlistelli in legno in pendenza di supporto
Guaina impermeabilizzante incollata a freddo
Pannello X-LAM 18 cm, intradosso a vista trattato con impregnante protettivo
Faretto LED ad incasso nel pannello X-LAM
SCALA ESTERNA
Parapetto e cosciale esterno in acciaio verniciato
Rivestimento alzate e pedate in lastre di pietra arenaria 3 cm
Rampa in c.a 16.5 cm
Cappa in calcestruzzo 10 cm
Lamiera grecata 6.5 cm
STRUTTURA VERTICALE
Pilastri tubolari in acciaio Ø 140
SOLAIO ESTERNO PIANO TERRA
Pavimentazione in lastre di pietra arenaria 3 cm
Massetto cementizio 5 cm
Riempimento pendenzato in calcestruzzo alleggerito
Guaina impermeabilizzante su fondazione
Piastra di fondazione in calcestruzzo armato 45 cm
Calcestruzzo magro 10 cm
Canalina interrata per lo scolo
delle acque con caditoia in ghisa
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
Pavimentazione carrabile in ciottoli di fiume in pietra dura collocati di punta, fughe eseguite con pietre posate a coltello
Letto di sabbia e cemento 12 cm









LUOGHI E LAVORO

Edificio multifunzionale
San Michele Tiorre, Felino, Parma
L’area in cui è collocato l’edificio è situata nelle prime pendici dell’Appennino parmense, in un ambito agricolo di valore paesaggistico.
Il progetto assume la condizione del sito per collocare il volume e gli spazi aperti con l’obiettivo di ridurre gli impatti paesaggistici e mantenere la visibilità del il panorama circostante. La costruzione diventa un segno discreto all’interno del contesto paesaggistico e un luogo di osservazione del paesaggio così come è venuto storicamente a formarsi. Con questo obiettivo si è scelto di utilizzare materiali provenienti dalla tradizione locale, come la pietra e il legno che caratterizzano i tamponamenti delle pareti esterne. L’uso del vetro, invece, rimarca l’affaccio verso la grande pianura padana, definendo paesaggisticamente un volume molto semplice che si smaterializza verso la pianura. Il parco che circonda gli edifici aiuta l’integrazione con le aree agricole attraverso alberature autoctone quali querce, frassini, ornielli e aceri campestri che caratterizzano il paesaggio agrario collinare. Oltre a queste è presente una serie di siepi arbustive miste che garantiscono una integrazione ecologica grazie alla diversità vegetazionale.
L’edificio, che riprende planimetricamente la tipologia degli edifici agricoli, ha svolto nel corso del tempo varie funzioni con un alto grado di flessibilità d’uso: deposito, garage, spazio giochi, laboratorio di falegnameria... e oggi è destinato all’attività di ristorazione per agriturismo. Dal punto di vista energetico la grande superficie della copertura è stata interamente utilizzata per la collocazione di un impianto fotovoltaico, integrato da un sistema di accumulo con batterie collocate nell’interrato. L’utilizzo di una pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento rende completamente autosufficiente dal punto di vista energetico non solo questo edificio, ma in parte anche l’adiacente abitazione principale e un’altra in corso di progettazione nelle immediate vicinanze.
Nell’interrato, oltre a un deposito, è stata prevista una vasca di accumulo dell’acqua piovana con una capacità di 400 mc. L’acqua è utilizzata per l’irrigazione della grande superficie a parco attorno all’abitazione principale.
La struttura della costruzione è interamente in cemento armato per le parti interrate, mentre il piano superiore è caratterizzato da una struttura mista in acciaio e pannelli di legno X-lam per le parti verticali e la copertura. Le pareti in legno sono rivestite verso l’esterno da pietra ricostruita o da tavole in larice sovrapposte a un isolamento in lana di roccia. In copertura, isolata con fogli in materiale composito termoriflettente dello spessore di due centimetri, i moduli fotovoltaici sono ancorati tramite graffe a pannelli in lamiera grecata.


SOLAIO DI COPERTURA
Impianto fotovoltaico 50 kW
Elementi di fissaggio pannelli alla lamiera grecata di alluminio 5 cm
Lastra metallica in lamiera di alluminio 0.8 mm
Pannello OSB 2 cm
Isolante sottile termoriflettente 2.4 cm
Orditura doppia, listello e controlistello 4+3 cm
Barriera al vapore
Solaio in X_LAM a vista 20 cm
Profilo HEB200
Rivestimento in legno
Piatto in acciaio verniciato 1 cm
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimentazione in gres 1.5 cm
Massetto per posa pavimenti 6 cm
Sottofondo alleggerito 12 cm
Solaio in calcestruzzo armato 22 cm
Orditura singola con listelli 2 cm
Rivestimento in larice 2.5 cm
Rivestimento in pietra ricostruita
Muro in calcestruzzo armato 30 cm
Portone in legno con telaio metallico, rivestito con tavole verticali in larice
Copertina in alluminio
Piatto in acciaio verniciato 1 cm







Ampliamento cantina vitivinicola
Casatico, Langhirano, Parma
L’azienda Carra di Casatico è situata sulle colline di Langhirano all’interno di un ambito di alto valore paesaggistico caratterizzato dalla presenza del castello di Torrechiara. In questa zona è prescritto l’uso di materiali tradizionali, anche negli interventi di nuova edificazione.
Per rispondere alle norme di tutela paesaggistica e nello stesso tempo rendere funzionale la cantina alle fasi lavorative attuali, il progetto utilizza vari accorgimenti, sia nell’uso dei materiali sia nella definizione dei volumi. In particolare, si è ripreso l’uso del tetto a due falde con copertura in coppi che caratterizza gli edifici agricoli della zona.
La semplicità delle forme in diretta continuità interpretativa con le tipologie del luogo riporta gli ampi spazi lavorativi a una dimensione domestica, evidenziando la conduzione familiare dell’azienda.
La ripetizione e gli intervalli fra i volumi consentono un adeguato e discreto inserimento all’interno del paesaggio al quale ci si rapporta anche all’interno degli spazi lavorativi, tramite ampie vetrate che consentono allo sguardo di spaziare sui vigneti adiacenti.
L’uso dell’acciaio e del legno caratterizza la struttura degli edifici: vengono coperti ampi spazi con una percezione delle componenti sufficientemente leggera.
La struttura del deposito è interamente in legno con l’utilizzo, per le pareti, di pannelli in legno massiccio stratificato, lasciato a vista all’interno come fosse una grande scatola di legno che contiene le cisterne per il vino. All’esterno, la struttura di tamponamento è rivestita con isolante e con una finitura a intonaco colorato che rende morbida la percezione dei volumi. Materiali, colori e spazi pensati per essere parte di un territorio, di una famiglia, di un prodotto.









Edificio commerciale Langhirano, Parma
Il tema dell’edificio commerciale si è caratterizzato nella recente epoca per esempi di scarsa relazione con i luoghi sia urbani sia paesaggistici. Le strutture e le aree circostanti determinano spesso quel fenomeno dei “non luoghi” in cui la percezione complessiva è di una sostanziale estraneità dei contenitori rispetto al contesto. Per superare e dare una risposta a questo problema il tema progettuale è stato affrontato cercando, a livello insediativo, un rapporto con i caratteri originari del contesto, ancora oggi presenti nonostante un’edilizia percettivamente frammentata.
La collocazione dell’edificio segue l’asse est-ovest, perpendicolare alla valle, assunto da buona parte del tessuto edificato circostante, ed è rafforzata dalla presenza di un porticato che si estende come segnale di ingresso al centro abitato, riprendendo idealmente l’allineamento con l’antico Mulino del Piano, collocato lungo la strada Massese a poca distanza. Il porticato permette la definizione del punto di accesso principale, sia pedonale sia carrabile.
La volumetria del fabbricato è piuttosto semplice: un parallelepipedo in cui le pareti perimetrali si modificano per formare la copertura, inclinata come in tutte le costruzioni tradizionali della zona. Il materiale di rivestimento per le pareti e la copertura è il medesimo, una lamiera metallica. La parte basamentale, seminterrata, è invece in cemento armato a vista e ospita il parcheggio aperto verso via Nenni. L’intera struttura sopra il parcheggio è realizzata in legno, con setti e travi in legno lamellare, pareti di controventamento in pannelli di X-lam e solaio di copertura in pannelli prefabbricati a telaio.
La parte che si affaccia verso la strada principale, collegata con il porticato, si caratterizza invece per la trasparenza delle vetrate e dei volumi di ingresso che accolgono e si aprono al visitatore.
L’apparente semplicità dell’interno è il risultato di un’attenta integrazione fra le necessità funzionali, la struttura e le parti impiantistiche, al fine di ottenere all’interno un comfort legato a fattori quali la qualità della luce, dell’aria e della percezione visiva e acustica.
Uno degli aspetti fondamentali è stata la modulazione della luce naturale all’interno della struttura, importante per il benessere di chi lavora o di chi si aggira fra gli scaffali per fare la spesa. Due file di ampi lucernari diffondono dall’alto la luce naturale in tutto lo spazio di vendita. Tutta la copertura, costituita da travi e pannelli in legno, è stata lasciata a vista in modo da rendere accogliente e confortevole la sosta e contribuire anche ad una migliore percezione acustica.



PARETE ESTERNA
Finitura esterna in lamiera aggraffata 0.7mm
Tavolato OSB/3 24 mm
Intercapedine di ventilazione 20/100 mm
Telo antivento
Pannello isolante in lana di roccia 8+8 cm
Pannello in X-LAM 12 cm
Lastra placcata in fibrogesso 12.5 mm
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimentazione in gres 10mm
Massetto armato fibrorinforzato 11 cm
Isolante in XPS 18 cm
Barriera al vapore
Platea in calcestruzzo armato 41 cm
SOLAIO COPERTURA
Membrana impermeabile a base di bitume ibrido HCB e rinforzato con armatura composita di velo di vetro e poliestere impregnata con un coating acrilico ad elevata capacità riflettente
Pannelli multibox sp. minino 28 cm:
Tavolato OSB/3 22mm
Travetti 80x240mm = 80 cm
Intercapedine con isolante in lana di roccia 24 cm
Barriera al vapore
Tavolato OSB/3 22mm
Trave in legno lamellare 220x960 mm
Canaline impianto elettrico e rete dati
Impianto di illiminazione su binari



Edificio agricolo
San Michele Tiorre, Felino, Parma
Tiorre è una frazione del comune di Langhirano nelle colline parmensi. Il nucleo abitato è formato da alcuni edifici rurali utilizzati come abitazioni o come stalle e fienili.
Di particolare interesse è il quadro paesaggistico in cui l’abitato è inserito: disposto su una linea di crinale è un luogo privilegiato di osservazione del paesaggio, oltre che un elemento facilmente riconoscibile nella particolare struttura morfologica delle colline.
Il progetto riguarda una struttura da adibire a ricovero per 60 capi da rimonta collocata, per esigenze di proprietà, in adiacenza alla stalla esistente.
A partire dalle caratteristiche del sito e dalla particolare collocazione del manufatto fra la strada di crinale e la stalla prefabbricata, si è ritenuto opportuno formare un fronte discreto verso la strada per coprire la vista di un prefabbricato esistente e mantenere dalla via la percezione del contesto collinare, accentuando gli aspetti di orizzontalità del nuovo fronte.
Lo schema funzionale della stalla, formato da un corridoio di servizio per i mezzi meccanici e da una zona a fianco per il ricovero degli animali, è evidenziato nel progetto attraverso una diversa altezza: il corridoio di servizio si caratterizza per essere più alto rispetto alle altre zone, diventando anche uno spazio funzionale per il ricambio d’aria e l’illuminazione naturale degli ambienti interni per il benessere degli animali.
Si sono volutamente preferiti l’uso di materiali “commerciali” e poveri, il cui utilizzo garantisse una semplificazione del sistema costruttivo. La struttura portante è in profili metallici con maglia modulare; una parte della copertura è realizzata con pannelli in lamiera e una parte con una struttura lignea a travetti trasversali e tavolato di larice inchiodato. La finitura di entrambe le coperture è in rame, i tamponamenti esterni sono in legno di larice.
L’idea del prospetto orizzontale con il tavolato in legno ha come riferimento una piccola opera di Burri in cui una serie di fiammiferi piatti in legno sono attaccati con il Vinavil su uno sfondo colorato.
La copertura del corridoio sporge di un metro abbondante rispetto alla struttura, non solo per proteggere dalla pioggia e dal sole i pannelli lignei, ma anche per dare un possibile riparo alle rondini.



RIUSI COLLETTIVI

Centro culturale e biblioteca
Langhirano,
Parma
Il complesso dell’ex Macello (1927-1930) si presenta come un luogo rigorosamente recinto, al cui centro è ubicato quello che originariamente era il reparto tecnico dello stabilimento e sul cui fronte principale su strada si situa il volume delle funzioni amministrative. Le regole della simmetria determinano il disegno complessivo dell’impianto, mentre a caratterizzare i volumi e il muro di cinta concorre un apparato decorativo complesso, formato da parti in laterizio a vista che incorniciano le superfici intonacate.
Le attività previste dal progetto di recupero sono quelle relative a un centro culturale con una biblioteca, una fonoteca, una ludoteca, l’archivio storico, gli uffici amministrativi. Nel rapporto fra le nuove attività e il contenitore si è cercato di mantenere una certa discrezione e semplicità nell’uso dei materiali e nella definizione degli spazi interni. Se le parti esterne dell’edificio sono state oggetto di un restauro attento alla conservazione delle caratteristiche esistenti, per gli interni si è scelto di riportare alla luce caratteristiche costruttive dell’edificio che per motivi legati alle attività funzionali erano state nascoste nella realizzazione. La demolizione dei solai, delle tramezze interne e il rifacimento della copertura hanno permesso l’introduzione di zone soppalcate, ma anche la possibilità di avere la percezione di come effettivamente è organizzato questo edificio con i padiglioni distribuiti tangenti a una galleria centrale. Anche le superfici intonacate sono state in gran parte demolite e si è riportata alla vista la muratura in sasso listata in mattoni, tipica tecnica costruttiva della zona, che ora è mostrata come materiale storico.
La biblioteca è situata all’interno di un volume proprio, ed è organizzata su due livelli: al piano terra sono collocate le scaffalature per i libri mentre la sala lettura è disposta nella parte superiore per garantire maggiore intimità e silenzio a chi è intento a leggere.
Il progetto, oltre al restauro delle parti edilizie e al disegno di tutti gli arredi interni e dei serramenti, ha riguardato anche le aree cortilizie, con la realizzazione di un giardino all’italiana e di una recinzione in pannelli metallici che, inglobando il locale degli impianti tecnici, funge da chiusura per un lato dell’area.








Museo del cibo
Langhirano, Parma
L’area del Foro boario, situata fra il centro storico di Langhirano e il torrente Parma, è frutto di un progetto urbanistico dei primi decenni del 1900 con il quale si realizza il muro di difesa spondale e la conseguente regimentazione dell’alveo del torrente Parma, bonificando e urbanizzando una vasta serie di aree tangenti al torrente stesso.
Il progetto del Foro boario è stato realizzato solo in parte: originariamente, infatti, era prevista una grande corte chiusa su quattro lati da due edifici a “C” caratterizzati all’interno da un alto porticato perimetrale.
Di questa corte si realizzò solo un edificio, insieme al grande piazzale verso il macello, con funzione di mercato all’aperto per il bestiame.
La storia del Foro boario è legata ai processi economici del territorio e all’identità stessa del paese di Langhirano, centro di mercato e di lavorazione dei prodotti legati all’agricoltura.
L’atteggiamento che ha guidato la fase di progettazione e conseguente realizzazione del museo è stato innanzitutto quello di una riscoperta dell’edificio esistente e delle sue principali caratteristiche. Per questo, oltre alla demolizione di tutti i tamponamenti che negli anni avevano chiuso le arcate del grande porticato, ci si è limitati a una “ripulitura” delle parti murarie, riportando l’immagine complessiva al suo stato originario. Anche il mantenimento delle capriate lignee della copertura contribuisce oggi a leggere gli aspetti costruttivi dell’edificio.
All’interno di questo volume “riscoperto” si colloca in modo quasi autonomo lo spazio allestitivo del museo, formato da una grande struttura lignea predisposta per poter usufruire in futuro anche di un secondo piano espositivo.
Questo spazio non è altro che la riproposizione dello spazio ottenuto nei salumifici con l’uso delle “scalere” in legno, dove vengono appesi i prosciutti per il periodo della stagionatura.
Fin dall’inizio si voleva ottenere un effetto di radicamento del museo al territorio, attraverso un richiamo alla memoria storica. Il percorso museale ha infatti il compito di illustrare le caratteristiche e la storia della lavorazione del prosciutto, prodotto tipico del paese.
Anche la cura dei particolari e l’uso e l’accostamento di materiali tradizionali rimandano a una sapienza artigianale di cui la lavorazione del prodotto necessita. Il progetto proponeva anche il completamento edilizio di tutta l’area attraverso una nuova costruzione (non realizzata) che ridefiniva perimetralmente una grande corte secondo lo schema del progetto originario mai realizzato.




Recupero delle capriate esistenti attraverso idropulitura e trattamento superficiale con fissativo incolore
COPERTURA
Manto in coppi con onduline sottocoppo
Doppia orditura di listelli in legno 35x40 mm per aerazione
Guaina traspirante
Tavolato in compensato marino 25 mm
Isolamento in pannelli di sughero 4+4 cm
Guaina traspirante
Tavolato in legno 30 mm
Travetti in legno 110x90 mm
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE
Montanti e traversi 16x16 cm
Solaio portante in pannelli multistrato 10 cm
Controsoffitto in pannelli di compensato di betulla
Recupero del paramento murario in sassi attraverso idropulitura e trattamento superficiale con fissativo incolore
Scala con struttura in acciaio e pedata in legno massello
Serramento in acciaio e vetro con profili realizzati su disegno
SOLAIO PIANO TERRA
Soletta in calcestruzzo armato 33 cm
Pannelli isolanti 4 cm
Serpentina per riscaldamento a pavimento affogata in un getto in calcestruzzo armato
Strato di allettamento a base cementizia 4 cm
Pavimentazione in resina 2 cm




COMUNITÀ EDUCAZIONE CULTO

Chiesa e centro parrocchiale
Varedo, Milano
Varedo è un piccolo centro interessato da quel fenomeno di urbanizzazione diffusa che è caratteristica consolidata dell’area milanese e che lega ormai senza soluzione di continuità centri storici, periferie residenziali, aree artigianali e commerciali. In questi spazi dove lo sguardo non riconosce limiti, il progetto si propone di ritrovare una misura e un tempo necessari alla crescita di una comunità.
Il progetto della chiesa, risultato vincitore nel 1990 di un concorso indetto dalla Curia Arcivescovile di Milano, si propone come obiettivo principale la costruzione di un organismo urbano in cui i volumi edilizi e gli spazi aperti, alternandosi, assumano una loro precisa identità e qualità.
‘Camminare lungo bei muri e attraversare bei cortili’: con questo obiettivo i volumi edilizi sono stati collocati verso la strada principale a formare un fronte abbastanza compatto, che lasci ben visibili gli ingressi verso i cortili interni.
Un percorso di attraversamento connette tutti gli spazi esterni e interni e rafforza la percezione di un organismo complesso ma comunque unitario. Il fronte verso i campi da gioco è concepito in modo morbido, e lascia a un basso e lungo pergolato il compito di accogliere chi di là proviene.
L’edificio della chiesa è costruito come un grande recinto murario che contiene al suo interno l’elemento più caratteristico: un velario ligneo sospeso che delimita l’aula e l’assemblea.
Entrando in chiesa, percepiamo immediatamente il senso di raccoglimento; la visione frontale dell’altare segnala il punto di arrivo di un percorso e l’inizio di uno spazio fortemente significativo in cui l’Assemblea e il Presbiterio formano, nella loro configurazione unitaria, il luogo della Mensa Eucaristica. Si voleva ottenere all’interno una ‘tensione tranquilla’, un senso di accoglienza quasi domestica, ma allo stesso tempo non rinunciare a quel senso di mistero che è nella tradizione degli edifici del ‘Sacro’. Importante, per il raggiungimento di questo obiettivo, è stato l’uso della luce, che non è mai spettacolare, ma semplicemente funzionale a far capire le gerarchie delle parti in cui è articolato l’interno.
La luce scandisce poi il tempo della giornata, distribuendosi sulle superfici interne in modo differente a seconda della posizione del sole: è questa una percezione piacevole che accompagna chi è dentro rendendolo partecipe dello scorrere del tempo. Gli spessi muri perimetrali descrivono l’esterno dell’edificio come fortemente radicato al terreno, mentre internamente, grazie al loro spessore e alla collocazione delle aperture, consentono di ottenere il necessario silenzio.
Oltre al progetto architettonico sono stati realizzati su disegno tutti gli arredi interni della chiesa.














Pavimento in pietra
Getto in cls con pannelli radianti
Wallwasher
Lucernario apribile
Controsoffitto in cartongesso
IPE 270
Scossalina metallica
Serramento metallico
HEA 140 Lastre in vetro stratificato
Pannelli in legno di faggio 234x60
Traliccio metallico
Copertura con "monopanel" rovescio a finitura liscia 10 cm
Controsoffitto in legno di faggio 2.5 cm
PARETE ESTERNA
Rivestimento esterno in listelli di cotto
Muratura in "poroton" 25x25x19 cm
Muratura in doppio UNI 25x12x12 cm Finitura interna ad intonaco
PARETE ESTERNA
Profilo 60x30x6 mm zincato e verniciato
Rivestimento in listelli di cotto
Muratura in "poroton" 35x25x19 cm Finitura interna ad intonaco





Chiesa e centro comunitario
Castel di Lama, Ascoli Piceno
L’edificio per il culto è l’ultima parte realizzata del grande centro parrocchiale che comprende, oltre alla chiesa, spazi per l’educazione e l’incontro, attrezzature sportive e ricreative, dando luogo a un sistema urbano di notevole effetto comunitario. Frutto di un concorso nazionale a inviti organizzato dalla C.E.I. per i progetti pilota sull’edilizia di culto nel 2006, il progetto sviluppa l’idea di un radicamento al luogo delle strutture edilizie attraverso la disposizione volumetrica e l’utilizzo di materiali locali, relazionandosi con l’abitato con percorsi pedonali che attraversano lo spazio del sagrato, che si allarga nella vasta piazza giardino.
L’osservazione dei principali elementi del paesaggio ha portato a immaginare, a livello insediativo, una serie di muri immersi nei filari di ulivi. Elemento fondamentale del progetto è il percorso pedonale pubblico che attraversa il nuovo insediamento, separando i volumi della chiesa da quelli delle attività parrocchiali e suggerendo possibili connessioni urbane con le altre aree pubbliche presenti nell’intorno. Il percorso, fiancheggiato da un filare di ulivi, è in continua relazione con i diversi luoghi che caratterizzano l’insediamento: la piazza antistante il sagrato, il portico, i cortili che sono intervallati agli edifici adibiti alle attività parrocchiali. Queste ultime sono articolate all’interno di tre volumi, distinti ma collegati tra di loro da una serie di telai e travi, che caratterizzano e definiscono gli spazi cortilizi, oltre che porsi come filtro verso i volumi della chiesa.
La piazza antistante il sagrato è delimitata, oltre che dalla facciata della chiesa, da un semplice muro nella parte a sud e da un portico chiuso verso la strada principale. Tali limiti permettono di ottenere un senso di raccoglimento dello spazio, una dimensione più consona al vivere collettivo, al ritrovarsi di una comunità.
Il campanile, posto verso la strada principale e il centro abitato, segnala con la sua altezza la posizione del centro parrocchiale al territorio circostante.
L’edificio dedicato al culto si caratterizza all’esterno per la grande facciata in lastre di travertino utilizzate come filtro esterno che lascia trasparire gli spazi interni della chiesa.
L’interno accoglie un grande velario ellittico sospeso, luogo dell’assemblea e spazio della liturgia. I luoghi liturgici, fonte battesimale, ambone, altare, sede, crocefisso e tabernacolo sono disposti lungo un percorso che attraversa longitudinalmente lo spazio presbiteriale per concludersi in un giardino dove è stato collocato un ulivo. La disposizione dell’assemblea interpreta i dettami del Concilio Vaticano II, con la zona presbiteriale circondata dalle sedute dei fedeli a formare la sostanza del farsi “Chiesa”. L’altare e l’ambone sono collocati frontalmente nei due fuochi dell’ellisse per rimarcare la pari dignità della mensa e della parola.










SOLAIO COPERTURA INGRESSO Ghiaia
Doppia guaina armata e telo proteggi guaina
Massetto livellante 5 cm
Isolamento termico in EPS Barriera al vapore
Solaio in latero-cemento 25 cm
Controsoffittatura per alloggiamento impianto di illuminazione con lastre in gessofibra 2 cm
reticolare in acciaio
VETRATA ESTERNA
Serramento facciata continua in alluminio a montanti e traversi
Vetro esterno temperato
Intercapedine con gas argon 90% 16 mm
Vetro interno stratificato basso emissivo

Lastre in travertino accoppiate
Listelli in travertino
PAVIMENTAZIONE SAGRATO
Pavimentazione in lastre di travertino 4 cm
Sottofondo 6 cm
Massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata 10 cm
Ghiaia 20 cm Geotessuto antiradice

Struttura

LUCERNARIO
Serramento facciata continua a montanti e traversi
Vetro esterno temperato
Intercapedine con gas argon 90% 16 mm
Vetro interno stratificato basso emissivo
SOLAIO COPERTURA AULA
Doppia guaina impermeabile armata
Pannello OSB 2 cm
Isolamento in fibra di legno 18 cm
Tavolato ligneo 2 cm
Barriera al vapore
Travetto in legno 8x12 cm
Soglia in travertino 6 cm
PARETE ESTERNA
Intonaco esterno 1.5 cm
Laterizio porizzato 12 cm
Isolante in polistirene estruso 5 cm
Setto in calcestruzzo armato 25 cm
Cassero a perdere in celenit 5 cm
Laterizio porizzato 12 cm
Intonaco Interno 1.5 cm
Serramento in alluminio a taglio termico
Vetro esterno temperato
Intercapedine con gas argon 90% 16 mm
Vetro stratificato interno basso emissivo
Struttura reticolare in acciaio
Controsoffitto con telo termoteso
Telo semifiltrante
Trave in legno fissata alla struttura reticolare in acciaio con staffe metalliche
Struttura reticolare in legno
Profilo in legno verniciato
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimentazione in lastre di travertino 4 cm
Massetto cementizio e tubazioni pavimento radiante 8 cm
Pannelli isolanti in XPS 10 cm
Barriera al vapore
Sottofondo alleggerito 16 cm
Soletta armata in calcestruzzo sopra vespaio 5 cm
Vespaio aerato con casseri a perdere 37 cm
Massetto in calcestruzzo con doppia rete 16 cm





Polo scolastico
Felino, Parma
La nuova scuola primaria di Felino, con annessa mensa e palestra, è la prima parte realizzata di un progetto più vasto che prevede un Polo Scolastico formato da scuola primaria, scuola secondaria, mensa e due palestre.
L’obiettivo alla base del progetto del polo scolastico è stato quello di ottenere spazi didattici fortemente in continuità con i percorsi, le aree verdi e gli spazi pubblici circostanti, così da rendere la scuola una parte fondamentale del paese.
La disposizione delle aree pubbliche nelle previsioni di piano ha consentito di ipotizzare una loro connessione attraverso un percorso ciclopedonale parallelo alla via principale, che partendo dal centro del paese attraversi una zona attrezzata per lo sport e il tempo libero e successivamente l’area del polo scolastico.
La soluzione architettonica, articolata in corpi distinti ma collegati, ha permesso una realizzazione per stralci funzionali.
L’organizzazione dell’edificio scolastico realizzato è caratterizzata dalla presenza di un ampio spazio centrale a doppia altezza, su cui si affacciano i ballatoi di distribuzione del primo piano e collegato anche visivamente alle aree esterne. Questo ampio ‘cortile’ interno è il luogo della relazione fra studenti, insegnanti e genitori, in cui oltre agli intervalli quotidiani si possono svolgere varie attività didattiche e incontri di gruppo. Le aule e gli spazi per le attività speciali e i laboratori si affacciano con ampie vetrate verso le aree a verde e sono dimensionate e arredate per ottenere un senso di familiarità domestica.
Per tutti gli edifici è stato previsto un sistema costruttivo “a secco” con impiego di una struttura portante in pannelli multistrato di legno (X-lam) sia per le pareti che per i solai interpiano e di copertura. Questo sistema permette una prefabbricazione leggera nella quale gli elementi massicci per pareti e solai sono fabbricati singolarmente su progetto e assemblati in cantiere.
Lo spazio centrale a doppia altezza ha invece una struttura portante in ferro con colonne e travi.
Controsoffitti fonoassorbenti in legno all’interno delle aule e microforati nei corridoi, nei laboratori e negli spazi di ricreazione contribuiscono a migliorare il comfort acustico.
Le note di colore introdotte all’interno della scuola seguono abbinamenti per colori complementari, in modo da garantire una naturale armonicità dell’insieme, pensata per accogliere e stimolare percettivamente i bambini che qui trascorrono una lunga parte della loro giornata.










SOLAIO COPERTURA
Ghiaietto 5 cm
Tessuto non tessuto geotessile 400 gr/mq
Doppia guaina impermeabile
Tavolato ESB 15 mm
Freno al vapore
Intercapedine con listelli per ventilazione
Pannelli isolanti in lana di vetro 16 cm
Solaio in X-LAM 20.2 cm
Barriera al vapore guaina liquida
Pannelli tipo celenit 2.5 cm a vista avvitati al solaio
Travetti in legno 5x5 cm i=5 cm verniciati
Ripiano/scrittoio in legno rivestito in laminato
SOLAIO PIANO PRIMO
Pavimento in linoleum 0.5 mm
Massetto cementizio e tubazioni pavimento radiante 6.5 cm
Isolante per pavimento radiante 3 cm
Tappetino fonoisolante 8 mm
Sottofondo alleggerito 10 cm
Tappetino fonoisolante 6 mm
Solaio in X-LAM 20.2 cm
Pannelli tipo celenit 2.5 cm a vista avvitati al solaio
Travetti in legno 5x5 cm i=5 cm verniciati
Lastra in gessofibra 12.5 mm
Pannello in X-LAM 9.5 cm
Isolante in polistirene 12 cm
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimento in linoleum 0.5 mm
Massetto cementizio e tubazioni pavimento radiante 6.5 cm
Barriera al vapore
Pannelli isolanti in XPS 10 cm
Sottofondo alleggerito 11 cm
Soletta armata in calcestruzzo sopra vespaio 5 cm
Vespaio aerato con casseri a perdere 105 cm
Calcestruzzo magro 10 cm
Membrana impermeabile con lamina metallica + guaina impermeabile
Pannello ESB 15 mm
Pannello in X-LAM 10 cm
Frontalino in lamiera di alluminio verniciata
PARETE ESTERNA
Intonaco di finitura esterna 1 cm
Isolante in lana di roccia 10 cm
Pannello in X-LAM 9.5 cm
Isolante in lana di vetro 6 cm
Serramento in alluminio con doppio vetro
PARETE ESTERNA
Intonaco di finitura esterna 1 cm
Isolante in lana di roccia 10 cm
Pannello in X-LAM 9.5 cm
Isolante in polistirene 10 cm
Frangisole a lamelle orientabili in alluminio
Serramento in alluminio con doppio vetro
PAVIMENTAZIONE ESTERNA
Autobloccante in calcestruzzo 6 cm
Sabbia 5 cm
Soletta armata in calcestruzzo con rete 10 cm
Stabilizzato di frantoio 10 cm
Drenaggio in ghiaia compattata sp. minimo 20 cm
Tubo drenante Ø 16 cm

Nuova scuola primaria
Loiano, Bologna
L’area di intervento è ubicata nella parte meridionale di Loiano, località di interesse paesaggistico nell’Appennino bolognese.
L’area è oggi un punto di vista privilegiato di osservazione, affacciandosi a ovest verso valle in un ambito agricolo. Il progetto assume la condizione del sito per collocare i volumi e gli spazi aperti con l’obiettivo di ridurre gli impatti paesaggistici e mantenere un rapporto visivo con il paesaggio e con l’abitato di Loiano, a rimarcare l’appartenenza della scuola a questa comunità e a questo paesaggio.
A questo scopo, il volume a due piani della scuola è stato parzialmente interrato secondo la linea di pendenza del terreno. Si è così ottenuto, verso la strada di accesso, la percezione di un volume basso, limitando l’effetto barriera visiva verso il paesaggio della vallata.
Aspetto fondamentale per l’inserimento nel paesaggio è anche la scelta dei materiali di finitura esterna. Si sono infatti differenziati i due piani dell’edificio rimarcando una parte basamentale, rivestita in pietra ricostruita secondo le caratteristiche locali, e una parte superiore più “leggera”, destinata alle aule, con una finitura a intonaco colorato. In copertura un ‘tetto verde’ a inerbimento estensivo garantisce una percezione dall’alto in continuità con l’ambiente naturale.
L’ampio atrio d’ingresso, il sistema di percorsi di accesso alle aule visivamente collegati con l’esterno e gli spazi attorno ai vani scala diventano luoghi con illuminazione naturale in cui è possibile sostare, parlare, osservare, giocare, esporre, riunirsi... eliminando di fatto gli spazi di mero passaggio in favore di spazi sempre abitabili dalla comunità scolastica.
L’interno si caratterizza per l’utilizzo del legno a vista nei solai, nelle scale, nei serramenti e negli arredi con l’obiettivo di una percezione domestica e accogliente degli spazi scolastici a disposizione dei bambini e del personale scolastico.
L’illuminazione naturale ha una distribuzione uniforme grazie alle ampie aperture lungo tutta la parete esterna.
Le fasi di progettazione e realizzazione dell’edificio sono state accompagnate da un percorso partecipativo che ha visto impegnati, oltre alle componenti scolastiche, anche i genitori e gli abitanti di Loiano.




SOLAIO COPERTURA
Vegetazione
Substrato estensivo
Stuoia filtrante
Vaschette tetto verde 2.5 cm
Tessuto non tessuto
Manto impermeabile poliolefine
Pannello Osb/3-S 2.2 cm
Isolante in lana di roccia 24 cm
Solaio in X-LAM a vista 6 cm
profilo di contenimento in alluminio 2 mm
pannello OSB/3-S 2,2 cm
spessori per pendenza
pannello X-Lam a vista 6 cm
parapetto in vetro
SOLAIO BALCONATA
Pavimento in gres 1 cm
Guaina Impermeabile
Massetto per pendenze 5/8 cm
Isolante in XPS 15 cm
Cordolo in calcestruzzo armato a sostegno del parapetto
Soletta in calcestruzzo armato 20-15 cm
Isolante in XPS 10 cm
Rasatura armata, primer e rivestimento di finitura ad intonaco
serramento in legno e alluminio con doppio vetro
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimento in linoleum a teli 5 mm
Massetto di ripartizione 4 cm
riscaldamento a pavimento 5 cm
Massetto alleggerito 15 cm
Solaio in cls armato 30cm
PARETE ESTERNA
Pietra ricostruita sp. massimo 70 mm
Pannello isolante in lana di roccia 16 cm
Parete in calcestruzzo armato 25 cm
Intercapedine 5 cm isolata con lana di roccia 4 cm
Lastra di finitura in gesso fibrorinforzato 25mm
0 50 100 150 cm
serramento in legno e alluminio con doppio vetro
SOLAIO CONTRO TERRA
Pavimento in linoleum a teli 5 mm
Massetto di ripartizione 4 cm
riscaldamento a pavimento 5 cm
Massetto alleggerito 15 cm
Isolamento con pannelli XPS 10 cm
Platea di fondazione in cls armato 30 cm
Calcestruzzo magro 10 cm
Vespaio in ghiaia
SOLAIO COPERTURA
Vegetazione
Substrato estensivo
Stuoia filtrante
Vaschette tetto verde 2.5 cm
Tessuto non tessuto
Manto impermeabile poliolefine
Pannello Osb/3-S 2.2 cm
Isolante in lana di roccia 24 cm
Solaio in X-LAM a vista 6 cm
SOLAIO CONTRO TERRA
Pavimento in linoleum a teli 5 mm
Massetto di ripartizione 4 cm
riscaldamento a pavimento 5 cm
Massetto alleggerito 15 cm
Isolamento con pannelli XPS 10 cm
Platea di fondazione in cls armato 30 cm
Calcestruzzo magro 10 cm
Vespaio in ghiaia
SCALA
Pavimento in linoleum incollato 5mm
Struttura in calcestruzzo armato
SOLAIO PIANO TERRA
Pavimento in linoleum a teli 5 mm
Massetto di ripartizione 4 cm riscaldamento a pavimento 5 cm
Massetto alleggerito 15 cm
Solaio in cls armato 30cm

SPERIMENTAZIONI INSEDIATIVE



Case a corte
Langhirano, Parma
Il progetto di queste case a corte è il risultato di un’ipotesi, non completamente realizzata, per un piccolo insediamento residenziale nelle colline attorno al centro urbano di Langhirano. Su un terreno in pendenza si era previsto di insediare una serie di blocchi a corte con dei sistemi di attraversamento pedonale che, separati dal traffico veicolare, potessero consentire con continuità l’uso di spazi ricreativi in comune. Gli edifici realizzati mostrano comunque questo principio. I garage e gli spazi di servizio sono stati collocati verso la strada e usati come recinzione, mentre gli alloggi hanno una relazione privilegiata con il giardino interno.
Un percorso pedonale pubblico attraversa il centro della corte, relazionando gli alloggi con l’intorno. La continuità fra le recinzioni e i volumi abitati fornisce un’immagine fortemente compatta accentuata dall’uso del mattone.
Le murature sono state realizzate con il sistema a doppia parete, intercapedine aerata e finitura esterna in laterizio faccia a vista.


Residenze monofamiliari
Langhirano, Parma
L’area del progetto è situata a ovest dell’abitato di Langhirano, un centro nelle prime pendici collinari dell’Appenino parmense.
La zona è oggi caratterizzata dalla presenza di alcuni interventi residenziali a bassa densità edilizia, case mono o bifamiliari e, nella parte a sud, da un quartiere residenziale con edifici di tipo condominiale.
Il progetto concerne una serie di quattro abitazioni disposte su due fronti, per un totale di otto unità abitative. Ogni unità abitativa è articolata attorno a una piccola corte: l’alternarsi di questi spazi vuoti con i volumi edilizi definisce la percezione dei volumi all’interno della strada di lottizzazione. Al piano rialzato di ogni alloggio sono collocate la zona giorno e le camere, mentre al piano interrato trovano spazio un ampio garage, le cantine e le lavanderie. Nella parte a est il prospetto delle partizioni murarie è invece scandito da una serie di piccole logge a servizio delle camere. L’andamento orografico del terreno viene rimarcato dalla collocazione delle parti volumetriche disposte a scalare lungo la pendenza. Le parti murarie esterne degli edifici e delle recinzioni sono in mattoni a vista; le coperture previste nel progetto in rame sono state cambiate in corso d’opera dalla committenza con tegole in cotto. L’altezza dell’insediamento risulta volutamente contenuta, con l’interramento parziale del piano dei servizi.







Residenze con tipologie miste
Collecchio, Parma
L’area dell’intervento si trova a Collecchio, un comune della fascia pedemontana in provincia di Parma. In considerazione delle caratteristiche geografiche dell’area, nonché della sua accessibilità, il progetto urbanistico ha preliminarmente definito il sistema dei percorsi, le aree pubbliche e private e un preciso assetto planivolumetrico dell’insediamento. Nel progetto della viabilità una particolare attenzione è stata prestata alla gerarchia dei percorsi, in modo da garantire una continuità di percorrenza sia per il traffico veicolare che per quello ciclabile e pedonale: una strada principale giunge fino agli edifici in linea, mentre due strade secondarie interne distribuiscono gli edifici monofamiliari.
All’interno dell’area sono infatti riconoscibili tre blocchi di edifici: due destinati alle residenze unifamiliari e uno a residenze condominiali. I tre differenti blocchi sono evidenziati anche dalla disposizione delle alberature sia lungo i confini dell’area di intervento sia lungo le strade di penetrazione del nuovo quartiere, mentre nella fascia di terreno adiacente alla tangenziale è stata prevista una fascia boscata che avrà la doppia funzione di schermare dal traffico veicolare e di costituire un corridoio ecologico utile a flora e fauna selvatiche.



Giardino per l’infanzia
Gaiano,
Collecchio, Parma
Il progetto ha previsto la sistemazione del percorso di attraversamento del piccolo abitato di Gaiano con la costruzione di un semplice marciapiede con rifinitura di graniglie stabilizzate, un piccolo giardino giochi e il collegamento pedonale con il cimitero e nuove aree di sosta.
Il percorso pedonale che proviene dal centro abitato entra all’interno del giardino separandosi nettamente dalla strada carrabile; da questo punto esso modifica la sua conformazione relazionandosi attraverso l’uso dei materiali ad una situazione che può essere definita “ludica campestre”, infatti il piccolo giardino si trova proprio al limite dell’abitato di Gaiano come cerniera verso la campagna circostante.
Il disegno del nuovo spazio verde risponde alla necessità di creare un luogo adatto a più attività (incontro, passeggiate e riposo all’aria aperta, gioco, contemplazione della campagna, osservazione della piccola fauna selvatica e della flora spontanea mentre il tracciato dei sentieri rivela i più semplici collegamenti dell’area con il proprio immediato intorno, in particolare con il viale del cimitero e con la futura area sportiva attrezzata prevista nell’area confinante. Le specie vegetali di cui si è progettata la messa a dimora sono quelle che appartengono alla campagna circostante, per favorire un buon inserimento paesaggistico del giardino ma anche una sua integrazione ecologica; semplici muri concludono il giardino rispetto all’abitato, lo separano e lo relazionano con lo spazio aperto della campagna, o meglio, del mondo naturale della campagna di ieri, fatto di grandi querce, siepi, prati di fiori selvatici... qui è il mutare della forma e della qualità dei muri che racchiudono e intersecano il giardino a realizzare quanto occorre per sedersi, appoggiarsi, giocare, arrampicarsi, saltare, bere... attraverso varchi nei muri – cui fanno da contrappunto moduli più alti – si entra e si esce, costeggiandoli o guardando oltre, si è invitati a osservare il paesaggio esterno e, forse, a vederlo con occhi nuovi rispetto alle abitudini acquisite. Anche la variazione fisica dei materiali della pavimentazione segna i passaggi di chi percorre via della Libertà attraverso l’area verde: soglie di pietra segnano gli ingressi, mentre i sentieri interni sono sottolineati da elementi in laterizio che accompagnano la passeggiata. Lo spazio centrale del giardino, quasi una radura circondata dagli alberi, ospita un muro speciale, quello dedicato al gioco dei bambini. Un luogo cui si è voluto attribuire una fisicità molto spiccata per favorire quelle percezioni e sensazioni corporee così importanti per i bambini, specialmente per quelli più piccoli. Un muro da attraversare per scoprire che il terreno è su livelli diversi lungo i due lati; su cui far rimbalzare una palla; a cui affacciarsi per guardare di là; dietro a cui nascondersi per poi riapparire dall’apertura successiva...




COSTRUZIONI
Piccolo rifugio in Appennino
Tufi d’Agna, Corniglio, Parma
Progetto
2014
Lavori
2014-2015
Tipo di intervento
Ristrutturazione e riuso
Committente
Privato
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Sara Chiari, Matteo Zaccarelli
Strutture
Simone Leoni
Impresa esecutrice
Danilo Barbieri

Ampliamento del camposanto
Castrignano, Langhirano, Parma
Progetto
1989
Lavori
1992-1993
Tipo di intervento
Ampliamento Committente
Comune di Langhirano
Progettazione
Marco Contini
Direzione Lavori
Marco Contini
Collaboratore
Nicola Bonazzi
Strutture
Luciano Rossi
Impresa esecutrice
Monticelli srl

Struttura sportiva polivalente
Parma
Progetto
2003-2005
Lavori
2005-2007
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Comune di Parma
Progettazione
Marco Contini
Direzione Lavori
Marco Contini (prima fase)
Giampaolo Vecchi, Filippo Sodano (seconda fase)
Collaboratori
Elisa Paletti, Sara Chiari, Davide Fasoli
Strutture
Massimo Del Fedele, Giovanni Feldmann
Impianti
Giampaolo Vecchi, Francesca Cavatorta
Consulente per le vetrate
Ing. Fausto Cattivelli
Imprese esecutrici
Moretti Intherolz; Fratelli Sala

Recupero di edifici agricoli
Chiastrone, Langhirano, Parma
Progetto
2010-2011
Lavori
2012-2014
Tipo di intervento
Ristrutturazione e riuso
Committente
Privato
Progettazione
Marco Contini, Sara Chiari
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Elisa Paletti
Strutture
Paolo Bertozzi
Progetto impianti meccanici
Massimo Bocchi
Progetto impianti elettrici
Giampaolo Vecchi
Impresa esecutrice
Impresa edile Piazza Franco
Ristrutturazione di una villa sul Lago di Como
Cernobbio, Como
Progetto
2010-2011
Lavori
2012-2014
Intervento
Restauro
Committente
Privato
Progettazione
Marco Contini, Alessandra Dalloli
Direzione lavori architettonica
Marco Contini, Alessandra Dalloli
Collaboratori
Sara Chiari, Matteo Zaccarelli,
Carine Aussems, Davide Pelizzi
Progetto del giardino
Paolo Pejrone, Frango Brugo
Strutture e direzione lavori
Ferdinando Brambilla
Impianti meccanici
Massimo Bocchi
Impresa esecutrice
Ediltecno Restauri srl


Casa a patio
Monticelli Terme, Parma
Progetto
2018-2019
Lavori
2019-2020
Tipo di intervento
Nuova costruzione
Committente
Privato
Progettazione
Marco Contini, Sara Chiari
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Matteo Zaccarelli
Strutture
Giancarlo De Lisi
Impianti meccanici
Simone Dalmonte
Impianti elettrici
Giampaolo Vecchi
Impresa esecutrice
Buia Nereo srl

Insediamenti residenziali
Langhirano, Parma
Progetto
1997-1999
Lavori
1999-2001
Tipo di intervento
Ristrutturazione e nuova costruzione
Committente
Imprese Piazza Franco, Tosini immobiliare
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Marco Contini (ristrutturazione)
Franco Piazza (nuova costruzione)
Collaboratori
Claudia Guastadini
Strutture
Giovanni Feldmann (ristrutturazione)
Claudio Ferrari (nuova costruzione)
Impianti
CD Studio, Giampaolo Vecchi
Impresa esecutrice
Franco Piazza

Recupero e riqualificazione nel borgo basso di Torrechiara
Torrechiara, Langhirano, Parma
Progetto prima fase
2005-2006 (prima fase)
2017-2019 (seconda fase)
Lavori
2006-2009 (prima fase)
2018-2020 (seconda fase)
Tipo di intervento
Ristrutturazione e riuso Committente
Privato
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Agata Cleri (prima fase)
Simone Rossi (seconda fase)
Collaboratori
Claudia Guastadini, Elisa Paletti,
Sara Chiari
Strutture
Giovanni Feldmann (prima fase)
Simone Leoni (seconda fase)
Impianti
C.D. studio, Giampaolo Vecchi, Giuseppe Burcotti
Imprese esecutrici
Farnese Ristrutturazioni
Riqualificazione del borgo alto del castello di Torrechiara
Torrechiara, Langhirano, Parma
Progetto prima fase
2002-2003
Lavori prima fase 2003-2004
Progetto seconda fase 2020-2021
Lavori seconda fase 2022-2024
Tipo di intervento
Ristrutturazione e riuso Committente
Comune di Langhirano
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Alessio Pedrona, Matteo Zaccarelli
Consulenti
Luciano Serchia (analisi storica)
Strutture
Giovanni Feldmann (prima fase), Schrentewein & Partner (seconda fase)
Impianti
C.D. Studio
Impresa esecutrice
Impresa di Costruzioni MC srl


Edificio multifunzionale
San Michele Tiorre, Felino, Parma
Progetto
2013
Lavori
2013-2014
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Privato
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Elisa Paletti, Matteo Mascia, Matteo Zaccarelli
Strutture
Marco Pedrini
Imprese esecutrici
Boraschi; Cirigliano

Ampliamento cantina vitivinicola
Casatico, Langhirano, Parma
Progetto
2007
Lavori
2008-2010
Tipo di intervento
Ampliamento e ristrutturazione Committente
Azienda agricola Carra
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Elisa Paletti, Franco Premi
Strutture
Schrentewein & Partner
Impresa esecutrice
F.lli Manara spa

Edificio commerciale
Langhirano, Parma
Progetto
2016
Lavori
2017-2018
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Coop Alleanza 3.0
Progettazione
Marco Contini, Andrea Albertini (CCDP)
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Matteo Zaccarelli
Strutture e impianti
CCDP, IRES
Strutture in legno
Schrentewein and Partner srl
Imprese esecutrici
Cooperativa Bruno Buozzi, Sicrea, Uni-Edil, Di Centa e Di Ronco, Torregiani & C.

Costruzione agricola
Tiorre, Langhirano, Parma
Progetto
1998
Lavori
1999
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Azienda agricola Sillari
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Marco Contini
Strutture
Giovanni Feldmann

Centro culturale e biblioteca
Langhirano, Parma
Progetto
1993-1995
Lavori
1995-1998
Tipo di intervento
Ristrutturazione e riuso Committente
Comune di Langhirano
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Nicola Bonazzi, Paolo Contini, Agata Cleri (verde)
Strutture
Giovanni Feldmann
Impianti
CD Studio, Giampaolo Vecchi
Imprese esecutrici
Soncini srl; Impresa Allodi

Museo del cibo
Langhirano, Parma
Progetto
2003-2004
Lavori
2005-2006
Tipo di intervento
Ristrutturazione e riuso Committente
Comune di Langhirano / Comitato Musei del cibo
Progettazione
Marco Contini
Progetto allestitivo
Marco Contini, Sara Chiari
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Elisa Paletti, Nicola Bonazzi
Strutture
Claudio Ferrari
Impianti
C.D. studio; Giampaolo Vecchi
Curatore del museo
Mario Zannoni
Impresa esecutrice
Buia Nereo srl

Chiesa e centro parrocchiale
Varedo, Milano
Concorso
1990
Progetto
1995-1996
Lavori
1996-1999
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Curia Arcivescovile di Milano
Progettazione
Marco Contini, Claudio Bernardi, Raffaele Ghillani
Chiesa e centro comunitario
Castel di Lama, Ascoli Piceno
Concorso
2026
Progetto
2007-2010
Lavori
2008-2019
Tipo Intervento
Nuova costruzione Committente
Diocesi di Ascoli Piceno
Progettazione e direzione lavori
Marco Contini
Strutture e impianti
Studio Di Emidio
Polo scolastico
Felino, Parma
Concorso
2005
Progetto
2005-2008
Lavori
2009-2012
Tipo Intervento
Nuova costruzione Committente
Comune di Felino
Progettazione
Marco Contini, Sara Chiari
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Claudia Guastadini, Andrea Zerbi, Agata Cleri (verde)
Strutture
Sandro Nalin, Maurizio Ghillani
Impresa esecutrice
Minotti
Collaboratori
Alessio Brugnoli, Giambattista Premi, William Pierantozzi, Matteo Mascia, Matteo Zaccarelli
Opere artistiche
Giuliano Giuliani
Aspetti liturgici
Don Mario Cataldi
Impresa esecutrice
Gabriele Gaspari; Enzo Reschini
Facciata e serramenti
Enzo Reschini


Direzione lavori
Marco Contini, Sara Chiari
Strutture
Schrentewein & Partner
Impianti
Massimo Bocchi, Giampaolo Vecchi
Impresa esecutrice
A.T.I. Coverall srl; Satrini Elvi

Nuova scuola primaria
Loiano, Bologna
Progetto
2015-2016
Lavori
2016-2017
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Impresa Ferruccio Maestrami / Comune di Loiano
Progettazione
Marco Contini, Sara Chiari
Direzione lavori
Marco Contini, Sara Chiari
Strutture
Schrentewein & Partner
Impianti meccanici
Simone Dalmonte
Impianti elettrici
Giampaolo Vecchi
Impresa esecutrice
Ferruccio Maestrami

Case a corte
Langhirano, Parma
Progetto
1992
Lavori
1993
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Impresa Bergamaschi srl
Progettazione
Marco Contini
Collaboratori
Nicola Bonazzi
Strutture
Giovanni Feldmann
Impresa esecutrice
Bergamaschi srl

Residenze monofamiliari
Langhirano, Parma
Progetto
2001-2003
Lavori
2003-2005
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
ImpresaBosi srl
Progettazione
Marco Contini
Collaboratori
Elisa Paletti
Impresa esecutrice
Bosi srl

Residenze con tipologie miste
Collecchio, Parma
Progetto
2001-2005
Lavori
2006-2012
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Impresa Costruzioni S.C.S. srl
Progettazione
Marco Contini, Eugenio Ceci
Collaboratori
Sara Chiari, Elisa Paletti
Strutture
Eugenio Ceci
Impresa esecutrice
Costruzioni S.C.S. srl

Giardino per l’infanzia
Gaiano, Collecchio, Parma
Progetto
1997
Lavori
1998
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Comune di Collecchio
Progettazione
Marco Contini
Direzione lavori
Marco Contini
Collaboratori
Giampaolo Contini, Claudia Guastadini, Gianluca Pasquali
Essenze arboree
Agata Cleri
Impianti
Giampaolo Vecchi
Impresa esecutrice
Costruzioni Coruzzi srl

IN CORSO
Polo scolastico
Rovereto sulla Secchia, Novi di Modena, Modena
Concorso 2016
Progetto 2019-2020
Lavori
In costruzione
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Comune di Novi di Modena
Progettazione
Marco Contini, Quattroassociati
Collaboratori
Sara Chiari, Matteo Zaccarelli, Alessio Pedrona
Strutture
Schrentewein & Partner
Impianti meccanici
Simone Dalmonte
Impianti elettrici
Giampaolo Vecchi
Direzione lavori
Marco Contini con Alessio Pedrona

Scuola secondaria e palestra
Mori, Trento
Concorso 2019
Progetto 2019-2023
Lavori
In appalto Tipo di intervento
Nuova costruzione e ristrutturazione Committente
Provincia Autonoma di Trento Progettazione
Marco Contini con Sara Chiari
Collaboratori
Matteo Mascia, Matteo Zaccarelli, Alessio Pedrona
Strutture
Schrentewein & Partner
Impianti
STEA Progetto

Scuola secondaria e palestra
Bologna
Gara 2020
Progetto 2020-2021
Lavori
In costruzione
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Città Metropolitana di Bologna Progettazione
Marco Contini, Sara Chiari
Collaboratori
Alessio Pedrona, Matteo Zaccarelli, Paolo Ferioli
Strutture
Schrentewein & Partner
Impianti meccanici
Simone Dalmonte
Impianti elettrici
Giampaolo Vecchi
Acustica
Morlini Engineering
Direzione lavori
Marco Contini

Centro culturale “la casa Francigena”
Berceto, Parma
Bando
Bando Rigenerazione Urbana 2021
Progetto 2021-2023
Lavori
In costruzione
Tipo di intervento
Nuova costruzione e ristrutturazione Committente
Comune di Berceto
Progettazione
Marco Contini con Sara Chiari
Campus scolastico
Sorbolo, Parma
Gara 2020
Progetto
2022-in corso
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Comune di Sorbolo Mezzani
Progettazione
Marco Contini, Quattroassociati, Policreo Collaboratori
Sara Chiari, Gianmarco Cotti, Alessio Pedrona, Matteo Zaccarelli
Scuola primaria
Ghedi, Brescia
Gara 2022
Progetto 2022-2023
Lavori
In costruzione
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Comune di Ghedi
Progettazione
Marco Contini, Joseph di Pasquale Collaboratori
Sara Chiari, Matteo Zaccarelli,
Collaboratori
Matteo Zaccarelli, Alessio Pedrona
Strutture
Schrentewein & Partner
Impianti meccanici
Simone Dalmonte
Impianti elettrici
Giampaolo Vecchi
Acustica
Morlini Engineering
Direzione lavori
Marco Contini con Alessio Pedrona

Strutture
Schrentewein & Partner
Impianti meccanici
Simone Dalmonte
Impianti elettrici
Giampaolo Vecchi
Acustica
Morlini Engineering

Diana Ranghetti, Alessio Pedrona, Gianmarco Cotti, Paola Sacchi
Strutture
Schrentewein & Partner, E.T.S Spa
Impianti meccanici
Guido Facchinetti
Impianti elettrici
E.T.S Spa
Verde e paesaggio
P’arcnouveau
Direzione lavori
ETS

Polo dell’infanzia
Berceto, Parma
Progetto 2023
Lavori
In costruzione
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Comune di Berceto
Progettazione integrata
Continiarchitettura:
Marco Contini, Sara Chiari,
Alessio Pedrona, Schrentewein & Partner, Simone Dalmonte, Giampaolo Vecchi
Collaboratori
Gianmarco Cotti, Matteo Zaccarelli
Verde e idraulica
Zanzucchi Associati
Acustica
Morlini Engineering
Direzione lavori
Marco Contini con Alessio Pedrona

Nido d’infanzia e centro bambini e famiglie
Sorbolo, Parma
Progetto 2023
Lavori
In costruzione
Tipo di intervento
Nuova costruzione Committente
Comune di Sorbolo Mezzani
Progettazione integrata
Continiarchitettura:
Marco Contini, Sara Chiari, Alessio Pedrona, Schrentewein & Partner, Simone Dalmonte, Giampaolo Vecchi
Nido d’infanzia
Nonantola, Modena
Progetto 2023
Tipo di intervento
Nuova costruzione
Committente
Comune di Nonantola
Progettazione
Continiarchitettura
Marco Contini, Sara Chiari, Alessio Pedrona, Schrentewein & Partner, Simone Dalmonte, Giampaolo Vecchi
Collaboratori
Gianmarco Cotti, Matteo Zaccarelli
Collaboratori
Gianmarco Cotti, Matteo Zaccarelli, Alessio Pedrona
Verde e idraulica
Zanzucchi Associati
Acustica
Morlini Engineering
Direzione lavori
Marco Contini con Gianmarco Cotti


Riqualificazione dell’area archeologica del castello
Berceto, Parma
Progetto 2025 Lavori
In appalto
Tipo di intervento
Restauro e riqualificazione dei percorsi di visita
Committente
Comune di Berceto
Progettazione integrata
Continiarchitettura:
Marco Contini, Sara Chiari, Alessio Pedrona, Schrentewein & Partner, Simone Dalmonte, Giampaolo Vecchi
Istituto tecnico e palestra
Sant’Ilario di Rovereto, Trento
Gara 2023
Progetto 2025-in corso
Tipo di intervento
Nuova costruzione e ristrutturazione Committente
Provincia Autonoma di Trento
Progettazione
Continiarchitettura, JDP Architects
Collaboratori
Gianmarco Cotti
Consulenti
Luciano Serchia (analisi storica)
Cristina Anghinetti (archeologia)


Restauro e rifunzionalizzazione palazzo Sacconi
Fermo, Trento
Gara 2022
Progetto
2025-in corso
Tipo di intervento
Consolidamento e restauro Committente
Comune di Fermo
Progettazione
Marco Contini, Sara Chiari
Strutture e impianti
RPA

Crediti fotografici
Davide Galli
Piccolo rifugio in Appennino: pp. 9, 24, 26, 27, 28, 29, 178
Ristrutturazione di una villa sul lago di Como: pp. 52, 54, 56, 57, 179
Casa a patio: pp. 12, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 179
Recupero e riqualificazione nel borgo basso di Torrechiara: pp. 74, 76, 78-79, 180
Riqualificazione del borgo alto del castello di Torrechiara: pp. 80, 82, 83, 85, 86, 87, 180
Chiesa e centro parrocchiale: pp. 17, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 183
Chiesa e centro comunitario: pp. 17, 138, 140, 141, 143, 145, 183
Polo scolastico: pp. 148, 183
Nuova scuola primaria: pp. 154, 156, 157, 158, 161, 184
Paola De Pietri
Struttura sportiva polivalente: pp. 13, 36, 38, 41, 178
Recupero di edifici agricoli: pp. 11, 44, 46, 47, 48, 49, 179
Insediamenti residenziali: pp. 14, 68, 70, 71, 72, 73, 180
Edificio multifunzionale: pp. 6, 13, 90, 92, 95, 96, 97, 181
Ampliamento cantina vitivinicola: pp. 98, 100, 101, 181
Museo del cibo: pp. 120, 122, 123, 124-125, 127, 182
Polo scolastico: pp. 146, 150-151
Stefano Botti
Ampliamento del camposanto: pp. 30, 32, 33, 34, 35, 178
Costruzione agricola: pp. 108, 110, 111, 182
Centro culturale e biblioteca: pp. 114, 116, 118, 119, 182
Stefano Vaia
Polo scolastico: pp. 152
Bruno Cattani
Edificio commerciale: pp. 102, 104, 105, 107, 181
Marco Contini
Case a corte: pp. 164, 165, 184
Residenze monofamiliari: pp. 166, 184
Residenze con tipologie miste: pp. 14, 168, 169, 185
Giardino per l’infanzia: pp. 18, 170, 172, 174-175, 185
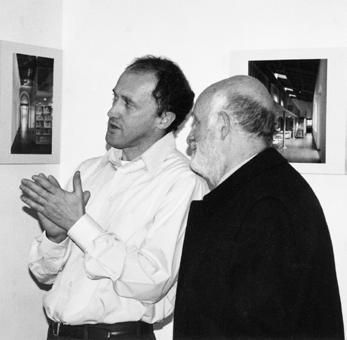
Marco Contini
Laureato alla facoltà di Architettura di Venezia ha successivamente collaborato presso gli studi di Vittorio Gregotti a Milano e Guido Canali a Parma.
Ha svolto per diversi anni attività di docenza presso le Facoltà di Architettura delle Università di Ferrara, Parma, Alghero e al Politecnico di Milano.
Come progettista e direttore dei lavori ha realizzato residenze, scuole, musei, edifici religiosi, edifici sportivi, recuperi di edifici storici, con una particolare attenzione agli aspetti realizzativi, alle modalità di intervento rispetto alle preesistenze e alle esigenze dei committenti.
Nel 2023 ha fondato continiarchitettura una società tra architetti e ingegneri che si occupa di progettazione con uno sguardo multidisciplinare e una effettiva integrazione fra architettura, strutture, impianti.
Vive e lavora a Torrechiara, un piccolo centro dell’Appennino parmense.
Premio IN-ARCH regione Marche “rigenerazione urbana” 2020
Premio Sostenibilità edifici non residenziali Agenzia per lo sviluppo sostenibile
Modena 2019
Premio Sostenibilità Ambientale e Sociale ANCI Efficienza energetica e innovazione in edilizia 2012
Medaglia d’oro all’architettura italiana menzioni d’onore nelle sezioni edifici produttivi e residenziale 2003
Premio “Rizzardi Polini” Architettura Accademia nazionale di Belle Arti di Parma
Premio Zaffagnini Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara
Marco Contini con l’architetto Vittorio Gregotti

Giovanni Vragnaz
Giovanni Vragnaz, architetto, friulano. Laureato con Vittorio Gregotti, con lo stesso ha lavorato, dal 1984 al 1989, come redattore della rivista “Rassegna - problemi di architettura dell’ambiente” curando alcuni numeri monografici. Ha collaborato con Leonardo Benevolo e Gino Valle.
Autore di saggi, recensioni, articoli e progetti apparsi su riviste italiane e straniere (Casabella, Domus, Abitare, AB, Progex, Archimade, Piranesi, Architetti Regione, d’Architettura, Giornale d’Architettura, Parametro), ha curato volumi per Einaudi ed Electa. Dalla fondazione è membro della redazione della rivista internazionale “PIRANESI. Rivista d’architettura della Mitteleuropa” Lubiana (SLO).
Presente nella sezione Italiana della VI Biennale internazionale di Architettura di Venezia del 1996.
Ha insegnato, dal 2003, prima al Corso di Laurea in Architettura a Trieste, poi all’IUAV di Venezia e ora insegna nel corso di Laurea in Architettura della Facoltà di Ingegneria di Udine.
Un suo lavoro è stato recentemente iscritto dal Ministero della Cultura nel Censimento delle Architetture italiane dal 1945 ad oggi.
“Molti anni fa avevo intitolato un breve testo su Contini “La provocazione della semplicità”, ricordando il paradosso dell’accostamento, non essendoci architettura meno “provocatoria” di quella di Marco. Prevale in essa, invece, il senso della misura, cioè il suo “essere misurata” in senso materiale, metrico, dimensionale di controllo percettivo ma anche – e soprattutto – in senso etico.”
Giovanni Vragnaz
ISBN 979-12-81229-22-8
